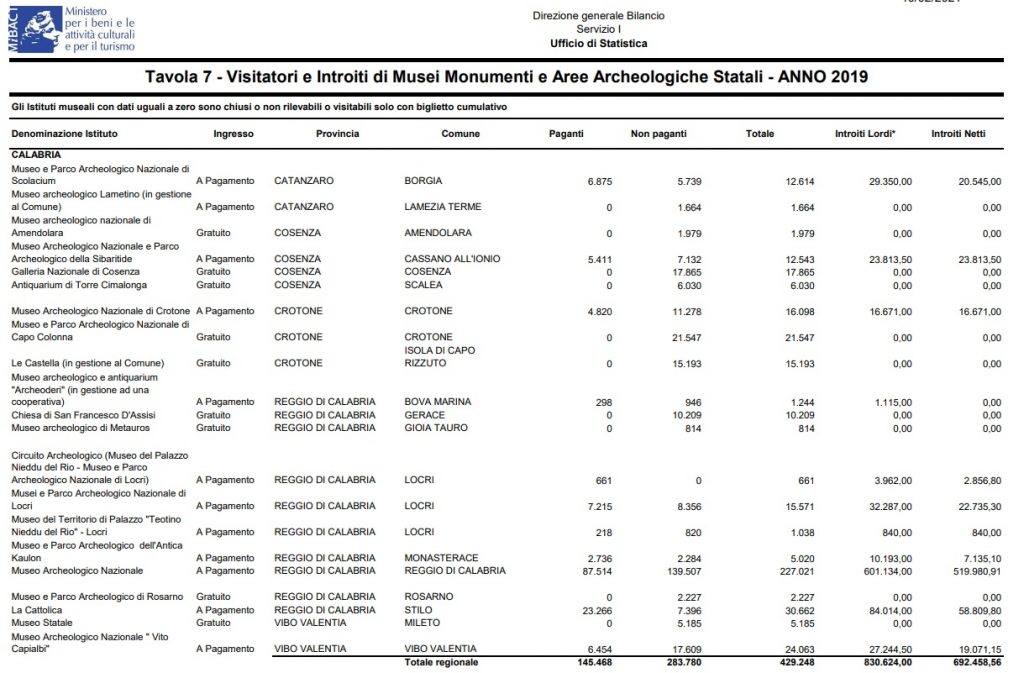Il tentativo dell’amministrazione Occhiuto di trasformare Alarico in un brand e di dedicargli un museo virtuale non ha funzionato, come ribadiscono anche alcune disavventure amministrative non proprio leggere. L’attuale sindaco Franz Caruso, ha dichiarato di preferire Telesio al re barbaro, mettendo probabilmente una pietra tombale su tutta la vicenda.
In Alarico la storia universale si mescola a quella locale, com’è avvenuto a Cosenza, dove il re goto sarebbe morto di malaria e quindi, sarebbe stato sepolto nel letto del fiume Busento, deviato per l’occasione, come tramanda la bella poesia di August von Platen.
Ma il dibattito, anche acceso, esploso sui social prova anche che Alarico continua a “fare immaginario”. Abbiamo chiesto al famoso storico del Medioevo, Franco Cardini, cosa ne pensa della questione Alarico.
Quanto c’è di vero o di verosimile in questa leggenda?
«Quanto ci sia di vero non è mai stato accertato. La verosimiglianza è valutabile in relazione a usanze funebri variamente attestate in ambito tanto celtogermanico quanto uraloaltaico (specie le sepolture equestri)».
Assieme ad Alarico e al suo cavallo sarebbe stato seppellito il tesoro razziato dai visigoti a Roma. Esiste davvero questo tesoro?
«Sepolture principesche caratterizzate da ricchi e preziosi corredi sono attestate. Per quanto Alarico fosse cristiano ariano, è probabile che, dato il suo rango principesco, le antiche tradizioni folkloriche gote fossero in qualche modo rispettate. Quella del “tesoro” razziato a Roma e sepolto nell’alveo del Busento sembra avere tutti i caratteri della leggenda folklorica».
A Cosenza si è tentato di trasformare Alarico in un brand e di dedicargli, addirittura, un museo virtuale. Queste operazioni “simboliche” possono avere un senso? E, se sì, quale?
«Credo che, più che “simbolica”, l’iniziativa in questione dipenda in parte dalla prospettiva di costruirvi sopra un business e in parte dalla speranza che tutto ciò costituisca uno scoop. Ora, business e scoop hanno senza dubbio entrambi un senso e uno scopo nella società attuale. In questo caso, tuttavia, parliamo di un problema “simbolico”: simbolico di che? Simbolico a che scopo? L’Alarico-“barbaro” e l’Alarico-“eroe” sono entrambe dimensioni scarsamente spendibili oggi a livello mediatico, a meno d’introdurvi al riguardo criteri di “radicamento” e di “identità” oppure, al contrario, di cancel culture, che mi parrebbero entrambi sciocchi e inopportuni».

Veniamo al punto centrale: barbaro distruttore per molti, figura eroica per altri. A quale di questi schemi corrisponde Alarico?
«Si tratta, appunto, di schemi valutativi: per giunta di carattere etico-retorico, soggetti ai cambiamenti di interpretazione delle vicende storiche e alle corrispondenti tavole di valori».
Non parliamo di un problema storico, insomma. Il sacco visigotico dell’Urbe fu un evento traumatico, considerato da tanti come il colpo letale all’impero e alla civiltà romane. Tuttavia, Alarico è considerato quasi un papà della patria da tedeschi e spagnoli. Come mai questa ambivalenza?
«Anche la valutazione da dare dell’evento del 410 deve essere spogliata da qualunque valore retorico o simbologico se si vuol darne una lettura storica. In realtà, ai primi del V secolo Roma aveva largamente perduto il suo carattere di centro politico e militare, mentre anche sul piano religioso il suo vescovo non aveva ancora la funzione che avrebbe avuto più tardi. Peraltro quella di Alarico fu più un’occupazione transitoria che un vero e proprio sistematico saccheggio (ben più grave sarebbe stato l’evento del 1527). La “paternità patria” di Alarico per tedeschi e spagnoli, a sua volta molto relativa, riguarda i secoli XVIII-XIX, quando questi valori venivano più densamente espressi».
Sempre a proposito di mito: i nazisti subirono la fascinazione di Alarico. Al punto che Himmler inviò degli agenti in Calabria per trovare le tracce della leggenda.
«Tutto va naturalmente riferito alla mitologia politica filobarbarica e postromantica che alcuni ambienti del governo e delle organizzazioni culturali nazionalsocialiste favorivano, con una buona dose di medievalismo wagneriano. Come in altri casi (l’interesse per il buddhismo-induismo che condusse a spedizioni antropologiche tra India e Himalaya, e quello per il catarismo, che comportò indagini nell’area pirenaica di Montségur), l’interesse nazista per il germanesimo – e quindi la rivendicazione di tutto quel che apparisse “germanico” – non condusse a esiti specifici sotto il profilo scientifico: nulla di paragonabile, ad esempio, rispetto al rapporto tra fascismo e romanità in tutti i loro aspetti. Tuttavia, nell’àmbito dell’organizzazione di ricerche archeologico-antropologiche della società Ahnenerbe (“Eredità degli avi”), sostenuta con forza dagli alti comandi delle SS, alcuni studi furono seri e interessanti: basti al riguardo il nome del grande Franz Altheim, che vi collaborò».

Il tardo antico è un periodo storico suggestivo, carico di contraddizioni, come tutte le fasi di passaggio. È possibile esprimere un giudizio equilibrato sui capi barbari, più o meno romanizzati, che ne furono protagonisti?
«Tutte le fasi storiche sono, per un verso, “di passaggio”; e, per un altro, sono “convenzionali”, appartengono cioè più ai dibattiti storiografici che non alle realtà storiche effettive. I “capi barbari” in contatto con l’impero romano vanno pertanto considerati anzitutto appunto nel loro rapporto con una realtà dinamica caratterizzata però da grande flessibilità (basta pensare all’intelligenza, all’apertura e alla sensibilità con la quale l’impero guardava ai culti religiosi: se e quando in tale àmbito vi furono scontri, ciò va fatto risalire al rigore inflessibile di alcuni di quei culti, non all’incomprensione o al fanatismo romani che in genere non c’erano).
I capi barbari in contatto con l’impero furono molto spesso personaggi eccezionali, di grande intelligenza, in grado di mantenere la loro identità e di adattarla alle esigenze di un dialogo portatore di nuove sintesi. Casi come quelli di Ezio, di Stilicone, di Ataulfo, di Odoacre, di Teodorico, di Clodoveo, di Rotari, di Liutprando, sono per intelligenza, per lungimiranza, per cultura, la regola anziché l’eccezione. All’estremità di questo percorso c’è Carlomagno».
Dovrebbe essere sfatata l’idea dei barbari come “distruttori”?
«Dovrebbe senza dubbio: se tale idea esistesse o fosse mai esistita sul serio. In realtà, la “tesi” incolta e patriottarda dei “barbari germanici” quali distruttori dell’impero (che non a caso fa il paio con l’altra altrettanto ridicola e assurda, quella anticlericale del cristianesimo e dei cristiani come causa della decadenza e della caduta dell’impero romano) non è mai stata sostenuta sul serio da nessuno studioso valido, a parte qualche boutade spinta da esponenti dell’illuminismo più screditato e scadente: appartiene al sottobosco delle idee veicolate da dilettanti semicolti nell’ambito di una sottocultura-pseudocultura che è dura a morire proprio perché è troppo labile per uscire allo scoperto e confrontarsi in modo qualificato con la critica scientifica seria».

Perciò, non avendo mai prodotto nulla di serio e d’interessante, questa pseudocultura non è mai stata neppure degnata di una confutazione approfondita e sistematica. Ma, dal momento che non ha mai influito su nulla di scientificamente apprezzabile, riemerge di continuo a livelli di sostanziale ignoranza. Purtroppo la frana progressiva – e quindi la caduta a picco del tono culturale medio della società occidentale in genere, italiana in particolare, tipico degli ultimi decenni – ha finito col fornire un’autorevolezza specie mediatica del tutto fittizia e gratuita a solenni sciocchezze o addirittura a ridicole idiozie che hanno purtroppo libertà di diffondersi liberamente nei vari canali dei social. La falsa cultura acriticamente presa sul serio è una delle funzioni principali dell’analfabetizzazione della società in corso».