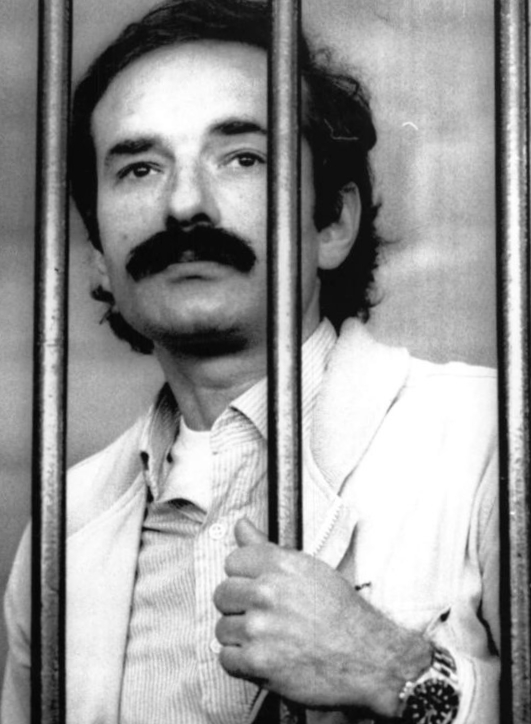[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
A Buonvicino si arriva in 15 minuti da Diamante. Basta volersi fare questa cortesia e sopportare qualche curva. Quella per arrivarci non è una “strada perduta” ma è una strada che, per chissà quale ragione, ancora troppi si ostinano a non percorrere. Eppure Buonvicino ha ottime carte da giocare e basterebbe farsi guidare da appetiti – è il caso di dire – molto ruspanti, senza arzigogolare troppo di fantasia. Perché c’è poco da girarci intorno: a Buonvicino tanto per cominciare si mangia in maniera straordinaria. E questo è un primo dato di fatto inconfutabile.
Qui si mangia e si beve bene
Se c’è una cosa per cui i turisti ricordano la Calabria con ammirazione stupita, questa è solitamente la quantità di portate che si nascondono dietro la vaga dicitura di “antipasto misto della casa”. Bene: a Buonvicino, generalmente, dovete moltiplicare per 2 la quantità già ipertrofica e almeno per 5 la qualità rispetto alla media regionale (e giuro di non essere al soldo della pro-loco locale).
Non è finita qui: i vini locali hanno sapore, corpo e gradazione che francamente non ho mai trovato altrove (gusti personali, ovviamente ma c’è anche una ragione storica di cui parlerò un’altra volta). I ristoranti disseminati lungo i tornanti che portano al paese possono provarlo con fierezza (e qui mi taccio), qualora a provarlo non bastasse la toponomastica con le contrade Vignali, Ficobianco e Puma: tutto intorno al “food”, insomma. Ma mica da ora…

Il duca Cavalcanti con la passione per la cucina
Il caso – anzi – la storia vuole che, ad un certo punto, a fregiarsi del titolo di duca di Buonvicino fosse quell’Ippolito Cavalcanti che nel 1837 fu anzitutto autore di quel libro – la Cucina teorico-pratica – che fu il più celebre ricettario d’Italia per almeno 54 anni (nonché il primo a menzionare la ricetta della pasta al pomodoro), ovvero quando fu soppiantato dall’ormai più inclusivo e ‘unitario’ Pellegrino Artusi (col fin troppo popolare La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene).
Ora, parliamoci chiaro, il ‘buonvicinato’ c’entra poco, in quanto Ippolito era tutto campano: di madre, di nascita, formazione e decesso (e lo stesso libro è scritto in due lingue: napoletano e italiano). Vero, al suo bisnonno Lucio era stato conferito da Carlo VI il titolo di primo duca di Buonvicino già nel 1720, e l’omonimo nonno di quest’ultimo ne era già barone ancora prima, ma va anche considerato il fatto che, lasciata la Toscana, i Cavalcanti tra Napoli e la Calabria proliferarono enormemente, ed è quindi difficile stabilire quanto davvero Ippolito abbia solcato i vicoli di Buonvicino.
I vicoli forse no. I campi e i vigneti forse di più, perché una cosa certa c’è: ai Cavalcanti appartenne il gattopardesco Casino di Contrada Lago, oggi abbandonato dopo un primo tentativo di ristrutturazione e ampliamento da parte di privati. L’imponente portale, sempre chiuso, cela dietro al suo muro di cinta semicircolare diversi corpi di fabbrica, tra cui una cappella intitolata a San Giacomo, che certamente potrebbe dire qualcosa di più anche sulla storia di Ippolito e dei suoi.
L’albero genealogico
Non c’entra ma c’entra: un piccolo dato genealogico che solitamente sfugge e va invece fissato da qualche parte è che la nonna paterna di Ippolito era Marianna Andreassi de Consiliis – originaria di Oriolo Calabro – il cui nonno Francescantonio era, a fine Seicento, Presidente della Regia Camera della Sommaria, e i cui avi De Georgis furono committenti, nel Cinquecento, dello splendido presepe in pietra di Tursi. Chiusa parentesi.

Buonvicino è un po’ Napoli
Buonvicino e Napoli, dunque, e il nesso torna quando intravedi nel centro storico un “vico Speranzella”, che riporta dritto ai Quartieri Spagnoli e alla pizza fritta di Donna Fernanda. Ancora una volta, testa e pancia. Nel bar della piazza mi ero fermato a parlare con due anziani – forse nemmeno tanto – che si contendevano la scena mentre il numero di bicchieri di vino reciprocamente offerti diventava sempre più incerto.
Gerardo e Angelo mi raccontavano così del maestro d’ascia Francesco Martorello, classe 1906, che batteva i boschi dormendo all’addiaccio in sacchi a pelo fatti di foglie d’albero; della grotta del diavolo, di quella d’u sìettu, della zona della scivulenta detta così perché ci si facevano scivolare i tronchi degli ontani appena tagliati, della grotta di Maladurmì che col suo nome confermava tutto il mio scetticismo di quando altri mi raccontarono l’improbabile etimologia che riconduceva a questa stessa parola il nome della contrada Maladrumi in Sardegna, verso Porto Istana.
Ma torniamo agli anziani del luogo, meno fantasiosi (forse): mi parlavano dei feudatari della prima metà del Seicento, i De Paula di Malvito (pure avi del gastronomo Cavalcanti), contro i quali la popolazione di Buonvicino si sarebbe armata ferocemente non soltanto per opporsi all’aumento dei balzelli ma anche – immancabile in ogni leggenda che si rispetti – allo ius primae noctis.
Sanzioni economiche
Buonvicino e l’Impero fascista: appena si entra nel centro storico ci si imbatte in una lapide che, lì per lì, dice poco e che invece ha anch’essa un suo primato ben preciso: è tra le meglio conservate delle circa 40 colleghe superstiti in Italia. Risale alla fine del 1935 e ricorda le sanzioni economiche comminate all’Italia da parte della Società delle Nazioni in occasione delle conquiste in Africa Orientale.

Per disposizione dello stesso Mussolini, tale lapide doveva essere affissa presso tutte le sedi municipali italiane. Dopodiché furono rimosse, abrase, riutilizzate, distrutte e, appunto, ne rimangono oggi pochissimi esemplari. Quella di Buonvicino è tra le più intatte, neppure le lame dei fasci sono state intaccate (solitamente era l’intervento “minimo”): potere della perifericità.
Non trasferire mai la statua del Santo
Buonvicino e l’imperscrutabile. Il 17 settembre 2006, festa di San Ciriaco (guaritore ed esorcista vissuto a cavallo dell’anno 1000, patrono di Buonvicino), un masso si stacca dal costone di roccia che sovrasta il paese. Rimbalza da un angolo all’altro del dirupo, ignora il centro storico e si dirige verso la piazza alle porte del paese, laddove è in corso il mercato per la festa.
Tradotto: persone, bancarelle, automobili. Risultato: nessun danno a persone o cose (e le persone, ok, possono darsela a gambe con una certa prontezza; bancarelle e auto parcheggiate, un po’ meno). Mi fermo ad ascoltare il racconto un po’ più attentamente perché, man mano che i dettagli aumentano, mi ricorda sempre più la trama di altri due o tre racconti analoghi.

Pare insomma che la sacra effige del santo fosse stata portata anche quell’anno in processione dalla Chiesa di San Ciriaco Abate fino alla chiesetta costruita nei pressi della grotta che il santo adoperò come eremo, in fondo al vallone nei pressi del paese. Fin lì tutto normale. Se non fosse che quella volta fu deliberatamente lasciata lì e non riportata “a casa sua”. Da qui l’ammonimento del Santo: ira e salvazione, mazze e panelle. Tutti questi dettagli, insomma, m’hanno ricordato la storia di un’immagine sacra, rinvenuta in un bosco, poi trasferita in una chiesa, poi sparita e ritrovata esattamente nel luogo originario, laddove si decise infine di fondare il monastero del Sagittario, in Basilicata.
La stessa ‘cocciutaggine’ delle statue sacre mi è nota, per il pochissimo che ne so, almeno in due altri casi: a San Bartolomeo ad Alicudi, e alla Madonna del Càfaro ad Albidona (portata in una nuova chiesa e puntualmente ritrovata nella chiesa precedente, e puntualmente riportata nella nuova fino alla frana definitiva di quest’ultima, in cui si salvò solo la statua). Sarà per questo che al bivio della sterrata che conduce alla grotta di San Ciriaco un cartello invita religiosamente a non bestemmiare per le buche, perché “Dio ti sente, il Comune no”.

Enogastronomia e misticismo
Va detto, Buonvicino riesce a unire sacro e profano, sensi e spirito. Enogastronomia e misticismo, forse, per giunta, tutto in chiave naturalistica: l’enorme statua di San Ciriaco che incombe – protettiva e minacciosa – sul paese, sta fuori da una delle prime curve della martoriata strada che porta alla chiesa della Madonna della Neve, 720 metri s.l.m. (ovvero un dislivello di 320 in pochi tornanti). Ma, quando si arriva lì, si è presi dal guardare a tutto fuorché alla chiesa, trovandosi su un terrazzo naturale a metà tra cielo e montagne dell’Orsomarso. A fare da guardia, due cagnolini, ma proprio cuccioli, che vi seguiranno imploranti (benché non randagi) fino a quando non rimetterete piede in macchina.

Ventisei famiglie senza luce e acqua corrente
Dall’altra parte del bivio “delle bestemmie” si prende invece la strada sterrata, ma abbastanza in piano, per la contrada abbandonata di Serrapodolo, a circa 5 km dal centro storico. È ciò che resta di una delle antiche vie istmiche calabresi: questa si insinua subito fuori dal paese, in mezzo ad un canyon, e procede fino al Varco del Palombaro (quello che portava al santuario di Artemisia, in seguito a quello del Pettoruto, e da sempre alla Piana di Sibari).

Per arrivare a Serrapodolo bisogna bagnarsi i piedi un paio di volte e ne vale la pena: oggi ci si incontra al massimo qualche gruppo composto da bue, vacca e vitellino, ma fino al 1968 qui vivevano ben 26 famiglie, mi dicono. Non erano mai state raggiunte dall’acqua corrente e dalla luce elettrica, e lentamente abbandonarono questa vallata e questi paradisi, restituendoli alla loro eternità.