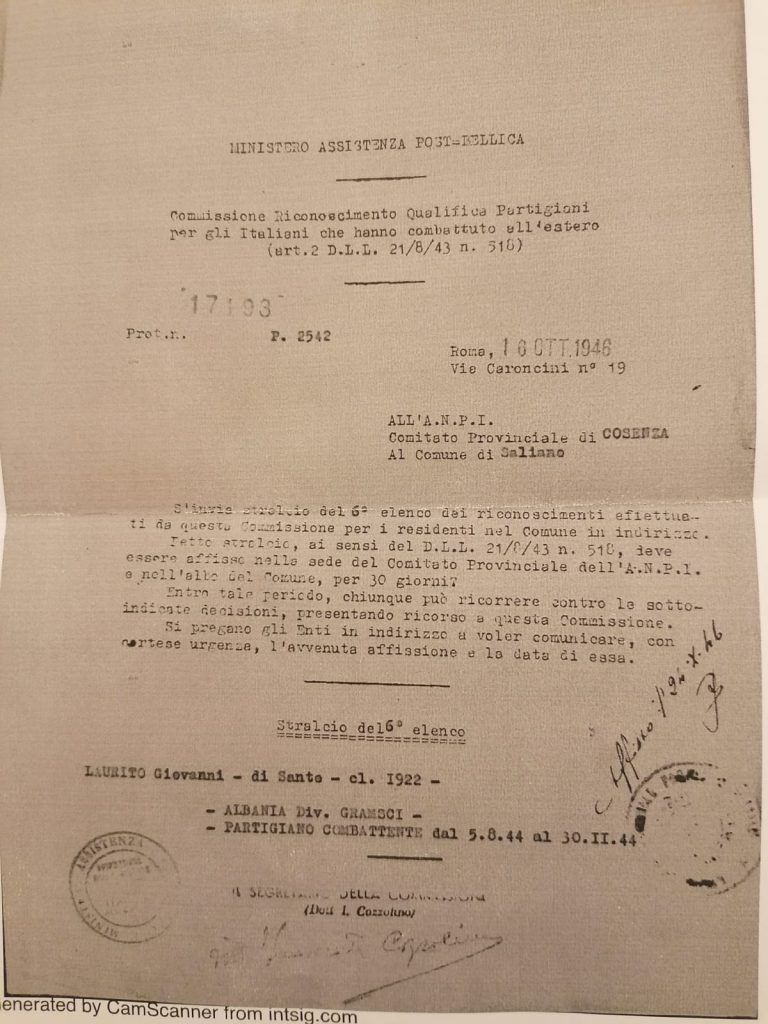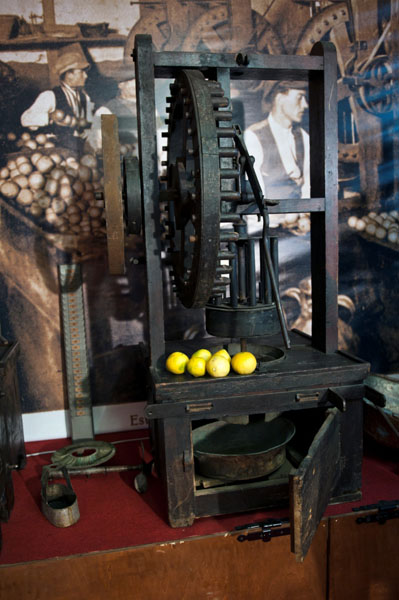[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Terzo anno di pandemia, di nuovo a pensare alle vacanze possibili. Condizionato dal Covid e dalle relative problematiche due anni fa e poi l’estate scorsa ho iniziato a passare in rassegna le spiagge della mia infanzia, progettando di ritrovarne una adatta a un periodo di riposo. Ne ho rivisto alcune dopo decenni di reciproca indifferenza. Speravo di evitare le videochiamate pietose dei tanti connazionali confinati in quarantena a Malta, come a Mykonos o alle Baleari, imploranti soccorso dalla patria lontana. Questa umiliazione pubblica e mediatica no, non intendevo subirla.

Due mesi sul Tirreno cosentino
I miei genitori, da Cosenza, quando noi figli eravamo piccoli – parliamo di mezzo secolo fa – avevano preso l’abitudine di affittare un appartamento al mare. Per un mese, a volte anche per due, come si usava allora, di solito sul Tirreno cosentino. Da Amantea a Cetraro, da Guardia Piemontese a Fiumefreddo, da Fuscaldo ad Acquappesa, abbiamo vagato per molti anni, come gli ebrei nel deserto del Sinai. Gli ebrei avevano trasgredito, così racconta la Bibbia, ma noi che colpa dovevamo espiare? Cosa cercavamo, dopo aver caricato l’auto di tante masserizie, che all’epoca i padroni di casa non ritenevano di mettere a disposizione degli ospiti?
Dune, mare, edifici abusivi
Un’estate, forse due siamo sbarcati a Torremezzo, frazione sul mare di Falconara Albanese. Le marine calabresi si somigliavano tutte, tra le dune dal nulla spuntavano case e palazzi vicinissimi alla spiaggia. Edifici in gran parte abusivi ovviamente, proprio davanti al rilevato ferroviario, così di notte si saltava nel letto, al passaggio di ogni espresso Palermo-Milano.
Le prime case prese in affitto dai miei non le ricordo, ero troppo piccolo. Dai racconti che ritrovo nella memoria si capisce che erano essenziali e scomode, ma ancora più ristretti erano gli alloggi dei proprietari che, pur di guadagnare qualcosa, si trasferivano in una mansarda, o presso parenti. A Torremezzo, però, eravamo già negli anni Settanta e le sistemazioni pioneristiche, per uomini duri, erano disponibili, per fortuna nostra, solo ai ritardatari incalliti.

L’eparchia di Lungro arriva a Torremezzo
Non ho trovato molte foto di queste vacanze, soprattutto le case si vedono appena. All’epoca scattare una foto richiedeva un minimo di formalità, un’occasione, un compleanno, una prima comunione, eravamo lontani dalla follia dei social.
Quello che mi ha meravigliato, però, dopo tanti anni, parcheggiando sul lungo viale di Torremezzo, davanti ai palazzi e ai condomini scrostati dalla salsedine, è stata la scoperta di trovarmi nei confini dell’eparchia di Lungro. L’eparchia è una circoscrizione amministrativa, in uso nella chiesa orientale. Quella di Lungro è una delle due eparchie italiane, l’altra ha sede a Piana degli Albanesi, in Sicilia. Nelle due estati trascorse a Torremezzo non mi ero reso conto di dimorare in una comunità di cattolici albanesi di rito greco.
L’eparchia di Lungro è stata istituita nel 1919, le sue comunità sono sparse lungo la valle del Crati, alcune anche fuori regione, ma i fondatori di Falconara si sono allontanati dai compatrioti fino a stabilirsi tra le montagne della catena tirrenica.
La comunità originaria è quella di Falconara, un borgo nascosto tra le montagne, a qualche chilometro dal mare. Per non trovarsi d nuovo davanti i turchi, o piuttosto i pirati saraceni, da cui erano fuggiti intorno alla metà del Quattrocento, quando la loro terra entrò a far parte dell’Impero ottomano, la Sublime Porta.

La Storia mi è apparsa davanti all’improvviso, sotto le modeste sembianze di una piccola chiesa, intitolata al Santissimo Salvatore, in mezzo ad alcuni sterminati alveari abitativi dall’aspetto desolato, in abbandono. Tra le palazzine orfane di vacanzieri la chiesa era aperta e in ordine, ed era una tipica chiesa bizantina, con le icone alle pareti, i mosaici e l’iconostasi che separa la zona riservata al papas, al sacerdote, dal settore dei fedeli.
I Balcani sul Tirreno?
Imperdonabile non aver esplorato il territorio delle vacanze, anche se la chiesa non credo esistesse in quegli anni (su un sito arbëresh ho letto che fu edificata nel 1991). Ho scoperto anche che la parrocchia di Falconara entrò a far parte dell’eparchia in tempi recenti, durante l’episcopato a Cosenza di monsignor Enea Selis, che volle riunire quella comunità isolata alle altre comunità albanesi.
Ma perché durante il mio soggiorno non mi ero spinto fino a Falconara? Cosa avevo da fare di importante in quella noiosa marina?

Se mi fossi mosso da ragazzo avrei scoperto, molti anni prima, il fascino del mondo balcanico. Magari sarei partito subito per la Morea, in cerca dei castelli crociati e delle fortezze ottomane e veneziane. In Albania avrei ammirato prima il parco archeologico di Butrinto, bellissimo, immerso nel verde, circondato da una laguna, dove si passano in rassegna tutte le civiltà mediterranee.
Le vacanze dei cosentini
Il problema delle vacanze dei cosentini, a ragionarci adesso, mi appare chiaro: ci si ritrovava al mare, tutti negli stessi posti, sempre tra le stesse facce, a volte in mezzo a conoscenti, vicini di casa, parenti proprietari di seconda casa, data la nota, sfrenata passione edilizia dei miei concittadini. Quindi non ti veniva la curiosità di esplorare i luoghi, perché ti sembrava di stare sempre a Cosenza, una Cosenza con la spiaggia e il mare.
A volte passeggiando a Guardia Piemontese, per dire, mi capitava di pensare di trovarmi in città, a via Caloprese. C’erano negozianti, parrucchieri, che in estate aprivano al mare un doppione dell’attività cittadina. Perfino i sacerdoti andavano in trasferta, a tenere d’occhio le pecorelle del gregge parrocchiale, temendo la dissolutezza e il sesso libero delle vacanze. Il massimo dell’esotismo era rappresentato da qualche famiglia di napoletani. In questa situazione non potevo pensare né all’esodo albanese né al dramma dei Valdesi massacrati a Guardia. Eravamo autoreferenziali, come si dice adesso.

In una marina nulla è pensato per spingerti verso la storia. Poi negli anni Settanta le marine erano una manifestazione della volontà di buttarsela alle spalle, quella storia triste, fatta di paesi isolati, di contrade senza acqua potabile e luce elettrica. Di noia e occhi sempre puntati addosso. Al mare si stava in costume, si passeggiava fino a tardi, si mangiava in modo più disordinato.
In mezzo a tutti quei glutei esibiti senza ritegno (in molti casi sarebbe stato opportuno un velo pietoso), a quei corpi ustionati e spalmati di olio solare (un solo flacone di Coppertone appestava una spiaggia), offerti allo sguardo critico o libidinoso dei vicini di ombrellone, ognuno poteva illudersi di trovarsi nella lussureggiante Bora Bora. I locali, ovviamente con nomi evocativi, minimo Palm Beach, mandavano musica ad alto volume, tutto il giorno; che ti fregava, insomma, della storia della fondazione di Falconara?
Torremezzo e Falconara
Evidentemente questi saranno stati i miei colpevoli pensieri in quelle roventi estati a Torremezzo, pensieri disturbati dal fischio stridente del treno. Ora ne passano meno, di treni, mi sembra, e le folle di vacanzieri devono aver preso altre direzioni, a giudicare dall’aspetto dimesso e malconcio di molti edifici. Il mare purtroppo mi apparve sporco, in quella prima estate di pandemia, segnato da schiuma e strisce inquietanti. Peccato.

Ora sarebbe il momento di recuperare il filo della storia: a Falconara qualcuno si è preoccupato di studiare, raccogliere tradizioni, canti, usi della piccola comunità. In rete si trova qualche documento interessante, si rinvia a dei libri. Molto più di quello che di solito si riesce a leggere su un comune così piccolo. Bisognerebbe raccontare o inventare, nel caso, le mitiche peripezie dei fondatori. Necessita un racconto di fondazione. Si potrebbe anche prenderlo in prestito dai libri di Carmine Abate, che ne ha scritti tanti. Io ho ancora da recuperare gli altri borghi delle mie vacanze del secolo scorso, per espiare la distrazione peccaminosa degli anni giovanili.