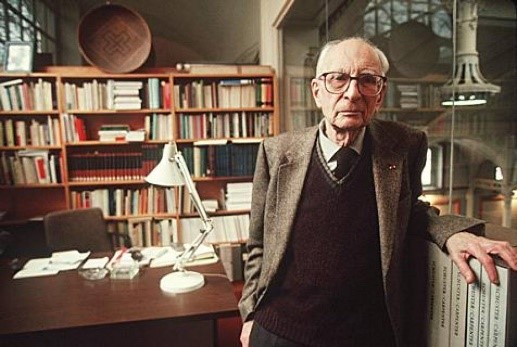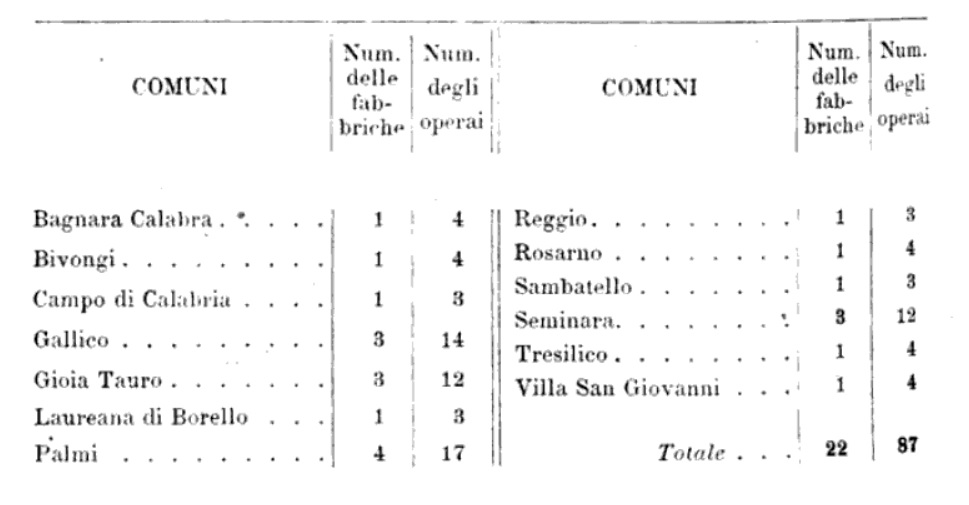Un giro del mondo e tanti guai, tra l’amore e l’anarchia. Li ha vissuti Giacomo Bottino, un operaio nato a Paola nel 1897 e poi emigrato, giovanissimo, a San Paolo del Brasile.
Sulle rotte dell’emigrazione transoceanica, Giacomo incontra la sua prima, grande passione: la politica.
A inizio XX secolo, essere socialisti non è facile. Ma essere anarchici può essere peggio: significa fare concorrenza a sinistra ai compagni dell’Internazionale, già in fase di divisione tra socialismo e comunismo. E significa, ovviamente, finire nel mirino delle autorità quasi in completo isolamento politico.
Che è poi quel che accade a Bottino.
Stuccatore a Formia
In Brasile Bottino non ha solo conosciuto l’anarchismo, ma ha anche imparato un mestiere: fa lo stuccatore ed è abbastanza apprezzato.
Nel 1921 si trova a Formia, dove si divide tra il lavoro e l’attività politica. E dove non ci mette molto a farsi schedare.

Infatti, Giacomo si dedica a un’intensa propaganda tra i muratori e i ferrovieri, in maggioranza comunisti, ai quali distribuisce Umanità Nova, la mitica rivista fondata e diretta da Errico Malatesta, dapprima a Milano e poi a Roma, dove il giornale e il suo fondatore sono costretti a trasferirsi perché i fascisti ne avevano incendiato la sede per rappresaglia in seguito alla strage dell’hotel Diana, attribuita agli anarchici.
Bottino frequenta Malatesta e proprio a casa del guru dell’Internazionale Anarchica conosce l’altra sua grande passione: Ida Scarselli.
Una famiglia pericolosa votata all’anarchia
Bella, alta mora e un po’ robusta (e, aggiungerà qualche anno dopo un anonimo verbale di polizia, «dall’aria simpatica») Ida è coetanea di Giacomo.
Ma in quanto a passione anarchica sembra tre volte più anziana: fa parte di una famiglia toscana di sette fratelli (oltre a lei, Oscar, Ferruccio, Egisto, Tito, Leda e Ines), tutti anarchici e tutti pericolosi.

Il 28 febbraio 1921 gli Scarselli si fanno (a dir poco…) notare a Certaldo, in provincia di Firenze, dove partecipano a un durissimo scontro di piazza con le Forse dell’ordine e i fascisti, giunti a dare manforte.
Ferruccio, il fratello maggiore, resta ucciso. Oscar, affetto da una vistosa zoppia, si dà alla macchia e fonda un suo gruppo: la Banda dello Zoppo. Poi scappa all’estero, gira mezza Europa e alla fine si rifugia in Urss, assieme a suo fratello Tito.
Egisto passa guai peggiori: arrestato subito dopo i disordini, si becca vent’anni di condanna. Ida, invece, viene arrestata e processata a Roma. Ma sarà assolta nel 1925 per insufficienza di prove.
Propaganda e anarchia: il primo guaio di Giacomo
Con questo popò d’esempio, Giacomo non ci mette molto a ficcarsi nel suo primo guaio serio.
Nel 1922 si trasferisce a Roma per stare vicino a Ida.
Il 24 aprile di quell’anno, Bottino si fa beccare dalla Polizia mentre volantina tra i soldati per incitarli alla diserzione. Viene arrestato e finisce sotto processo per propaganda sovversiva. Lo salva l’insufficienza di prove.
Ma i problemi veri sono solo all’inizio.
Una lettera maledetta
Il 27 novembre 1926 la censura intercetta una lettera indirizzata a Giacomo, che nel frattempo convive a Roma con Ida.
Gliel’ha spedita suo cognato Oscar dal Belgio e sembra scritta apposta per far infuriare i fascisti: dentro c’è tutto quello che un fuoriuscito può pensare del duce.

Le autorità iniziano a scavare nelle vite di Giacomo e Ida e trovano abbastanza elementi per considerarli non più dei “semplici” antifascisti, ma addirittura dei cospiratori.
A questo punto scatta il confino di pubblica sicurezza. Per sottrarvisi, Giacomo scappa a Messina. Ma la fuga dura poco, perché i carabinieri lo beccano il 13 febbraio 1927.
A questo punto il confino a Lipari dovrebbe essere una certezza, per lui.
Ma il regime la pensa diversamente: la pratica di Giacomo e Ida è passata, nel frattempo, al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
La galera e il confino
I due anarchici non sono più un affare delle prefetture, ma sono diventati di competenza dell’Ovra, la famigerata polizia fascista, che li ritiene parte del Soccorso Rosso internazionale, dopo aver scoperto le attività di Ida in favore dei detenuti politici.
Giacomo è rispedito a Roma il 20 marzo 1927 e subisce un processo per direttissima assieme alla sua compagna.
La condanna, inevitabile, è una mazzata per entrambi: tre anni di carcere, tre di sorveglianza e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici a lui; due anni e mezzo di carcere, tre di sorveglianza più l’interdizione a lei.
Ma l’amore vince ancora su tutto. E stavolta, galeotto è proprio il fascismo.
Il matrimonio e il ritorno in Calabria
Giacomo esce di galera il 19 marzo 1930, ma le autorità lo trattengono e lo spediscono al confino a Ponza. Qui ritrova Ida e, finalmente, la sposa Scontata del tutto la pena, Giacomo fa ritorno in Calabria nel ’32, dove porta con sé Ida e i loro tre figli.
Dapprima la famiglia Bottino si stabilisce a Paola, dove Giacomo chiede, invano, alla Questura di Cosenza un passaporto verso il Brasile, per sé, per la moglie e per una figlia.
Poi la coppia si trasferisce nel capoluogo, dove lui lavora come stuccatore nel cantiere del Palazzo degli Uffici.

Li raggiunge il cognato Egisto, nel frattempo uscito di galera grazie all’amnistia concessa dal regime per celebrare il suo decennale. Giacomo, con tre figli a carico, si dà la classica calmata e lavora duro. Anche Egisto si dà da fare come muratore nel medesimo cantiere del cognato. Tuttavia, non perde la passione politica e il vizio della propaganda. Resiste finché può a Cosenza e poi prova a scappare all’estero. Ma la polizia di confine lo ferma il 18 febbraio 1938 a Ventimiglia, assieme a un antifascista cosentino: Edoardo Vencia di Pedace.
Nel Brasile dei golpisti
La fine della guerra e del fascismo non significa la pace per la famiglia Bottino. Evidentemente, l’Italia di Mario Scelba, per anarchici come loro, non è più sicura di quella del ventennio.
Il 19 gennaio 1947 Giacomo, Ida e i tre figli si trasferiscono in Brasile, per la precisione a Niteròi, una città costiera dello Stato di Rio de Janeiro.

L’approdo in America Latina è la classica brace dopo la padella: nel 1964 i militari cacciano con un golpe il presidente João Goulart e instaurano la dittatura che durerà per i ventun anni successivi.
Fine della storia
Da questo momento in poi, Giacomo, di cui sono note anche in Brasile le simpatie politiche, finisce nel mirino della polizia e subisce le angherie di un vicino di casa, evidentemente legato al regime.
Quest’ultimo minaccia Giacomo più volte e lo denuncia ai militari. Non pago, arriva a sparare all’italiano e lo uccide. È il 14 settembre 1970.
Ida muore il 22 ottobre 1989, a novantadue anni suonati. E vanta un primato singolare: è stata la prima donna condannata da un Tribunale fascista. Per questo merito, lo Stato italiano le ha riconosciuto la pensione e la reversibilità di Giacomo.