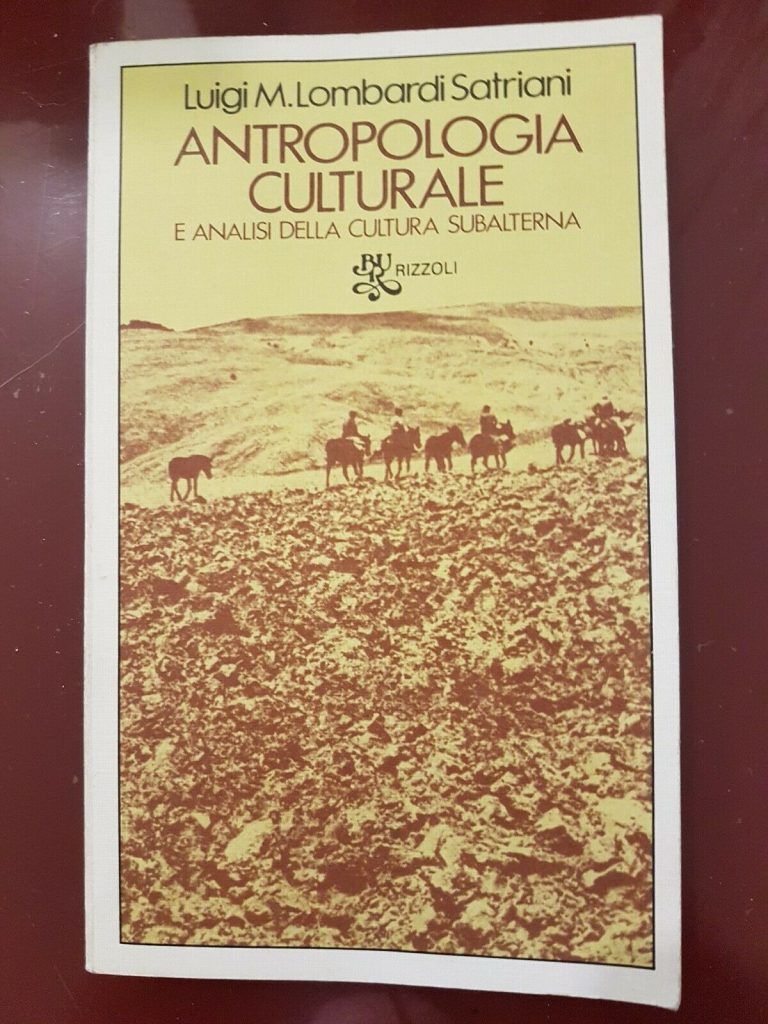[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Negli anni Cinquanta si assiste in Calabria a un grande successo del cinema. Già durante il fascismo i calabresi andavano in massa a vedere i film che si proiettavano nelle piazze: gli operatori dell’Istituto Luce arrivavano con un furgone, sistemavano un telone bianco sulla facciata di una casa e proiettavano pellicole di propaganda del regime. Nel dopoguerra le sale cinematografiche erano sempre affollate e molti spettatori, a volte costretti a stare in piedi, visionavano una pellicola anche due o tre volte.
Il cinema sbarca in Calabria
Nell’inverno del 1949 a San Giovanni in Fiore fu girato Il lupo della Sila e per diversi giorni gli abitanti ebbero occasione di vedere attrici e attori famosi come Vittorio Gassman, Amedeo Nazzari e Jaques Sernas. La simpatia e le attenzioni dei giovani sangiovannesi era tuttavia rivolta alla bellissima Silvana Mangano, la star reduce dallo straordinario successo di Riso amaro. Il film, diretto da Coletti, su soggetto di Steno e Monicelli, voleva avere una impronta realista e una sensibilità etnografica. In realtà, però, si tratta di un cupo melodramma che ripropone l’immagine del calabrese geloso e vendicativo e tradizioni popolari inventate come la gara del taglio degli alberi.
Dalla Sila all’Apromonte
Il lungometraggio ebbe un discreto successo e l’anno seguente Ponti e De Laurentiis producono Il brigante Musolino. Dalla Sila si passa all’Aspromonte ma i temi che caratterizzano la nuova pellicola sono gli stessi della precedente. Il protagonista personifica i caratteri stereotipati del calabrese: forte, spietato, violento, vendicativo e sanguinario. I delitti del romantico giustiziere si susseguono, lo scenario sociale è assente e il brigante si pone al di fuori della sua comunità, vittima di stato, mafia e chiesa. Calabresella viene cantata sia al matrimonio che durante la vendemmia.
I calabresi come barbari
Il lupo della Sila e Il brigante Musolino fornivano un’immagine negativa dei calabresi: genitori che per interesse sacrificano le figlie, gente che tradisce per paura e interesse, giovani irruenti, passionali e pronti a prendere il fucile per qualsiasi controversia e difendere l’onore della famiglia. I film, tuttavia, non suscitarono proteste e solo alcuni cortometraggi come Calabria segreta di Vincenzo Nasso furono aspramente criticati. Giornalisti e intellettuali calabresi rimproverarono al regista di avere rappresentato una immagine falsa della regione.
Miceli scriveva che, dopo aver visto il documentario prodotto dalla Rai, era rimasto molto deluso e amareggiato. Si trattava di un film di «pessimo gusto» che rivelava una spaventosa ignoranza della regione. Il regista «supercivile», con duelli feroci e balenio di coltelli, presentava i calabresi come barbari, ignorando che la Calabria non era stata patria del banditismo e che il popolo era buono e laborioso, semplice e onesto, amante della famiglia, della casa e della patria. Anche la “Baronessa scalza” criticava su un giornale cosentino il cortometraggio definendolo una produzione cinematografica «nauseante» per aver presentato i calabresi come feroci e primitivi.
L’altro cinema in Calabria
Non tutti i cineasti condivisero le scelte dei grandi produttori cinematografici. Negli anni Cinquanta alcuni registi realizzarono documentari sulla realtà economica, sociale e culturale della regione. I calabresi e la Calabria si prestavano bene a tradursi in forme artistiche e alla sperimentazione cinematografica. Pescatori che cacciavano il pescespada con tecniche millenarie in un mare azzurro e trasparente, fedeli che si flagellavano con pezzi di vetro spargendo sangue lungo i vicoli dei paesi e donne che raccoglievano olive ai piedi di alberi secolari avvolti dalla nebbia, erano soggetti e luoghi ideali per girare un film.

I contadini segnati dalla fatica e ammantati con panni consumati dal tempo, apparivano più interessanti di attori del grande cinema dalle facce regolari e vestiti con abiti inamidati provenienti da atelier; i paesi e le case abbarbicati su luoghi aspri e inospitali, le campagne arse dal sole, le montagne coperte da boschi impenetrabili erano più avvincenti dei paesaggi freddi e irreali costruiti negli studios di Cinecittà.
I documentari e la cura per le immagini
Alcuni registi erano affascinati da quella regione che ai loro occhi appariva come un luogo mitico, dove la natura era incontaminata e dove gli uomini vivevano in maniera semplice. Erano attratti da quella terra arcaica e spesso eliminavano ogni riferimento al reale che potesse inquinare il pathos della pellicola. A volte ricostruivano i rituali con attori di strada per renderli più spettacolari e drammatici. Lo stesso De Seta, il più bravo e originale tra i documentaristi, nel cortometraggio I dimenticati, per riprendere la festa dell’albero ad Alessandria del Carretto, chiese ai paesani di ricostruire alcuni momenti del rito.
Gli autori dei documentari filmavano la Calabria che avevano già in mente. Puntavano su immagini suggestive che suscitassero meraviglia e catturassero l’attenzione degli spettatori. Accompagnavano le sequenze con voci declamatorie. Utilizzavano colonne sonore per drammatizzare le scene. Davano al montaggio un senso di ansioso reportage. Eliminavano tutto ciò che era ritenuto scarsamente cinematografico. Erano particolarmente attenti alle inquadrature e alla cura della fotografia. Le immagini “dovevano parlare da sole”. In un fotogramma o in una sequenza dovevano essere rappresentati cultura, passioni e lavoro di un popolo.
La Calabria onirica al cinema corto
Spesso finivano per creare un’atmosfera onirica, fatta di volti e gesti antichi, sguardi immobili, luoghi irreali e selvaggi. Immagini belle sul piano filmico ma inventate e astoriche. I registi del “cinema corto” documentavano il reale ma al tempo stesso ne offrivano una visione lirica, cinematografica nel senso classico. Esigenze estetiche li spingevano a vedere solo la parte arcaica della Calabria e a ignorare quella che si stava trasformando per effetto della modernizzazione. Preoccupazioni stilistiche li spingevano a disinteressarsi dei forti cambiamenti che si verificavano nelle campagne, a non tenere conto del fatto che la logica del profitto stesse annullando le diversità culturali, a sottovalutare il senso di sradicamento presente in larghi strati della popolazione, a non vedere che la cultura dei calabresi si stava trasformando.
Qualcuno criticò tali documentari ricordando che la Calabria non era una terra semplice in cui gli uomini si accontentavano di mangiare e dormire, dove vigeva la logica della sopravvivenza, dove non c’erano momenti in cui il superfluo vinceva sul necessario, dove c’era una cultura collettiva fissata nel tempo a cui tutti si omologavano.
I registi di documentari e cortometraggi ebbero comunque il merito di rifiutare trionfalismo, conformismo ed etnocentrismo con cui i colleghi del grande cinema avevano ripreso e riprendevano la Calabria.
Antico vs Moderno
Nelle loro pellicole non si vedono i volti felici di contadini che mietono il grano dei cinegiornali, ma visi scavati dalla fatica e dal sole; non più campagne ridenti e fertili, ma terre spaccate dall’arsura e allagate dai fiumi; non più paesi pittoreschi abbarbicati su incantevoli paesaggi, ma centri urbani fatiscenti e abbandonati all’incuria del tempo. Contadini, pescatori, pastori e artigiani, nei loro filmati appartengono a un mondo millenario dove l’agire quotidiano è fatto di gesti uguali e ripetitivi, gente anonima che lavora silenziosamente nella lotta per l’esistenza in una natura straordinariamente bella, ma spesso aspra e violenta, amara e ingrata.

Nei cortometraggi i registi riconoscevano alle classi subalterne una dignità culturale che veniva denigrata da un vecchio meridionalismo e ignorata da un modernismo imperante. Scarsamente attratti dalla religione del progresso, si schieravano con la gente povera del Sud che pagava più di ogni altro il processo di modernizzazione. Proponevano col loro cinema una lettura etica e umanista della Calabria e dei calabresi, una visione che si contrapponeva a quella di intellettuali e politici che pensavano ad una rinascita della regione attraverso la distruzione della mentalità arcaica e retriva dei suoi abitanti.
Pasolini e le critiche
Nel dopoguerra tra molti calabresi si avvertiva una forte insofferenza nei confronti di una parte dell’opinione pubblica italiana che tendeva a presentare la regione come una terra arretrata. Nel 1959, in occasione di alcune dichiarazioni di Pier Paolo Pasolini sui calabresi, molti insorsero con commenti durissimi. Un giornalista scriveva che avrebbe voluto «sputare» sul volto dello scrittore il più profondo rancore e risentimento per le «espressioni bassissime» da lui rivolte alla sua gente.

La sua «sfacciataggine» era odiosa e, più che una risposta polemica, avrebbe meritato quattro poderosi calci «con le scarpe chiodate» di quei robusti boscaioli della Sila che «stillavano sudore e sangue per la quotidiana lotta di un tozzo di pane nerissimo». Il popolo calabrese era il più educato e il più generoso dei popoli, «ma guai a chi avesse cercato di calpestargli i calli!». Un altro periodico pubblicava la lettera aperta di un lettore che accusava Pasolini di avere usato nei confronti della Calabria le solite frasi «trite e ritrite» di chi è prevenuto: gli uomini della regione erano sani e belli e le donne erano abbronzate, efebiche, belle e affascinanti! .
Il Rally del cinema: la Calabria sulla stampa nazionale
Nello stesso anno, un fatto accaduto a Castrovillari suscitò un vivace dibattito sul “carattere” dei calabresi. Il 25 giugno, in occasione del Rally del cinema (gara automobilistica definita Mille miglia delle stelle), il marchese Gerini, con a bordo Anita Ekberg, durante una sosta presso un distributore di benzina, infastidito dalla folla che faceva ressa per ammirare da vicino la “Venere di ghiaccio”, ripartiva a forte velocità travolgendo venti persone. Secondo la stampa nazionale, il marchese, impaurito dai giovani che avevano perso letteralmente la testa per la diva svedese, partì con la Lancia Flaminia cercando di farsi largo tra la folla e mettersi in salvo. In una corrispondenza di Paese Sera si legge che, in ogni paesino della Calabria, folle di giovani assalivano puntualmente le macchine del rally prendendo gli equipaggi «a pacche, pizzicotti e sganassoni».

Si trattava di gente analfabeta e ignorante che perdevano la ragione di fronte a bellissime bionde come Eleonora Ruffo, che per il caldo sollevava le gonne ad altezze vertiginose! In realtà, secondo alcuni giornali locali, i giovani avevano mostrato solo un eccessivo entusiasmo per la Ekberg e qualcuno di loro aveva sputato e urlato contro Gerini dopo che questi li aveva insultati con gesti volgari e parole offensive. I castrovillaresi non erano selvaggi assatanati ma gente civile e ospitale: ragazze in costume tradizionale avevano accolto gli equipaggi con fiori e sorrisi e l’amministrazione comunale aveva offerto un pranzo a base di pollo arrosto e ottimo vino.
Anita Ekberg e il processo a Castrovillari
L’anno seguente, il 12 maggio 1960, Anita Ekberg, la celebre diva del cinema «dai capelli biondo-cenere e dalla pelle madreperlacea» che «camminava quasi sempre a piedi nudi e usava il reggiseno solo quando andava a cavallo», giunse in Calabria per testimoniare al processo contro Gerini. Quando scese dalla macchina davanti al tribunale di Castrovillari una folla di gente, in attesa da ore, l’accolse con un forte applauso. L’attrice, vestita elegantemente nella sua princesse nera con stola di visone selvaggio scuro, fu circondata da decine di fotografi e giornalisti.

In aula, alla richiesta del Presidente della Corte di dichiarare la sua età, l’attrice rispose che quella non era una domanda da rivolgere a una donna. E, nella deposizione, scagionò il marchese dichiarando che i giovani erano diventati così invadenti da sedersi sul cofano della macchina. Disse, inoltre, che alla sua camicetta non mancava alcun bottone e che quel giorno era vestita come una collegiale: gonna e camiciola a maniche lunghe. Durante il processo, il presidente della corte fu costretto a far sgomberare l’aula per il clima esagitato. La deposizione della Ekberg fu persino oggetto di una interrogazione dell’onorevole Migliori al ministro di Grazia e Giustizia nella quale si chiedeva se, come attestato da foto comparse su giornali e rotocalchi, l’attrice si fosse presentata con abiti e pose in contrasto col decoro delle aule giudiziarie: gambe accavallate, décolleté a vista e braccia scoperte!