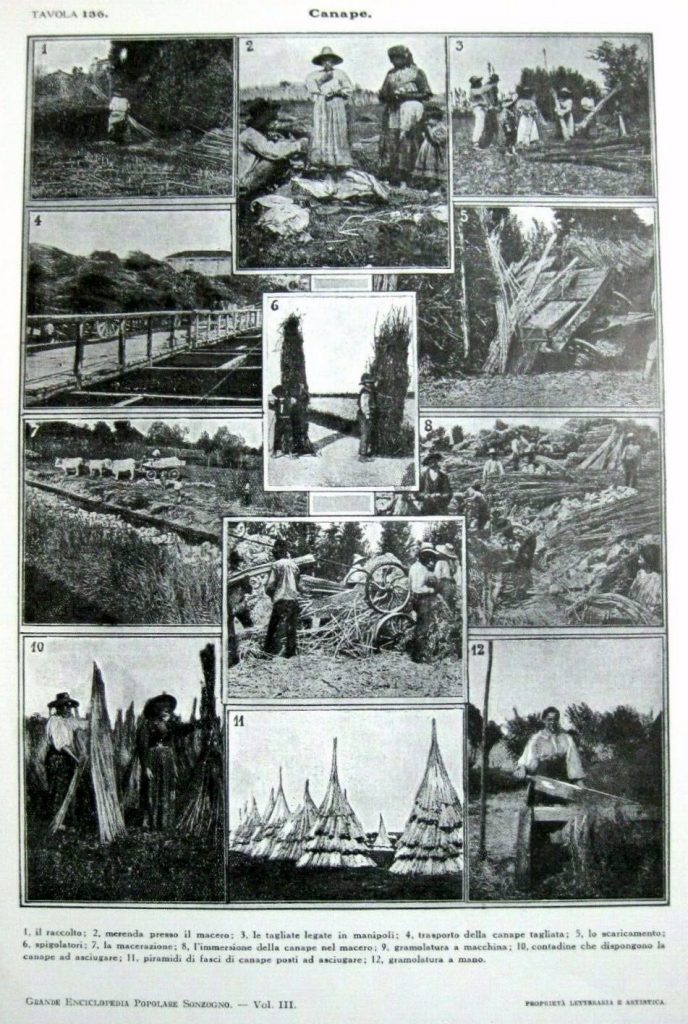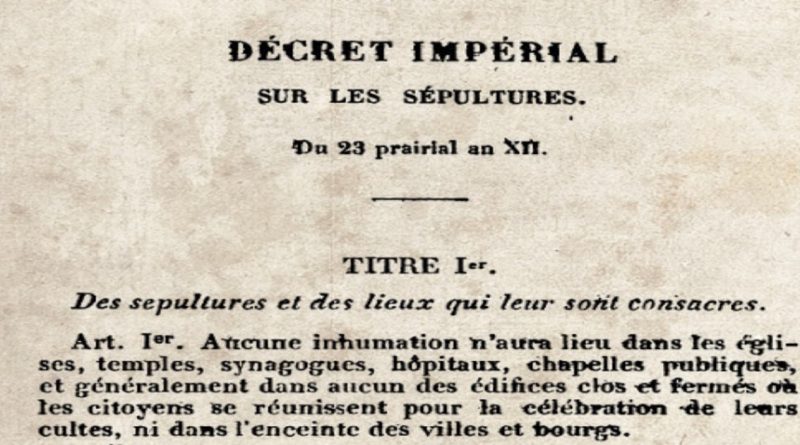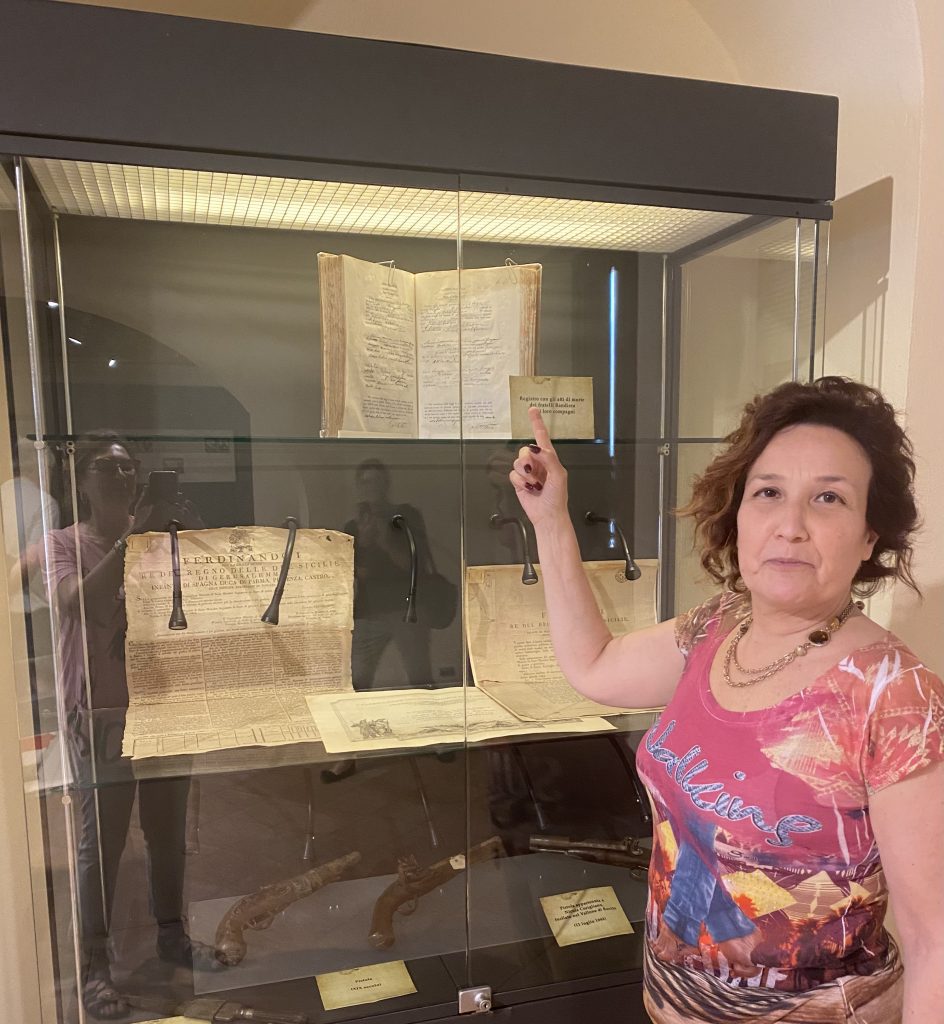[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Il polpo è una prelibatezza. In Calabria lo si prepara soprattutto ad insalata. Prima si eliminano occhi, becco e vescichetta, poi lo si cuoce in acqua bollente leggermente salata a fuoco molto basso. Non appena diventa tenero, si serve tagliato a tocchetti, con capperi, olive, pomodorini, foglie di basilico e peperoncino.
Una cattiva fama
Nel corso dei secoli, tuttavia, il cefalopode non ha goduto di buona fama. Anzi, era considerato di non facile assimilazione.
Ad esempio, Galeno e i medici della scuola salernitana scrivevano che non bisognava mangiare polpi perché le loro carni legnose e fibrose, resistevano alla digestione e avvelenavano il sangue.
Nei trattati di cucina in cui si davano consigli per vivere bene, si legge che i polpi incitassero alla incontinenza, erano poco nutrienti e particolarmente dannosi per lo stomaco.
Pareri contrastanti
Il polpo ha sempre affascinato gli uomini, che hanno espresso giudizi contrastanti. Aristotele e Plinio sostenevano che fosse un animale sciocco perché per curiosità si attaccava alle gambe del pescatore e si lasciava catturare.
Era talmente tonto e avido da avvinghiarsi a una frasca d’ulivo trascinata dal fondo del mare fino a farsi tirare fuori dall’acqua.
Eliano, invece, affermava che i polpi fossero animali intelligenti perché si acquattavano sotto le rocce, assumendone i colori per afferrare le prede. Giovio osservava che fossero talmente ingegnosi da mettere tra le valve delle ostriche una pietra per impedirne la chiusura.

Il polpo fifone
Secondo alcuni esperti il polpo era un animale vigliacco, che scappava di fronte alla minaccia, mimetizzandosi o spruzzando un liquido nero per intorbidire l’acqua. Serpetro scriveva che, essendo privo di vertebre, sangue e squame, fosse pavido e fuggisse dinnanzi ai nemici, rifugiandosi nella tana e alimentandosi dei suoi stessi tentacoli.
Teofrasto aggiungeva che la sua pelle spugnosa e piena di fori cambiasse colore come quella di un camaleonte per la paura.
Invece no: è tosto
Per altri studiosi il polpo era, invece, un animale coraggioso e, quando raggiungeva una certa grandezza, conseguiva una forza tale da essere considerato una «tigre del mare». L’arcivescovo Olao Magno Gotho raccontava che fosse feroce, crudele, aggressivo e preferisse affrontare il nemico piuttosto che rinunciare al combattimento. Perciò aggrediva grandi pesci e spesso anche marinai, pescatori e palombari.
Maier sosteneva che il polpo era il simbolo del coraggio: infatti era raffigurato nelle monete di alcune città della Magna Grecia per esprimere la forza e il carattere guerriero degli abitanti.
Spendaccione o risparmiatore?
Giovanni Fiore, ha interpretato una moneta di Thurio sui cui lati erano raffigurati un delfino e un polpo.
Secondo lui il primo simboleggiava la volontà di girare per il mondo come un pellegrino. Al contrario, il secondo, attaccato tenacemente agli scogli, esprimeva la sedentarietà e la cura per i beni.
Altri autori, invece, affermavano che il polpo fosse un dissipatore di sostanze e un divoratore senza ragione. Gli Egiziani, ad esempio, lo utilizzavano nei geroglifici per indicare chi era incapace di mantenere il frutto della propria potenza.
Erasmo da Rotterdam sosteneva che la capacità del polpo di mimetizzarsi era un monito a non mettere al centro la propria cultura e a non disprezzare le altre.

Il polpo secondo i santi
San Paolo si era comportato come un polpo per evangelizzare e convertire gli ebrei, accettandone leggi e tradizioni.
Per sant’Ambrogio, san Gregorio, san Basilio e altri santi predicatori, l’octopus era invece da disprezzare: un pesce molle senza fede e senza cuore, simile a quegli ignobili adulatori senza scrupoli, sempre pronti a mutar atteggiamento per compiere nefandezze e soddisfare i loro interessi venali.
E secondo i saggi
Eliano e Picinelli asserivano che il polpo fosse così avido e ingordo da non disdegnare gli esseri della sua specie e che mangiasse volentieri i suoi stessi tentacoli in mancanza d’altro cibo.
Invece per Ateneo e Plinio le mutilazioni dei polpi erano dovute ai denti aguzzi di gronghi e murene che, grazie alla loro vischiosità delle membra, sfuggivano i tentacoli. Mirabella pensava che il polpo stampato sulle monete di Siracusa rappresentasse l’eterna lotta tra tirannia e repubblica.

Il cefalopode simboleggiava, infatti, avarizia, ingordigia e superbia. Insomma, i vizi riscontrabili nel tiranno Dionigi che per anni aveva angariato i Siracusani.
D’altro parere lo studioso Testa, secondo cui il polpo incarnava l’immagine della città siciliana. Era infatti immortalato assieme a una stella marina in alcuni piombi di navi mercantili, per simboleggiare che Siracusa fosse stata edificata su uno scoglio ove dimoravano i polpi.
Il mollusco “porcone”
Il polpo era considerato un animale “impuro” perché lascivo e libidinoso.
Secondo gli Egiziani indicava un uomo incapace di staccarsi da una donna. E, secondo loro, solo l’erba pulicaria riusciva a farlo desistere dal coito.
Si diceva che la bramosia sessuale spingesse i polpi ad accoppiarsi ripetutamente. Di più: erano così insaziabili che, anche dopo la cottura, rimanevano ben eretti sulla propria corona di tentacoli.
Il polpo? Meglio del Viagra
Chi mangiava polpi diventava più potente sessualmente. Giovio scriveva che questi molluschi si digerivano con difficoltà, creavano sangue impuro e tormentavano il fegato ma il loro «salsume» svegliava l’appetito di Venere. Il sugo e la carne dei polpi dissalati e bolliti gonfiavano il membro virile e ravvivavano la voglia sessuale persino tra i deboli.
A Venezia i vecchi languidi e «mezzi morti» che desideravano procreare, acquistavano a caro prezzo i polpi essiccati o «invecchiati» dal sale che arrivavano da diversi porti del Mediterraneo.
Anche le donne, per favorire il concepimento, inghiottivano pezzi di polpo ben caldi insieme a pastiglie composte di nitro, coriandolo e cumino.
Le proprietà afrodisiache dei polpi spingevano i sacerdoti a considerarne le carni una minaccia per la salute di corpo e anima: la continua copulazione portava l’uomo alla rovina fisica e morale, così come accorciava la vita agli stessi cefalopodi.
Troppo sesso fa male, anche ai polpi
Plinio e altri scrittori affermavano che vivevano non più di due anni e che le femmine morivano di consunzione dopo la riproduzione.
Il naturalista calabrese Minasi confermava che fosse proprio la brama sessuale a condurre alla morte i polpi prima del compimento di due anni.
Per condannare la diffusa carnalità tra i fedeli, i predicatori cristiani usavano sempre la metafora del polpo che, spossato dai continui rapporti sessuali e senza forze, era preda dei nemici.
Il citato Olao Magno Gotho scriveva che i polpi, per il veemente coito, si debilitavano al punto di farsi portar via dalle loro tane e divorare da fragili pesciolini.
Pitagora proibiva ai suoi allievi di mangiare il polpo perché le sue carni spingevano alla copula. Come se non bastasse, vietava anche il consumo d’ortiche marine perché, bollite o fritte, anch’esse afrodisiache.
I polpi a causa dei continui rapporti sessuali perdevano ogni forza e diventavano pavidi, mentre quando non copulavano erano dotati di vigore e coraggio al punto da assalire gli uomini.
La brama sessuale portava alla morte e il polpo era catturato dai marinai sfruttandone la lascivia. In alcuni villaggi i pescatori calavano in acqua un polpo femmina attaccato a una corda, il maschio si avvicinava per congiungersi e i due cefalopodi, avvinghiati l’uno all’altro, erano tirati sulla barca.

Polpo, padre dei vizi?
Nel mondo antico il polpo incarnava le cattive abitudini degli uomini e i predicatori cristiani lo additavano come simbolo del demonio. Al contrario, in alcune città marinare era considerato una divinità e, presso alcuni popoli, alla nascita di un bambino per augurio si regalava un polpo alla puerpera.
I polpi erano animali «doppi»: generatori e annientatori, pavidi e coraggiosi, fedeli e traditori, buoni e cattivi.
Un proverbio antico diceva polypi caput per indicare quelle cose e quelle persone che non erano né tutte buone e né tutte cattive.
Il polpo bifronte
Il pensiero mitico va oltre il pensiero concettuale, gli opposti coesistono senza contrastarsi: sono aspetti complementari di una realtà unica.
Il polpo indicava una zona di confine tra due mondi, il naturale e il soprannaturale, e tra due nature, la terrestre e la marina. Proprio questa convivenza degli opposti alimentava il suo mito. Era un ossimoro in cui i contrari si contrapponevano e si compenetravano: caos e ordine, visibile e invisibile vivevano l’uno accanto all’altro.