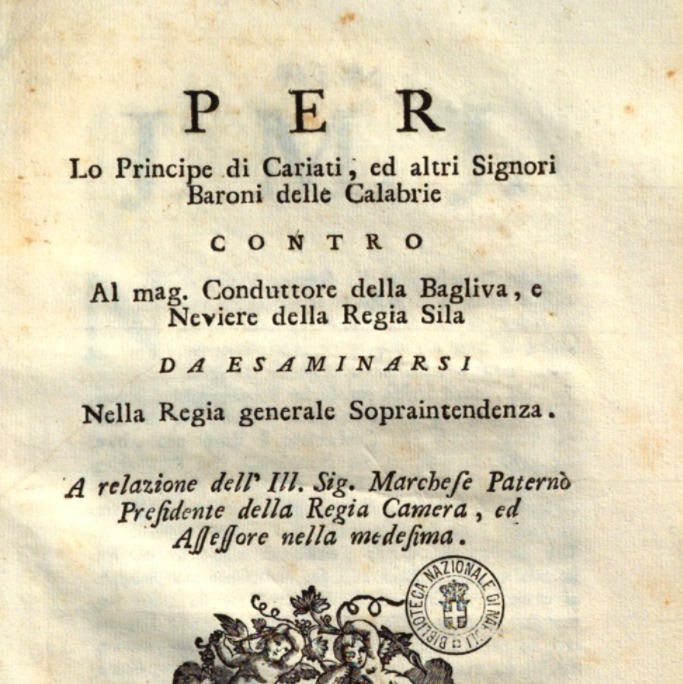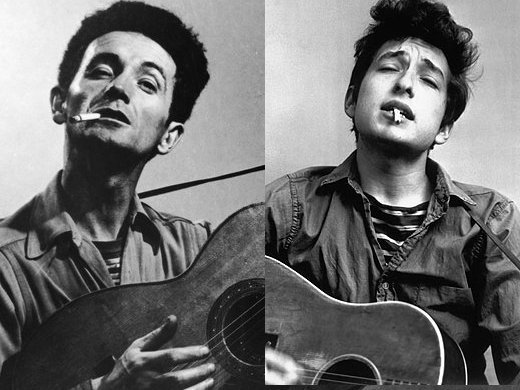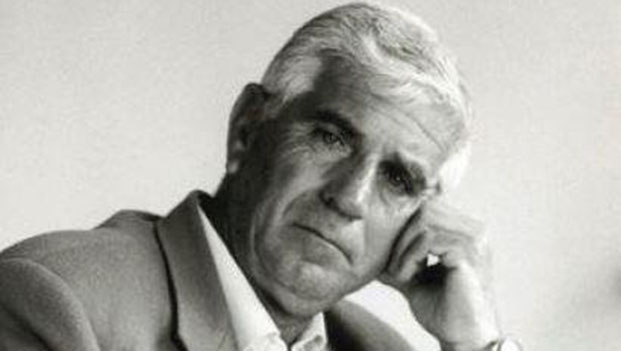Gli addetti ai lavori l’avevano ovviamente previsto (anzi, direi, “messo in conto”, un po’ nel bene e un po’ più in mala fede). Gli osservatori attenti se ne saranno accorti in tempo. La restante fetta di fruitori percepisce, assorbe acriticamente e poco elabora, in ossequio alla distinzione già aristotelica fra chi possiede logos e chi solo doxa, opinioni: in vista del centenario della marcia su Roma, gran parte dell’editoria italiana (non soltanto scientifica) si è prodigata in pubblicazioni a tema mussoliniano e/o fascista, declinate ora sul romanzesco, ora sull’equilibrismo tra il censorio e il garbato coccodrillismo.

In coda, istituzioni culturali, società storiche, archivi di Stato, deputazioni di Storia patria, obbligati a fare i conti con due numeri di 8 cifre assai simili (28101922 e 28102022), in virtù del mai sopito potere seduttivo del sistema decimale. I due numeri non sono utenze telefoniche e tuttavia hanno chiamato la suddetta compagine all’appello. Qual è il risultato? È un altro dato prevedibile, per alcuni: ovvero che del fascismo non si sa ancora parlare.
Del fascismo non si sa ancora parlare
Questo profluvio di pubblicazioni e di convegni, ha indici e programmi la cui eloquenza lascia quasi sempre abbastanza a desiderare, al netto del prestigio di taluni contributori. Si tratta perlopiù di retrospettive su questo o quello specifico personaggio, su questo o quell’evento relativo agli albori del fascismo o – fuori luogo – su qualche parentesi resistenziale che poco c’entra col centenario.

Sia chiaro sin d’ora: ovviamente solo forzanovisti, casapoundisti e compagnia marciando potrebbero auspicare una vera e propria “celebrazione” della ricorrenza anziché un mero riferimento asettico e di riflessione. E ci mancherebbe altro: non è questo il punto. Il punto è che cent’anni – diciamo pure un’ottantina – sono serviti assai poco a formare una seria coscienza critica rispetto alla salita al potere del regime fascista.
Duelli e imbarazzi
Qualcuno lo temeva e prevedeva già negli anni ’50: l’Italia non farà mai i conti col Ventennio, senza riuscire mai ad elaborare e metabolizzare tutto l’accaduto e soprattutto le ragioni dello stesso, e resterà stretta nella morsa del manicheismo fra buoni e cattivi, fra belli e brutti, rossi e neri (con prevedibile gioia dei bianchi, poiché tertium datur eccome!). La qual cosa riesce, oltre che ingiusta, anche un po’ ridicola e finanche imbarazzante per i protagonisti di tanta parte della storia politica – e culturale – dell’Italia repubblicana, tenuto conto del camaleontismo italico, dell’epurazione all’acqua di rose, dell’amnistia firmata Togliatti eccetera.

Il caso vuole – e questo è proprio un caso – che l’anniversario cada all’alba di un governo di destra, e ciò rende a molti ancora più imbarazzante un riposizionamento visibile (e allora, pensano gli stessi molti: meglio non farsi vedere affatto, almeno per un po’). Questo è il guaio: che di talune cose o si parla con una certa colorazione o non se ne può parlare affatto, con tutta la pavida ottusità di ritenere che parlare di un fascista significhi per forza vestirsi da fascista, neofascista o nostalgico che dir si voglia, senza distinguere la biografia dall’agiografia: ma che candore!
Una scelta di comodo
Di certi argomenti, insomma, non si riesce ancora a parlare con la dovuta e auspicabile serenità, sopraffatti da decenni di vulgata monocorde, comprensibile per via di una sedimentazione ideologica e pertanto culturale decennale: una stratificazione in cui abbiamo “imparato” a dare per scontati alcuni dati di fatto (o non-fatto) e meno altri; alcune certezze assai più apparenti che reali. Perché? Perché è comodo, perché è facile e rasserenante scegliere la via più breve. La quale, però, a ben vedere è la stessa identica via breve che – mutatis mutandis – può sempre portare a scorciatoie molto accidentate e pericolose.
La marcia su Roma e la prova generale a Napoli
Sto uscendo forse dal mio stesso seminato e certamente sto rimanendo sul vago. Ma, per essere più specifico, il tema meriterebbe un trattato che non ho il tempo di scrivere (né, francamente, tutta questa gran voglia). La marcia su Roma, si sa, ha radici più vecchie e anche poco mussoliniane: fu D’Annunzio a concepirla già un anno prima, e a programmarla per il 4 novembre ’22 prevedendovi anzitutto l’adesione di reduci e combattenti. E proprio a D’Annunzio i vari De Ambris, Balbo, Michele Bianchi e Dino Grandi avrebbero conferito per l’occasione la direzione degli squadristi.

Curiosamente o, anzi, assai comprensibilmente, sopravvivono più fotografie della “prova generale” della marcia che della marcia stessa: intendo quel Congresso tenuto a Napoli, in piazza del Plebiscito, pochi giorni prima. E mica c’era solo la spina nel fianco del reducismo che chiedeva conto del suo sacrificio: ragionevole era pure l’appoggio offerto al fascismo da parte degli industriali o dell’aristocrazia e della borghesia, per non dire della monarchia e del Vaticano. Chi meglio di un movimento nuovo, progressista, anticlericale e antisocialista – come appunto il fascismo degli albori, sottolineo degli albori – avrebbe potuto ispirare fiducia?
Fascisti insospettabili (o quasi)
Si pensi che tra i maggiori oblatori in favore della causa fascista ritroviamo aziende e privati oggi insospettabili (o quasi), ad esempio Voiello, Cirio, Citterio, Peroni, Cinzano, Wührer, Pedavena, Piaggio, FIAT, Isotta Fraschini, Paravia, Lips Vago, Manetti & Roberts, Rueping, e ancora il comm. Luigi Bertarelli, fondatore del Touring Club, nonché esponenti dell’aristocrazia fiorentina e marchigiana come i Ricasoli, gli Strozzi, i Ginori, i Della Gherardesca, i tre conti Gentiloni Silverj e i tre conti Tomassini. Perché mai i vari gruppi di potere o comunque ‘diffusi’ e con interessi da tutelare non avrebbero dovuto assicurarsi la propria fetta di appoggio, una propria garanzia? Era più che lecito cercare altri interlocutori politici, oltre a quelli già presenti e non ostili.

Fin troppo semplice istruire un processo alle intenzioni e giudicare i fatti a un secolo di distanza, con la cognizione maturata, a posteriori, di ciò che il fascismo divenne nel corso del Ventennio, di quali furono le sue pecche e quali i danni che procurò al Paese. Bisogna invece calarsi in quel preciso frangente storico e guardare i fatti con gli occhi di chi li vedeva accadere sul momento. Nessuno aveva la sfera di cristallo né nel 1919, al momento della fondazione del movimento, né quando si preparava e si attuava la marcia, né quando i fascisti entrarono in parlamento e nemmeno con le varie violenze perpetrate prima d’allora. No, nemmeno con quelle, ché non erano le uniche.
Il delitto Matteotti come spartiacque
La percezione del vero – o del nuovo – volto del fascismo fu indiscutibilmente chiara al grande pubblico soltanto nel 1924 con l’omicidio Matteotti. Pochi, prima del 28 ottobre, avrebbero previsto la longevità che un regime, dalle fattezze oggi note, avrebbe riservato. Tanti vi credettero in buona fede. In ogni caso, di marcia si parlò e poco più che di una marcia si trattò, a dispetto di qualche narrazione fin troppo gloriosa e apologetica rispetto al reale evento. Un film non notissimo ma esemplare, riesce a restituire perfettamente la natura della partecipazione alla marcia, attraverso le maschere di Vittorio Gassman e di Ugo Tognazzi nella pellicola tragicomica di Dino Risi intitolata, appunto, La marcia su Roma (1962).