[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Durante il fascismo la Calabria è nel destino di chi subisce il confino di polizia. Si stima che tra il 1926 e il 1943 i confinati in Italia siano 18.000 e di questi il 15% si ritrovi lì.
La propaganda antifascista in quegli anni è tra i peggiori crimini da prevenire: bisogna domare ogni istinto ribelle. Non importa aver commesso un reato per finire al confino, basta un semplice sospetto di pericolosità. È una misura di prevenzione che si applica con un mero allontanamento, ma di fatto priva della propria autodeterminazione chi se la vede infliggere. Il regime preferisce luoghi dell’entroterra, isolati durante i mesi invernali, difficilmente raggiungibili, scarsamente politicizzati. Ed è così che a Longobucco, paesino di poche anime sulla Sila cosentina, si scrive un’inaspettata favola da Mille e una notte.
Ma senza lieto fine.
Abis… Sila
L’Italia è appena uscita vittoriosa dalla campagna d’Africa, ma nella nuova colonia non mancano i malumori verso l’invasore. Un esempio? L’attentato a Rodolfo Graziani, figura di spicco del fascismo italiano, accusato di crimini di guerra e viceré d’Etiopia. Graziani rimane ferito nell’agguato, la dura repressione alla resistenza anticoloniale non si fa attendere e provoca migliaia di vittime.
I fascisti decidono di allontanare figure della classe dirigente etiope per scongiurare il rischio che animino nuove insurrezioni contro il regime.
E così una parte degli etiopi finisce al confino in Sila, a Longobucco. Sebbene l’isolamento del paese si presti ad aspre detenzioni, la permanenza si rivela migliore del previsto.
I deportati etiopi al confino a Longobucco sono infatti personalità vicinissime a Hailé Selassié, l’imperatore che dopo l’occupazione fascista aveva scelto l’esilio volontario. Hanno un livello socioculturale elevato e intrattengono contatti epistolari con Mussolini e alti prelati nel tentativo di cambiare la propria sorte.
È in effetti la Santa Sede a muoversi per garantire loro un soggiorno meno duro. A testimoniarlo, una lettera di monsignor Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI, al nunzio apostolico monsignor Francesco Borgongini Duca. Montini evidenzia le difficoltà economiche del figlio dell’ex ministro di Etiopia e chiede una soluzione al problema.
Al confino a Longobucco: «Purché non siano serviti da bianchi»
Data l’attenzione che i confinati etiopi riscuotono, le autorità fasciste assumono nei loro confronti un atteggiamento moderato. I nuovi arrivati non tardano ad accorgersene e si uniscono ai longobucchesi per ottenere maggiori compensi dalle casse del regime.
Gli italiani chiedono i pagamenti per i servizi offerti ai confinati e gli etiopi avanzano richieste per abiti, cibo e integrazioni degli assegni. Anche in virtù di questo scambio reciproco, le autorità trasgrediscono all’obbligo di non far incontrare i confinati con la popolazione locale.

Gli etiopi arrivano lassù con l’etichetta di irriducibili e pericolosi, ma l’interesse e la propensione a creare un clima cordiale per il quieto vivere rendono possibile l’incontro tra le due culture. Un certo peso pare averlo anche il fatto che, sebbene privati della libertà di lasciare Longobucco, siano prigionieri molto particolari rispetto ad altri al confino: vestono in doppio petto, nella villa che gli ha assegnato la Prefettura ci sono molti libri e si organizzano concerti. E poi, si racconta, ricevono un assegno di mille lire al mese, la somma che gran parte degli italiani dell’epoca sogna ascoltando l’omonima canzone alla radio.
Se, da principio, c’è chi li guarda circospetto, presto gli etiopi al confino diventano parte della comunità di Longobucco. Notabili africani e contadini silani vanno d’amore e d’accordo, al palazzo e ri nivuri (dei neri, ndr) le donne del paese portano minestre e verdure, le sarte cuciono per loro degli abiti in occasione delle festività. Colori, lingue, profumi per sette anni si incrociano nei vicoli.
È nato nu criaturo, è nato niro
Di quella convivenza la traccia più nitida resta Michele Antonio Scigliano, figlio della relazione illegittima tra Giuseppina Blaconà, una contadina di Longobucco, e il ras Ubie Mangascià al confino in Sila. Lui ha bisogno di una brava cuoca; lei ha il marito Vincenzo Scigliano al fronte, proprio in Etiopia, e bisogno di un lavoro. S’incontrano, si piacciono. E il 19 febbraio del 1939 a Longobucco nasce un bambino. Con la pelle scura come suo padre, povero come sua madre.

Per il paese e il regime è uno scandalo. Il ras Mangascià viene trasferito da Longobucco a Bocchigliero e lì rimane fino al 1943, quando gli alleati riportano gli etiopi al confino nella loro terra. Tornato in Africa, Mangascià diventa ministro delle Poste e consigliere della Corona, sposa una principessa del luogo molto vicina all’Imperatore.
Non dimentica però – e come lui altri confinati, che torneranno in Sila negli anni successivi – gli affetti lasciati sulle montagne calabresi, almeno non del tutto. Invia un po’ di denaro per contribuire alla crescita del figlio, chiede a Giuseppina di trasferirsi col bambino ad Addis Abeba, ma lei rifiuta.
‘U nivureddu, da boscaiolo a miliardario
Michele Antonio, nel frattempo, cresce con la sola madre. Per tutti è u nivureddu. Conduce una vita di stenti, cerca di racimolare qualche quattrino con i lavori più umili, tra qualche gesto di inclusione e le chiacchiere di paese che lo dipingono come figlio del peccato.
Appena maggiorenne si sposa con Filomena, povera come lui. Poi la sua vita cambia all’improvviso.
Nel municipio di Longobucco arriva una lettera, è dell’ambasciata d’Etiopia. Informa i cittadini che si andava cercando il figlio del ras. Qui le versioni della storia arrivate fino ad oggi divergono: secondo alcuni nella missiva si parla della morte del principe e della concessione dell’eredità al figlio Michele Antonio Scigliano; secondo altri di riferimenti a eventuali lasciti non ci sarebbe ombra. Fatto sta che u nivureddu per tutti è diventato miliardario.

La notizia della chiamata di Michele Antonio in Etiopia elettrizza i longobucchesi che risfoderano la loro arma migliore: la solidarietà. Preparano (a loro spese) feste e banchetti, gli comprano vestiti nuovi. Nasce addirittura un comitato – ne fanno parte, tra gli altri, il sindaco Giacinto Muraca e il vicesindaco Antonio Celestino – per chiedere un mutuo in banca allo scopo di gestire le spese di viaggio.
Il neo miliardario – secondo chi sostiene che il comunicato parli dell’eredità – va in giro promettendo, oltre alla restituzione dei soldi spesi in suo onore e per la sua partenza, anche gloria e splendore per Longobucco, il paese che aveva accolto il padre e cresciuto lui.
Il principe non cerca moglie
Giunto in Etiopia, però, l’unico pensiero è la sua nuova vita da principe. Di lui – tantomeno del denaro da restituire – in paese non si saprà più nulla. Qualcuno ancora oggi dice che lo abbiano ammazzato dei sicari assoldati da ulteriori eredi che non volevano dividere con lui il malloppo. Altri che la sorella di Ubie Mangascià abbia fatto cancellare dal testamento quel nipote mezzosangue.

Filomena, intanto, per la vergogna è tornata da sua madre a Rossano portando con sé i due figli. Al Corriere della Sera, che va a intervistarla nel 1963, racconta di essere andata a trovarlo in Africa pochi mesi prima. Michele Antonio – riferisce al cronista – pare avere problemi col testamento che gli ha cambiato la vita, ma va in giro su macchinoni in dolce e numerosa compagnia. Promette anche a Filomena denaro che non invierà mai. Si mostra freddo, ma non troppo. «I fimmini tutti l’ommini ce l’hanno… però Antonio non si è scordato di me e l’ha dimostrato!», spiega al giornalista la donna accarezzando nel pancione il loro terzo bambino che dovrà presto sfamare in qualche modo. Il marito le ha chiesto di chiamarlo Mangascià.
Longobucco e il confino
Gli etiopi non sono i primi dissidenti a essere finiti al confino a Longobucco, né gli ultimi. Passano da lì in quegli anni i personaggi più disparati, da Lea Giaccaglia ad Amerigo Dumini. E il paese fa da cornice anche alla tragica morte di tre confinati, due uomini e una donna. Le autorità archiviano il caso in tutta fretta, derubricandolo a omicidio-suicidio frutto della gelosia. Si tratterebbe, al contrario, di un delitto politico legato al mondo del nazionalismo croato di estrema destra, all’epoca alleato dei nazifascisti.

In Sila, però, il passaggio di queste genti ha lasciato ben poco di tangibile, solo racconti. Rimangono in filigrana nella storia di un paese, che per poco tempo, vide l’Africa a spasso nei suoi vicoli.
I longobucchesi di quegli anni non ebbero la sensibilità intellettuale di comprendere la portata del fenomeno, non conservarono abiti, ricetti, oggetti o lettere. Ma, in tempi non sospetti, custodirono, per tramandarcelo, il bene più prezioso: l’umanità.
































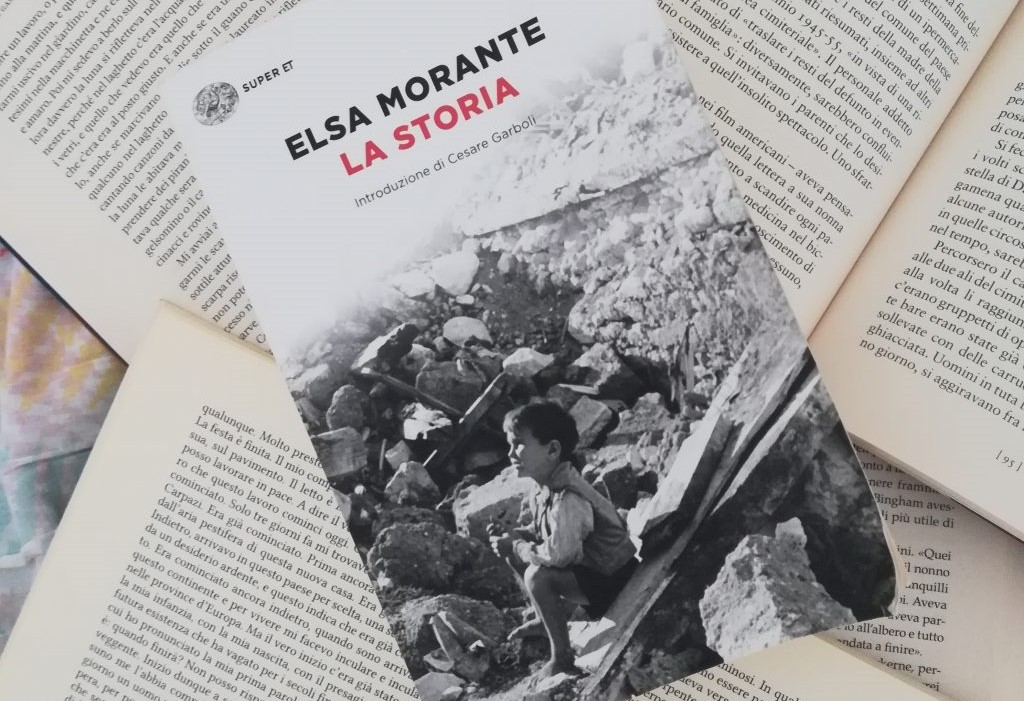








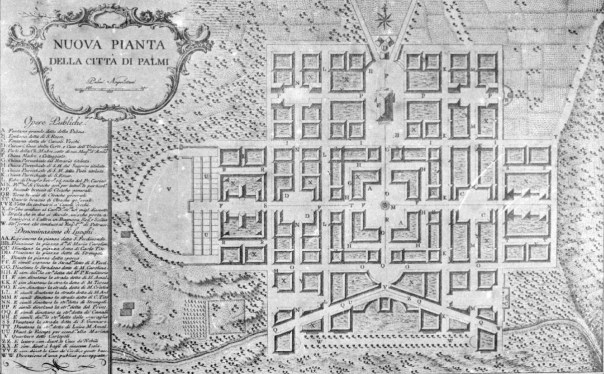




























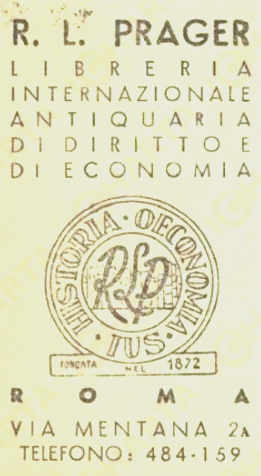 Werner Prager, protagonista – forse inconsapevole – di questa storia libresca, nacque nel 1888 a Berlino, dal libraio Robert Ludwig (1844-1914) la cui bottega aprì nel 1872. Assieme alla moglie Gertrud, continuò a gestire la società R. L. Prager e, pensando poi di scampare ai provvedimenti antisemiti, trasferì ingenuamente l’attività da Amsterdam a Roma nel 1937, ovvero solo un anno prima della promulgazione delle
Werner Prager, protagonista – forse inconsapevole – di questa storia libresca, nacque nel 1888 a Berlino, dal libraio Robert Ludwig (1844-1914) la cui bottega aprì nel 1872. Assieme alla moglie Gertrud, continuò a gestire la società R. L. Prager e, pensando poi di scampare ai provvedimenti antisemiti, trasferì ingenuamente l’attività da Amsterdam a Roma nel 1937, ovvero solo un anno prima della promulgazione delle 



