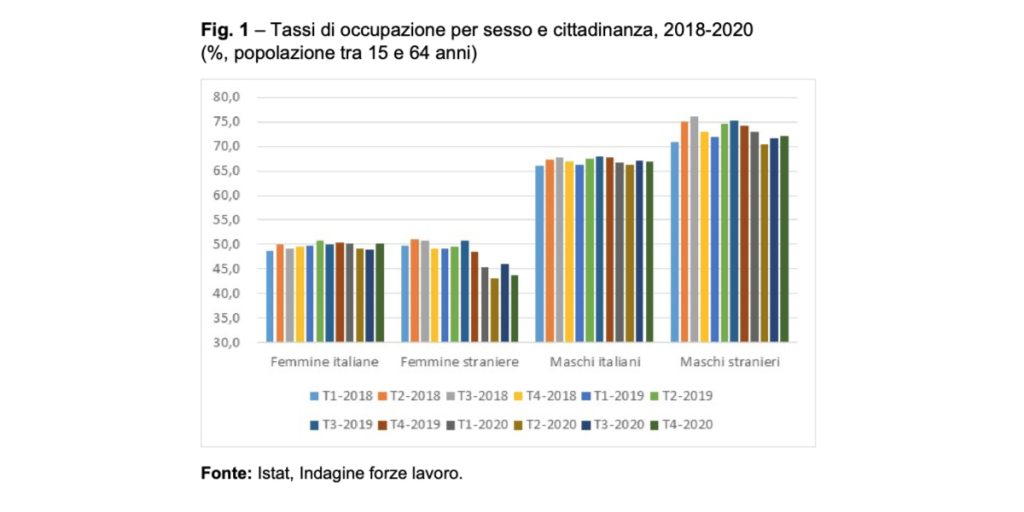Gli intellettuali locali – professori, giornalisti, romanzieri, registi, attori e artisti in genere – sono spesso manager di se stessi, presenzialisti per interesse, volontà di potere mediatico o potere tout court. Presentano libri, rilasciano interviste e fanno conferenze in cui si atteggiano a profeti. L’importante, è trovarsi sempre al centro dell’attenzione, comparire in televisione, essere citati nelle cronache dei giornali e ricevere riconoscimenti. Professionisti della parola, per appagare il loro narcisismo, puntano più alla pancia che alla testa, più agli umori che alla ragione. Consapevoli che per avere successo non è il contenuto del discorso che conta, legittimano sé stessi attraverso retorica, affabulazione e oratoria brillante.

Intellettuali tormentati
Si commuovono quando parlano della Calabria e descrivono il personale tormento che li spinge da una parte a voler andar via e dall’altra a rimanere. A volte la descrivono come una terra eccezionale, ricca di valori e di energie positive. Altre volte come una regione senza speranza che si avvia inevitabilmente verso la catastrofe. Molti intellettuali sono schierati politicamente, ma ammiccano opportunisticamente a un pubblico di destra o di sinistra e polemizzano a prescindere dalle idee. Se qualcuno dipinge un quadro pessimista e negativo della realtà regionale, sono pronti a smontarne le tesi per mutare atteggiamento poco tempo dopo.
Guai se manca il rimborso spese
Le loro conferenze sono moderate da giornalisti, arricchite da musicisti che allietano l’ambiente e attori o attrici che leggono pagine tratte dai loro libri bene esposti sui banchetti per essere venduti. Si fingono disinteressati a successo e guadagni, ma prima di accettare inviti chiedono il rimborso spese ed esigono ospitalità in alberghi e ristoranti rinomati. Gli intellettuali calabresi sono maestri nelle pubbliche relazioni, sempre attenti ad assicurarsi un ruolo nelle giurie di svariati concorsi così da scambiarsi reciprocamente premi e riconoscimenti.
Un premio non si nega a nessuno
In Calabria non c’è città, paese o contrada che non bandisca una rassegna, una selezione, un premio con relativa generosa distribuzione di pergamene, medaglie, coppe, targhe e compensi. Appuntamenti che sono vere e proprie fiere di vanità dove il pubblico si ritrova più per amor di mondanità che per interesse culturale.
Presentandosi come specialisti in grado di trovare soluzioni ai problemi, gli intellettuali spesso sono chiamati dai politici per amministrare la cosa pubblica e molti diventano assessori e consulenti culturali. Una volta assunto il ruolo, organizzano eventi in cui svago e informazione spicciola si confondono, manifestazioni che risultano inefficaci, inutili e vacue, nelle quali si trovano blande tracce di storia, cultura, arte, musica condite da una buona dose di enogastronomia.
Intellettuali che fanno intrattenimento
Alcuni sostengono sia meglio aprire alla modernità piuttosto che restare fedeli alla tradizione, poiché i legami affettivi e identitari condizionano la libertà di scelta. Altri che ci sia bisogno di ritrovare il clima culturale e sentimentale del passato che rappresenta ancora oggi il tratto comune dei cittadini, e insistono nel ripercorrere, realmente o idealmente, gli avvenimenti fondativi della storia locale.
I nuovi intellettuali favoriscono un sapere in cui il cittadino è utente passivo, una volgare cultura d’intrattenimento che ha colonizzato le strutture più profonde della coscienza. Le ricerche approfondite, le inchieste sul campo, le teorie complesse sono ignorate e respinte come inutili e anacronistiche, buone solo per una ristretta cerchia di specialisti.
Storici della domenica
Molti anni fa, Huinziga scriveva che lo storico di professione, rendendosi conto che per comprendere la complessità della realtà c’è bisogno di un faticoso lavoro critico, ha rinunciato a fare l’architetto scegliendo di diventare scalpellino. Interviene, quindi, la figura del dilettante che, illudendosi di avere pensieri ordinati, velocemente intravede tutte le prospettive necessarie per comprendere il reale. Incoraggiata dagli editori, preoccupati di soddisfare una cerchia di lettori sempre più ampia, nasce così quella che può essere chiamata la «storia letteraria». O, meglio, «belletteristica storica», in quanto l’essenza è belletteristica e l’aspetto storico è secondario.
Attenti alle lusinghe del potere
Lo studioso deve esprimere le proprie idee e non lasciarsi accecare dalle blandizie del potere, poiché non è possibile vivere in combutta col sistema e allo stesso tempo criticarlo. In quanto dicitore coraggioso di verità, non deve avere paura di mettere a repentaglio la propria condizione e le relazioni. Come un parresiasta, deve esprimersi in maniera chiara, dire quello che pensa senza dissimulazioni ed orpelli retorici, comunicare il suo vero pensiero correndo il rischio di irritare gli interlocutori.
Il suo compito non è quello di capovolgere il mondo, ma indicare alla sua gente gli atteggiamenti che l’hanno resa vittima di se stessa e, nello stesso tempo, spingerla ad agire per migliorare la sua vita. Deve rivelare agli uomini quanto siano ostaggio di una macroscopica manipolazione volta ad intorpidire le menti e nascondere la vita reale e smascherare i falsi retori che hanno veicolato ideologie finalizzate unicamente a perpetuare il sistema sociale funzionale al potere.
Sfatare i miti di una Calabria piagnona
Alcune ideologie, pur fornendo alla realtà un orizzonte di senso, si fondano sulla mistificazione della realtà. Giustificano l’atteggiamento vittimistico che ha plasmato le coscienze dei calabresi a tal punto da far loro ritenere di essere limitati e incapaci di affrontare gli eventi. I mali che affliggono la regione non sono addebitabili ad altri o al destino ma alle scelte compiute dagli uomini.
La falsa coscienza, o ideologia della sopravvivenza, può forse essere utile per superare difficoltà transitorie, ma sul lungo periodo si rivela dannosa. Il compito dell’intellettuale consiste nel riportare alla luce la falsa coscienza, distruggere le prigioni mentali che condannano gli animi a una cecità sempre più profonda, sfatare i miti che alterano la realtà e oscurano le coscienze, smantellare il castello di sacre opinioni che contribuiscono a dare un’immagine distorta di sé stessi.
Attenti al pensiero comune
L’intellettuale non deve fare la rivoluzione ma semplicemente dire la verità. Lo studioso non può essere condizionato dal relativismo secondo il quale tutto può essere affermato e che, pertanto, non esiste una verità. Non può rinunciare al giudizio e giustificare ogni cosa in virtù del principio che i gruppi hanno cultura propria. Non deve essere vincolato da una fedeltà alla sua gente che gli fa pronunciare mezze verità o perpetuare vecchi canoni ideologici. Egli deve sottrarsi alle pressioni del pensiero comune e dire con coraggio quello che pensa.
In Calabria, purtroppo, sono pochi coloro che si propongono di analizzare criticamente la realtà. E ancora meno quelli che vogliono saperla. Essi sanno che chi dice il vero provoca spesso irritazione e collera, mentre chi si adatta a ciò che la gente vuole sentire è ascoltato e amato. Forse gli uomini non sopportano la verità scomoda avendo vissuto troppo tempo nell’inganno. Preferiscono essere consolati da una menzogna piuttosto che essere feriti da una verità. Evitano di fare i conti con la realtà e si accontentano di ritenere autentiche le verità che hanno ereditato.
Meglio esuli in patria che servi
L’appartenenza politica o ideologica degli intellettuali non ha costituito garanzia di verità. Orwell affermava che le ideologie sono un veleno per la letteratura e, se proprio uno scrittore dovesse appassionarsi alla politica, dovrebbe farlo come cittadino. Gli intellettuali devono fare gli intellettuali, ricercare la verità senza subire condizionamenti, esercitare la critica demistificatrice della realtà nella ricerca del vero e contribuire, in quanto cittadino, a vivere in un mondo più giusto e più bello.

Chi vuole perseguire la verità deve rifiutare qualsiasi interferenza esterna, essere imparziale ed oggettivo. Non farsi condizionare dalle proprie simpatie, non avere preoccupazioni politiche, apologetiche o polemiche. Lo studioso deve correre il rischio di essere isolato e criticato, costretto ad abbandonare la sua terra o restarci a vivere come se fosse in esilio. L’esilio in patria è una condizione di dolorosa solitudine. Ma sempre preferibile a una socialità superficiale e tranquillità servile.