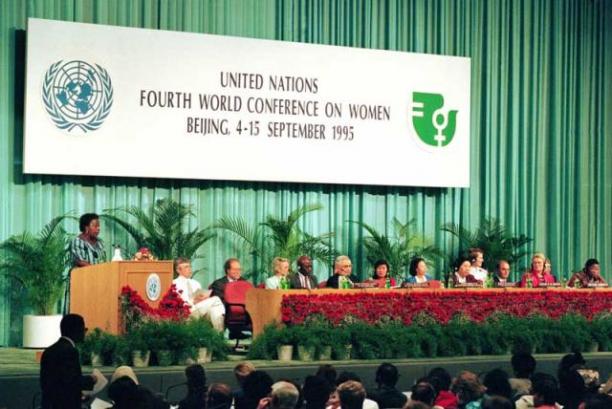Nel frastuono assordante della guerra e nel pianto silente di chi ha perso tutto, un dibattito tormentato scuote le coscienze all’interno di Israele. Dalle aule universitarie e dai centri di ricerca, voci accademiche si levano per confrontarsi con una delle questioni più angoscianti del nostro tempo: l’ipotesi di genocidio nei confronti del popolo palestinese. È una discussione che lacera, che costringe a guardare in faccia verità scomode, avvolta nel pesante sudario del dolore per le vittime innocenti, sia israeliane che palestinesi. Gli eventi del 7 ottobre 2023 hanno inferto una ferita profonda, riaccendendo antiche paure e inaugurando nuovi orrori, rendendo ancora più urgente la necessità di comprendere e analizzare.
Anche dentro Israele si comincia a parlare di “genocidio” in Palestina
All’interno del mondo accademico israeliano, le posizioni divergono radicalmente. Un numero significativo di studiosi, inclusi noti “Nuovi Storici”, non esita a parlare di “genocidio”, “pulizia etnica” o di “aspetti genocidari” nelle azioni di Israele in Palestina. Tra questi, Ilan Pappé sostiene da tempo che nel 1948 sia avvenuta una “pulizia etnica” della Palestina, introducendo già nel 2006 il concetto di “genocidio incrementale” per descrivere le politiche successive di Israele. Vede negli eventi attuali la continuazione di una logica eliminazionista. Anche Avi Shlaim, altro influente Nuovo Storico, definisce le azioni israeliane a Gaza “pulizia etnica e genocidio”, inquadrandole in decenni di occupazione e nelle ripercussioni della Nakba del 1948. Per Shlaim, il blocco degli aiuti umanitari a Gaza, unitamente alle “dichiarazioni genocidarie di leader israeliani e alla vastità delle vittime”, ha rappresentato un punto di svolta.

Studiosi israeliani lanciano l’allarme
Omer Bartov, stimato studioso dell’Olocausto, si è espresso a favore dell’applicazione del termine “genocidio” a Gaza), citando “la scala delle uccisioni e mutilazioni, e l’imposizione deliberata di condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica”. Bartov critica l’uso “perverso” della memoria dell’Olocausto per giustificare tali azioni, affermando che la mentalità osservata in alcuni soldati israeliani a Gaza gli ricordava quella dei soldati della Wehrmacht in Russia. Presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, Amos Goldberg, anch’egli studioso dell’Olocausto, ha dichiarato esplicitamente: Sì, questo è genocidio” riguardo a Gaza. Sostiene che non sia necessario un paragone con Auschwitz per parlare di genocidio, indicando come prove “la completa distruzione di Gaza, le uccisioni indiscriminate, la carestia deliberata e l’annientamento delle élite” ed evidenziando “un’atmosfera radicale di disumanizzazione dei palestinesi” nella società israeliana.
Il suo collega, lo storico dell’Olocausto Daniel Blatman, rincara la dose, affermando che Israele sta “bombardando a morte bambini affamati” a Gaza e definendo il “Piano dei Generali” israeliano “un terribile crimine di guerra che spazia dalla pulizia etnica al genocidio”. Raz Segal, studioso di genocidio, è stato tra i primi a etichettare la guerra di Israele a Gaza come un “caso da manuale di genocidio“, basandosi sulle dichiarazioni di funzionari israeliani e su atti come uccisioni di massa e politiche di affamamento.

Negare il genocidio di Israele in Palestina
Diametralmente opposta è la posizione di un altro gruppo di accademici, che contesta fermamente l’etichetta di genocidio. La loro analisi si fonda spesso su un’interpretazione legale restrittiva della Convenzione sul Genocidio del 1948, la quale richiede la prova di un “intento specifico” (dolus specialis) di distruggere un gruppo in quanto tale. Molti sostengono che, per quanto distruttive, le azioni di Israele manchino di questo intento specifico e che le dichiarazioni ufficiali possano essere interpretate diversamente. Un argomento frequente è che la campagna militare israeliana miri ad Hamas, e non al popolo palestinese nel suo complesso, e vengono citati gli sforzi per minimizzare i danni ai civili come prova contraria a un intento distruttivo.
Alcuni, pur ammettendo la possibilità di crimini di guerra, li distinguono nettamente dal genocidio. Israel W. Charny, ad esempio, considera le azioni di Hamas del 7 ottobre come “genocidio” e la risposta di Israele come “guerra” con molte vittime civili, suggerendo che Israele debba evitare un “picco genocidario”. Il professore di diritto internazionale Amichai Cohen, pur riconoscendo la “retorica odiosa proveniente da Israele” come un “punto debole”, ritiene problematica l’accusa di genocidio, suggerendo che le azioni di Israele possano essere spiegate da ragioni tattiche o strategiche.

Lo spettro dell’Olocausto incombe sul dibattito
L’ombra dell’Olocausto si proietta in modo complesso e doloroso su questo dibattito. Per studiosi come Bartov e Goldberg, la sua memoria è un monito universale: il “mai più” deve applicarsi a tutti, e le atrocità subite non possono giustificare l’inflizione di nuove sofferenze. Essi vedono nell’orrore del passato un imperativo etico a denunciare la disumanizzazione. Altri, invece, e più diffusamente nel discorso pubblico israeliano, invocano l’unicità dell’Olocausto per sostenere che le azioni di Israele non possono essere genocidarie, una prospettiva contestata da chi, come Goldberg, ribadisce che “Gaza non ha bisogno di essere Auschwitz per essere genocidio“.
Le voci critiche vengono censurate
Il contesto istituzionale in cui questo dibattito si svolge è tutt’altro che sereno. Pesanti accuse di “complicità istituzionale” delle università israeliane con le politiche statali e militari emergono da più fronti. Si descrive un ambiente in cui il “nazionalismo” sarebbe diventato l’”unico punto di riferimento”, limitando il pensiero critico e la discussione sulla sofferenza palestinese, spesso liquidata come “danno collaterale inevitabile”. La libertà accademica appare sotto forte pressione, con numerosi casi documentati di docenti e studenti, soprattutto palestinesi, sottoposti a procedimenti disciplinari, sospensioni e persino arresti per aver espresso posizioni critiche. Figure come la professoressa Nadera Shalhoub-Kevorkian, sospesa dall’Università Ebraica per aver definito la guerra a Gaza un genocidio, e la professoressa Nurit Peled-Elhanan, sospesa per aver fatto riferimenti alla violenza coloniale, sono diventate emblematiche di un clima che scoraggia il dissenso. Nonostante ciò, voci critiche continuano a farsi sentire, sia individualmente sia attraverso iniziative collettive.

In questo scenario straziato, è fondamentale ribadire che ogni vita spezzata, ogni sogno infranto, ogni lacrima versata, da qualunque parte provenga, rappresenta una tragedia immane. L’empatia non può conoscere confini. La sofferenza dei civili palestinesi a Gaza, sotto i bombardamenti, privati di beni essenziali, è un grido che interpella la coscienza del mondo, così come il dolore delle famiglie israeliane colpite dagli attacchi del 7 ottobre e l’angoscia per gli ostaggi meritano ascolto e profondo rispetto.
La pace giusta necessaria ma lontana
Il cammino verso una pace giusta appare oggi più impervio che mai. Tuttavia, nel coraggio di chi, anche all’interno della società israeliana, osa interrogarsi, criticare e sfidare le narrazioni dominanti, si può forse scorgere un barlume di speranza. Ascoltare queste voci, comprendere la complessità delle loro argomentazioni e riconoscere il peso del loro tormento è un passo necessario per chiunque voglia tentare di navigare questo doloroso abisso, nella speranza che un giorno si possa spezzare la spirale di violenza e costruire un futuro in cui il “mai più” sia davvero una promessa universale.
Tommaso Scicchitano