«Non è stato semplice. Operazione importante, impegnativa e coraggiosa, sotto diversi punti di vista». Patrizia Nardi, storica, già docente universitaria della Facoltà di Scienze Politiche di Messina, già assessore alla cultura del Comune di Reggio Calabria e focal point per l’Unesco della Rete delle Grandi Macchine a spalla italiane è appena rientrata dalla Palestina dove, a Betlemme, lo scorso 4 aprile 2023 ha inaugurato la mostra internazionale Machines for Peace. Un’iniziativa importante realizzata in sinergia con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, con il patrocinio della Farnesina, della Commissione Nazionale Italiana UNESCO e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. Dalla sua voce traspaiono soddisfazione, stanchezza e quella consapevolezza per una missione di pace che è il suo senso dell’operare nella Storia.
Perché organizzare una mostra del genere?
«Il 2023 segna per noi una data importante: è il decennale del riconoscimento UNESCO che coincide con il ventennale della Convenzione UNESCO 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Immateriale, ossia di quelle espressioni culturali, dei processi e dei saperi trasmessi e ricreati da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, all’interazione con la natura e alla loro storia. Era necessario dare un segnale importante, concreto, di testimonianza praticata. Per questo ho proposto alla grande comunità della rete – 36 associazioni e 4 amministrazioni comunali, Viterbo, Nola, Palmi e Sassari – di aggiungere alle attività ordinarie un focus specifico sul tema della pace che è una delle missioni, forse la più importante per cui è nata UNESCO dopo la seconda guerra mondiale: indurre comunità, gruppi, individui e nazioni a parlarsi e dialogare partendo dal patrimonio culturale come luogo per ricomporre i conflitti».
La guerra in questi mesi è su tutti i media…
«A maggior ragione oggi, con il conflitto ucraino in Europa e un rischio sempre maggiore di escalation, il tema della pace bussa, se mai ce ne fosse bisogno, con maggiore urgenza. Per questo abbiamo coinvolto tanti soggetti, pubblici e privati: l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, i Comuni, le Diocesi e Arcidiocesi delle Città della Rete, la Federazione Nazionale dei Club per l’UNESCO, Rotary International, FRACH – Fellowship of Rotarians who Appreciate Culturale Heritage, Meraviglia Italiana».
Raccontaci questo percorso
«A settembre scorso, in occasione del trasporto della Macchina di Santa Rosa – che celebra la traslazione del corpo della patrona di Viterbo avvenuta il 4 settembre 1258 per volere di Alessandro IV – abbiamo organizzato nella Città dei Papi un grande concerto coinvolgendo musicisti e cantanti dei Teatri dell’Opera di Leopoli, Odessa e Kiev: un evento partecipatissimo, oltre mille persone presenti. Quei musicisti straordinari, sofferenti e dignitosi al tempo stesso, suonavano il loro dramma davanti a noi, come abbiamo visto fare al coro dell’opera di Odessa riunitosi all’aperto per intonare l’inno nazionale ucraino.
Un modo esplicito per parlare alla comunità internazionale attraverso la musica, linguaggio universale per antonomasia. In quel momento ho pensato che la Rete delle Grandi Macchine potesse e dovesse continuare a dare un contributo concreto schierandosi contro tutti i conflitti: Macchine di pace contro macchine da guerra».
Che risposta c’è stata?
«La Rete ha molto sostenuto il progetto, fin dall’inizio: una mostra da portare nei luoghi di guerra, a partire dalla Terra Santa, per lanciare un messaggio di pace, forte e chiaro. Un Patrimonio Unesco ha il dovere di farlo e la partnership istituzionale è fondamentale. Le trattative erano state lunghe e complicate: avevamo avviato lo scorso ottobre l’interlocuzione con il Comune di Bethlehem per ricevere l’adesione solo il 20 febbraio successivo. Abbiamo organizzato tutto in poco più di un mese, pancia a terra potrei dire, costruendo una rete di cooperazione anche professionale molto significativa: abbiamo operato contemporaneamente con il team di ICPI, la OpenLab Company e il partner palestinese Iprint».
Altri aiuti?
«Abbiamo avuto il sostegno tecnico dei Comuni di Sassari e Viterbo e delle comunità della Rete, che sono venute in Terra Santa insieme a me. Senza di loro il progetto non avrebbe avuto la stessa valenza, progettare è un conto, condividere con gli stakeholder un altro ed ė un atto dovuto. E, chiaramente, fondamentale ė stato il lavoro di squadra ministeriale, la sinergia costante con il Gabinetto del ministro degli Esteri Tajani e la collaborazione con la nostra straordinaria rete diplomatica: Commissione Unesco, Rappresentanza Unesco a Parigi, Ambasciata di Tel Aviv, Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. Quando arrivai in riunione, la prima volta qualche giorno dopo l’ok da Bethlehem, rimasi stupita. Mi sarei aspettata più una riunione tecnica che una mobilitazione generale e questo mi ha molto incoraggiata, devo dire».

Potremmo dire che il governo ha avuto l’opportunità di cogliere un’occasione importante: il Mediterraneo in generale (e il Mediterraneo allargato, più specificamente) tornano ad essere centrali per la politica estera italiana.
«L’Italia lavora da diversi anni a sostenere l’obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese nella logica dei “due popoli, due stati”, sostenendo i negoziati di pace tra le parti: un ritorno a linee di politica estera che possano contribuire a costruire la pace in territori in cui la tensione ė continua e tangibile non può che essere considerato un fatto importante. Il conflitto ucraino ha saldamente posizionato il Paese in assetto atlantista, come mai accaduto prima dello scorso anno; e la guerra, con le sue priorità per la diversificazione di approvvigionamento energetico, combinata con le pressioni migratorie, impone la necessità di tornare alla vocazione naturale italiana: snodo centrale e madre del Mediterraneo, una responsabilità dalla quale, nel bene e nel male, non possiamo esimerci. Tajani ne è consapevole e la sua missione nello scorso marzo in Israele e Palestina è un segnale che va interpretato in un certo modo».
Mi stai dicendo che la cultura è il guanto di velluto della diplomazia?
«Avvicinare, far dialogare, fare cooperare comunità e soggetti istituzionali è il primo obiettivo dell’agenzia dell’ONU. La diplomazia culturale è strettamente connessa alla diplomazia politica e deve avvalersi di molti strumenti e altrettante strategie, specie in contesti complessi come quello palestinese, dove un conflitto che va avanti da oltre settant’anni anni ha creato comunità che vivono quotidianamente la divisione come parte integrante e quasi connaturata alla loro vita, con un mondo che sembra essersi girato dall’altra parte. Ma la missione della nostra delegazione non è passata inosservata».
In che senso?
«Le date scelte non sono state casuali. Abbiamo individuato il periodo della Pasqua, anzi delle “Pasque” che hanno radice comune, per il nostro messaggio di pace. La Pasqua cristiana, quella ebraica e l’ortodossa quest’anno, per l’insolito allineamento di calendario, hanno assunto un significato ecumenico di notevole importanza e un ulteriore invito al dialogo tra le religioni e le comunità. Purtroppo determinate ricorrenze vengono “utilizzate” anche nel male. Fino al martedì 4 aprile la situazione appariva tranquilla. Poi è precipitata. Il 5 era previsto un nostro incontro con gli studenti dell’Università di Bethlehem alla fine saltato per ragioni di sicurezza. Il 6 è iniziata l’escalation: la pioggia di missili, l’auto lanciata contro un gruppo di turisti proprio vicino all’ambasciata italiana di Tel Aviv, a trenta metri da dove si trovava l’ultimo gruppo della nostra delegazione, con le conseguenze che tutti conosciamo».
Avete percepito il pericolo?
«Si, anche per l’aumento dei controlli ordinari, particolarmente accurati anche in aeroporto. Una “normalità” che si è presentata a noi in maniera molto cruda, difficile da capire per chi non vive la quotidianità dell’emergenza».

Una mostra virtuale, un “affresco digitale”. Non avete trasferito nulla, ma avete trasferito tutto…
«Proprio così. Grazie alla tecnologia abbiamo scomposto, trasportato e ricomposto le feste di Nola, Sassari, Palmi e Viterbo, la coralità delle stesse, il significato che quella coralità assume in un processo di costruzione di ponti e di dialoghi di pace. Il film di Francesco De Melis – che abbiamo girato durante il lockdown per testimoniare il rischio della sparizione dei patrimoni immateriali in contesti di crisi riportando nelle città vuote, sui palazzi, sulle chiese, la musicalità e le immagini delle feste – fa scorrere le sue sequenze su un enorme spazio di proiezione di 16 metri».
Che effetto crea nello spettatore?
«Si entra nelle feste, nel Bethlehem Peace Center, a due passi dalla Natività e ci si trova in un’altra dimensione, accompagnati da 13 figuranti nei loro magnifici costumi “di scena” festiva, che dialogano con la maestosa testa-scultura che Giuseppe Fata ha dedicato al tema della mostra, nel contesto del progetto Simulacrum. Una circolarità di sensazioni, idee, progetti, competenze, solidarietà che hanno prodotto un miracolo».
Sei soddisfatta?
La pace si coltiva e si pratica nel lavoro quotidiano, non credo bastino più le teorizzazioni, i cortei e le bandiere. Aiutano, ma non bastano. Essere operatori di pace è una grande responsabilità e le “mie” comunità della Rete lo hanno capito bene. Se devo parlare di soddisfazione, beh, questo può essere sufficiente. Non possiamo voltarci dall’altra parte, né far finta che niente succeda: questo vale per tutti i conflitti e soprattutto per le comunità che ne restano vittime fisiche, sociali, economiche. Quel muro, immanente e imminente, che divide la Cisgiordania parla anche a chi si rifiuta ancora di ascoltarlo».
Le prossime tappe dopo Betlemme?
«La mostra resterà a Betlemme fino a maggio. Poi alcune tappe europee, tra cui Praga e Parigi e dove sarà necessario portare il nostro messaggio di pace, fino al 2024. In più, oltre ad alcune città italiane, ci sono situazioni in progress che stiamo monitorando, di cui daremo notizia al momento opportuno».
Cosa ti porti indietro da questa esperienza?
«La consapevolezza di avere dato il mio contributo e di aver incoraggiato la Rete a dare il suo, in un momento particolarmente difficile; l’aver lavorato con tantissime persone, le mie comunità, il mediatore Giorgio Andrian, il mio straordinario co-curatore Taisir Masrieh Hasbun e il team palestinese di IPrint, con OpenLab, la vicinanza di tutti. Di aver dato un contributo con i mezzi che mi sono propri e congeniali. Non dimenticherò le preghiere all’alba del muezzin dal minareto, l’avere la percezione che quella Terra continui ad essere il centro del mondo. E non dimenticherò un piccolo bambino, che accompagnava il suo papà autista di un nostro transfer: un piccolo bambino vivacissimo, un bimbo in trincea, le cui prospettive sono ben lontane da quelle di un mondo forse anche fin troppo dorato e fasullo, come a volte sembrerebbe essere il “nostro”».

































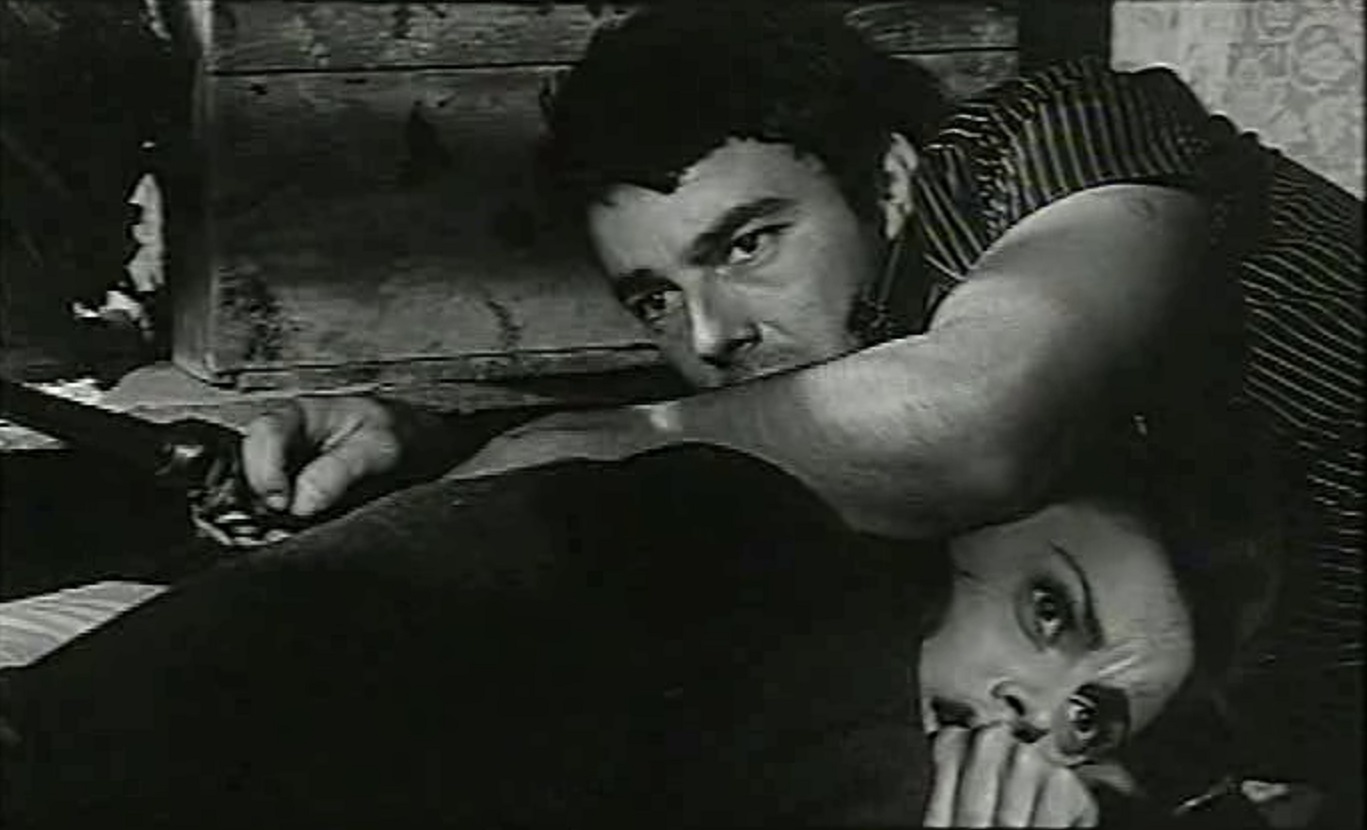






































 Questo articolo fa parte di un progetto socio-culturale finanziato dalla “Fondazione Attilio e Elena Giuliani ETS”. L’impegno de I Calabresi e della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani è quello di arare il terreno della memoria collettiva e trovare le radici da cui proveniamo per riscoprire la fierezza di una appartenenza.
Questo articolo fa parte di un progetto socio-culturale finanziato dalla “Fondazione Attilio e Elena Giuliani ETS”. L’impegno de I Calabresi e della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani è quello di arare il terreno della memoria collettiva e trovare le radici da cui proveniamo per riscoprire la fierezza di una appartenenza.