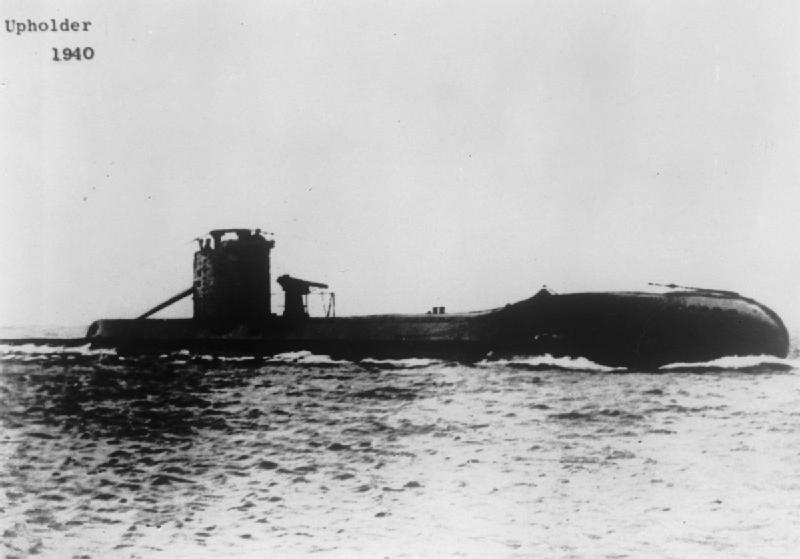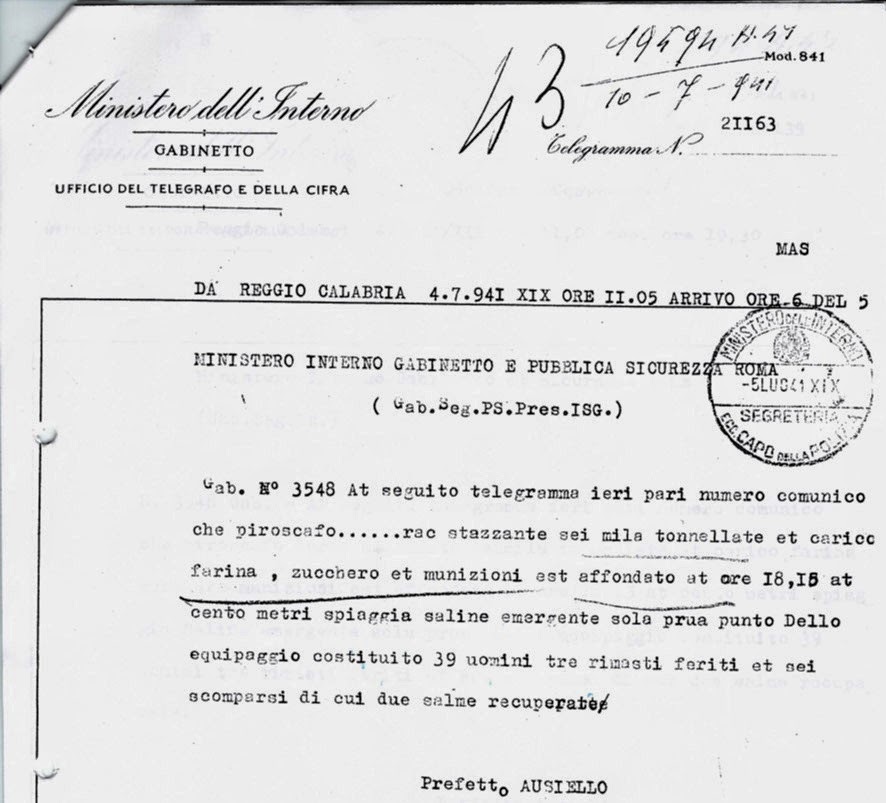Da quattordici anni a questa parte, la Germania e l’Europa sembrano aver imparato molto poco nel contrasto al crimine organizzato. Eppure, la strage di Duisburg fece “scoprire” a tutto il Vecchio Continente la presenza oppressiva, pericolosa, sanguinaria della ‘ndrangheta.
Scorre il sangue a Duisburg
È la notte tra il 14 e il 15 agosto del 2007 quando sul suolo tedesco, a Duisburg, restano sull’asfalto in sei. Davanti al ristorante italiano ”Da Bruno” nell’inferno di piombo rimasero uccisi Tommaso Venturi che aveva appena compiuto 18 anni, i fratelli Francesco e Marco Pergola di 22 e 20 anni, Francesco Giorgi appena 17enne, Marco Marmo di 25 anni, e Sebastiano Strangio di 39 anni.
Secondo quanto accertato dagli investigatori, quella sera nel ristorante non era stato soltanto festeggiato il compleanno di Venturi. Ma anche la sua ammissione nella ‘ndrangheta, avvenuta con la maggiore età. La cerimonia della “copiata”, conclusa, come da tradizione, con il giuramento proferito dal nuovo accolito mentre si lascia bruciare tra le mani un’immaginetta sacra. Il santino di San Michele Arcangelo, ritrovato proprio addosso a al 18enne Venturi. Vengono falciati da oltre 70 colpi. Tra cui, quello finale, alla testa.

Un eccidio che, nel corso degli anni, gli inquirenti calabresi ricostruiranno, portando a condanne definitive. Tra cui quella di Giovanni Strangio, punito col carcere a vita perché considerato la mente del commando entrato in azione nel giorno di Ferragosto. Strangio verrà arrestato il 12 marzo del 2009 in Olanda, a Diemen, piccolo centro vicino ad Amsterdam.
Una scia di sangue iniziata nel 1991
Una mattanza che la vulgata fa iniziare con un banale scherzo di trent’anni fa, protraendosi però, con una lunghissima scia di sangue, per decenni tra le famiglie contrapposte Pelle-Vottari e Nirta-Strangio. Quel massacro fece conoscere a tutti la pericolosità della ‘ndrangheta, che, da decenni, ha allungato i propri tentacoli in Germania, nei Paesi Bassi, in Francia, nel Regno Unito, in Svizzera, in Spagna e in Austria. In questi luoghi le ‘ndrine agiscono quasi del tutto indisturbate, con il traffico di droga e di autovetture. Ma anche con il riciclaggio di denaro attraverso aziende e locali. Forte la presenza di San Luca, con le famiglie Romeo-Pelle-Vottari e Nirta-Strangio. Ma anche i Farao-Marincola di Cirò (Crotone) e i Pesce-Bellocco di Rosarno (Reggio Calabria).
Una lunga scia di sangue nata con il lancio di uova tra famiglie “rivali” nel Carnevale del 1991. La violenza, nei mesi antecedenti a Duisburg, coinvolse il boss Francesco Pelle, in quel periodo 32enne, detto ‘Ciccio Pakistan’, che perse l’uso delle gambe in un agguato il 31 luglio 2006. Un tentato omicidio di cui si vendicò ordinando la strage di Natale del 2006 in cui morì una donna, Maria Strangio. Per errore. Il vero obiettivo, fallito dai sicari, era il marito Gianluca Nirta.
Gli uomini “cerniera”
Quella mattanza sul suolo tedesco sembra non aver insegnato nulla alla Germania e all’Europa. Le normative con cui i singoli Paesi contrastano il crimine organizzato continuano a essere inadeguate. E carenti anche i collegamenti investigativi tra Stati. Ma per le mafie non esistono confini. Soprattutto per la ‘ndrangheta. Nei mesi successivi alla strage di Duisburg si attiverà soprattutto l’Autorità Giudiziaria italiana: la Dda di Reggio Calabria chiuderà il cerchio con diversi tronconi dell’inchiesta “Fehida”.
Negli anni, il processo “Gotha” ha anche ricostruito (seppur con una sentenza di primo grado) le trame che seguirono quei mesi di sangue. Un contesto torbido in cui membri dell’Arma dei Carabinieri, del Ros, in particolare, sarebbero stati in contatto con uomini di ‘ndrangheta e soggetti “cerniera”. Patteggiando per arrestare alcuni latitanti.
I protagonisti sono l’avvocato Antonio Marra, considerato trait d’union tra lo Stato e le cosche, e l’ex parroco di San Luca e rettore del Santuario di Polsi, don Pino Strangio. Ambedue condannati in primo grado nel maxiprocesso “Gotha”. I due avrebbero svolto un ruolo di intermediazione, con l’accordo di alcuni ‘ndranghetisti di rango, per interloquire con canali ritenuti “non istituzionali”. Tutto al fine di acquisire notizie utili per la cattura di alcuni latitanti “sanlucoti”. In particolare Giovanni Strangio, poi arrestato dalla Polizia in Olanda.
Rapporto intenso quello tra Marra e don Strangio. I due avrebbero interloquito, talvolta in maniera equivoca e torbida, con alcuni membri del Ros dei Carabinieri. In quegli anni, almeno fino all’arrivo di Giuseppe Pignatone a capo della Procura di Reggio Calabria, funzionava in quel modo in riva allo Stretto. Marra e don Strangio sarebbero stati elementi di collegamento. Pedine di un sistema fatto di accordi, confidenze e soffiate e in cui si trovavano magistrati, ‘ndranghetisti, forze dell’ordine e membri dei servizi segreti.

La Trattativa Stato – ‘Ndrangheta
In una conversazione intercettata, don Pino Strangio fornisce a un appartenente del Ros i nominativi dei “sanlucoti” per i quali erano stati intrapresi determinati accordi per suo tramite. ‘Ndranghetisti che la Squadra Mobile identifica in Antonio Romeo, classe 1947, detto “Centocapelli” e considerato affiliato alla ‘ndrangheta di San Luca, in quel periodo detenuto a Parma; Antonio Romeo, classe 1957, detto “Il Gordo”, latitante a seguito dell’operazione denominata “Super Gordo” dai primi mesi del 2005, veniva tratto in arresto da personale del Commissariato di P.S. di Bovalino (RC) coadiuvato da personale del Commissariato di P.S. di Siderno (RC) in data 28.5.2008); Fortunato Giorgi, cognato di Romeo “Centocapelli” e inserito a pieno titolo nella consorteria dei Romeo alias “Stacchi”, legati a quella dei Pelle alias “Gambazza”.
I carabinieri che interloquirono con Marra e don Strangio negli anni finiranno pure sotto inchiesta. Ma alla fine otterranno un’archiviazione. Quello che il processo “Gotha” avrebbe dimostrato è il fatto che lo Stato avrebbe trattato per arrivare ad alcuni risultati investigativi che placassero la mattanza. Mettendo sul piatto della bilancia il trasferimento di carcere di alcuni detenuti.

In quegli anni, il Ros dei carabinieri aveva due anime. Una di queste credeva alla strategia secondo cui si dovesse attingere alle fonti confidenziali per arrivare ad alcuni risultati investigativi. Fonti che, quasi sempre, chiedono qualcosa in cambio. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero stati proprio i membri del Ros a contattare Marra per penetrare il territorio di San Luca. E per stringere il cerchio su alcuni latitanti. E poi il legale si sarebbe rivolto a don Pino Strangio. Il prete è, in quel periodo, rettore del Santuario della Madonna di Polsi. È, quindi, molto ben inserito sul territorio della Locride.
L’accordo salta
Marra e don Strangio avrebbero anche interloquito con alcuni magistrati. Anche se non si scoprirà mai il contenuto di tali interlocuzioni. Secondo le intercettazioni a carico dell’avvocato Antonio Marra si sarebbero anche tenuti degli incontri a San Luca. In quella sede sarebbero stati presi accordi con alcuni ‘ndranghetisti. Proponendo a essi vantaggi e favori in cambio di un aiuto per la cattura di alcuni latitanti. Tra cui, appunto, quella di Strangio.
Funzionava così. Del resto, lo testimoniano anche le indagini sul conto della famiglia Lo Giudice. Negli stessi anni, la cosca aveva rapporti privilegiati con forze dell’ordine e magistrati. Lo stesso avvocato Marra viene definito dai carabinieri che interloquivano con lui una fonte preziosa sul territorio. Nel doppiogioco tra Stato e ‘ndrangheta, evidentemente: «Aveva delle conoscenze…».
Nel post strage di Duisburg si tentò di fare lo stesso. Ma nel frattempo, in riva allo Stretto è arrivato il procuratore Giuseppe Pignatone. L’accordo salta, anche perché i carabinieri che avevano imbastito la trattativa subiscono il trasferimento. Marra non la prende benissimo, parlando al telefono con un altro membro dell’Arma, distaccato ai Servizi Segreti: «Ora sono in un mare di guai perché… per due cose, primo perché là ora, ora non so che cazzo dirgli di tutte le cose che siamo andati a dirgli, e a fare…eee… sembra poi che li abbiamo presi per il culo».
Così si conclude una trattativa, su cui, ancora, restano alcuni punti interrogativi: «A me non me ne fotte niente… cioè a dire io posso pure andare a san Luca a dirgli “guardate! sono una massa di buffoni, i soliti sbirri, dicono le cose e non le mantengono!».