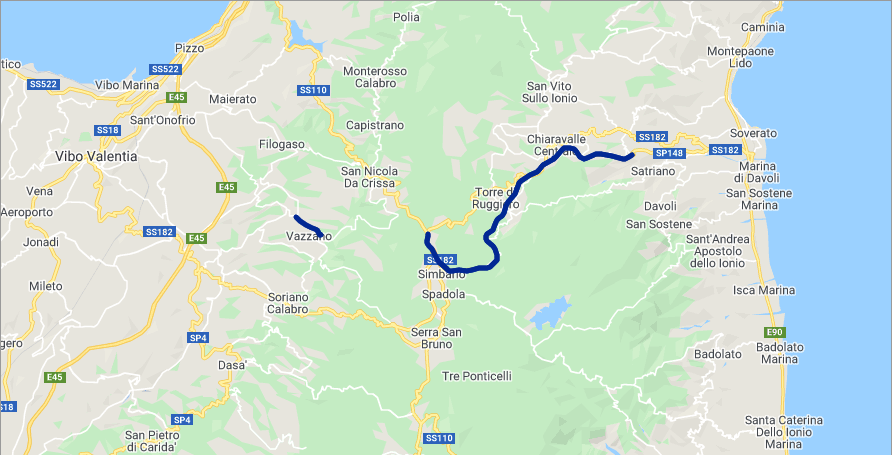Certamente canzoni del genere non le vedremo mai in corsa per la vittoria del Festival di Sanremo. Né i videoclip e i film che con esse si accompagnano rimarranno nella storia del cinema e della tecnica registica. Ma tutto si può dire tranne che non riscuotano successo. Sono quelle che, storicamente, vengono definite i “Canti di malavita”.
I canti di malavita
Negli anni si è passati da fisarmoniche e organetti, con ritmi che ammiccano alla tarantella calabrese, alle canzoni neomelodiche. E, soprattutto negli ultimi anni, alla musica rap e alla sua derivazione, la trap. Quel mix tra batteria cupa e sintetizzatori. E anche i supporti sono cambiati. Se un tempo, a Polsi, dove a inizio settembre si celebra la festa della Madonna della Montagna, le bancarelle che vendono i cd – e, in alcuni casi, persino le musicassette – con i “canti di malavita” sono tra le più diffuse, oggi questi capolavori li ritroviamo spesso su YouTube e sui social. Dove fanno il pieno di like e interazioni.
Ma il cliché è quello di sempre. E può essere assimilato ai corridos in voga nel Centro e nel Sud America, soprattutto negli ambienti legati al narcotraffico. Modelle, ballerine, cantanti, attrici. Insieme a soldi, auto di lusso (rigorosamente blindate), droga, alcolici e soldi. Tutto questo appare sempre in questi videoclip che circolano su internet e che fungono da vera e propria propaganda dei cartelli della droga. Qui, invece, gli “eroi” sono i boss, i carcerati, gli ergastolani. Nei corridos si ostenta la vita da nababbi dei narcos, mentre nei “canti di malavita”, ci si pone come uomini pii e devoti, vessati dai cattivi, da combattere e rifuggire: lo Stato e le forze dell’ordine (gli sbirri).
“Figli da gente”
L’ultimo brano in ordine di tempo si intitola Figli da gente ed è la colonna sonora dell’omonimo film, le cui riprese sono in corso in provincia di Crotone. Ma l’autore, il 24enne Tony Lena, fa ancora di più, unendo, a detta di taluni, due culture, come quella camorrista e quella ‘ndranghetista. L’autore, infatti è campano e la canzone immortalata in un videoclip che sta facendo il giro del web è in lingua napoletana. Ma viene citata espressamente Cirò Marina, nel Crotonese, strizzando l’occhio alla criminalità organizzata. Con capigliature, vestiti e atteggiamenti da guappi napoletani, i protagonisti tentano di conquistare l’ascoltatore. Il videoclip si snoda per le vie della località marittima, tra pistole, scene di spaccio e fughe rocambolesche proprio dagli “sbirri”.
Un videoclip che ha registrato migliaia di visualizzazioni su YouTube, prima di essere rimosso. Ma adesso è riapparso tramite un altro canale. Tutto è stato denunciato anche dalla senatrice del Gruppo Misto, Margherita Corrado. Ex esponente del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Parlamentare Antimafia, Corrado ha parlato di “pubblicità negativa”. Proprio la Commissione presieduta da Nicola Morra starebbe seguendo la vicenda. Peraltro, già da tempo è stato depositato un disegno di legge proprio per l’introduzione, nel codice penale, del delitto di istigazione e apologia della criminalità. Ma dal giugno 2020 giace arenata in Commissione Giustizia.
I testi delle canzoni
Già, perché si tratta di pura propaganda. Un po’ stantia, forse. Ma pur sempre propaganda. Anche Figli da gente non brilla per innovazione perché non si discosta troppo dai luoghi comuni propri della cultura criminale. Il riferimento è a una terra povera, con poche, pochissime, opportunità “Addò si campa ccù niente” recita la canzone. Per il paroliere, i “figli da gente” sono, infatti, quelli che “rischiano ‘a vita ppe chesta città, chi ha perso ‘nu pate, chi aspetta nu frate ca sta carcerato e vo turna’ ad abbraccia’”. Persone che vivono sempre sul filo, perché devono difendersi dai blitz delle forze dell’ordine: “Chi ‘a notte non duorme ‘ccu chella paura ca so vanno a piglia”. Tra un pensiero e l’altro per i carcerati, che, comunque, non vengono mai abbandonati dall’obolo delle cosche. Così come si raccontava, miticamente, in un’altra canzone di qualche tempo fa.
“Pe’ guagliune ‘e l’Aemilia”
Qualche mese fa, infatti, era emersa, altrettanto prepotentemente, la canzone Pe’ guagliune ‘e l’Aemilia, scritta proprio per dare conforto a chi era rimasto coinvolto in una delle inchieste più grandi sulla ‘ndrangheta al Nord. Il processo “Aemilia”, appunto. Scaturito dal blitz con cui i Carabinieri, nel gennaio 2015, arrestarono oltre 300 persone accusate di aver fatto parte di un’organizzazione criminale, capeggiata dal boss di Cutro – anche in questo caso in provincia di Crotone – Nicolino Grande Aracri. Che spadroneggiava su mezza Calabria, parte dell’Emilia e della Lombardia e aveva ramificazioni all’estero. In quel caso, l’idea fu del cantante neomelodico Gianni Live, che rilasciò il proprio brano e il proprio videoclip ancora una volta su YouTube. E, ancora una volta, fu un grande successo.
L’odio verso i pentiti
Se Figli da gente si concentra sulle sofferenze della detenzione, il testo del brano di Gianni Live è quasi totalmente incentrato sui pentiti, gli “infami” che, con le loro “cantate” inguaiano gli uomini d’onore. Che, ovviamente, nei testi sono sempre uomini giusti e retti, nonché mariti amorevoli e padri esemplari. Da sempre, gli “infami” e i “tragediatori” della ‘ndrangheta sono nel mirino. Ma con questi testi l’odio raggiunge livelli elevatissimi: “Nui ca ci mettimmu ‘o core dinta ‘e lettere… arret’ a ‘sti cancelli pensann’ ‘a liberta’” (Noi che mettiamo il cuore dentro le lettere… dietro a questi cancelli pensiamo alla libertà), quindi l’attacco al processo: “Ppe colpa d’u pentito nui stamm’a pava’… int’a stu processo Aemilia ‘ncuollo a nui hanno raccuntato nu par ‘e strunzate… c’hanno cundannat’” (Per colpa di un pentito noi stiamo pagando dentro a questo processo Aemilia addosso a noi hanno raccontato un paio di stronzate ci hanno condannato”).
I tempi cambiano?
Negli affari e nel modo di relazionarsi con il potere, la ‘ndrangheta cambia ed evolve continuamente. Per quanto concerne i riti e le tradizioni, invece, resta sempre simile a se stessa. Sono passati quasi vent’anni dai fatti cristallizzati nell’inchiesta “Pettirosso”, condotta contro la cosca Bellocco, una delle famiglie più potenti della ‘ndrangheta. In quell’indagine è possibile rintracciare e leggere un componimento dedicato al boss Gregorio Bellocco. Una canzone dal titolo eloquente – “Circondatu” – che è il racconto di una fuga, avvenuta nel 2003, allorquando i carabinieri fanno irruzione in un bunker situato ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Al momento dell’arresto, due anni dopo rispetto all’epico racconto, il ritrovamento all’interno del covo di un compact disk dal titolo “Penzeri di nù latitanti”.
Oltre il business
Raramente si tratta di denaro. Dietro queste opere c’è quasi sempre un aspetto ideologico. Quasi pedagogico del crimine. Anche se alcuni anni fa, due persone sono state anche condannate dal Tribunale di Reggio Calabria per le minacce agli attivisti dell’ex Museo della ‘Ndrangheta (oggi Osservatorio sulla ‘ndrangheta), che da anni ha una sede in un immobile confiscato alle cosche e si muove come un avamposto di aggregazione in un quartiere periferico e degradato.
Nel maggio 2012 i due si sarebbero presentati presso la sede del Museo dichiarandosi “autore” e “manager-produttore” dei cd “I canti di malavita” per chiedere maggiori informazioni sull’utilizzo che il Museo della ‘ndrangheta fa delle canzoni all’interno di laboratori didattici per lo studio del linguaggio della ‘ndrangheta. Rivendicavano, con minacce i propri diritti d’autore per l’uso delle loro opere. Hanno trovato solo una denuncia e una condanna.
Il menestrello Otello Profazio
I tempi, allora, forse non cambiano. In un’altra inchiesta contro le cosche di ‘ndrangheta, denominata “All inside”, emerse come gli uomini e le donne della famiglia Pesce, appartenente al gotha della criminalità organizzata calabrese, comunicassero con i detenuti (ricevendo anche messaggi dagli stessi) attraverso la trasmissione di determinate canzoni. E, allora, più le cose cambiano, più restano le stesse. Forse non saranno più gli strumenti musicali, le grida, i rumori di Polsi, tra tarantelle, organetti, tamburelli sotto l’egida di un “mastru i ballu”. Ma questi “canti di malavita” continuano ad avere quel ruolo di sempre.

Anche una canzone popolare, intitolata “Ndrangheta, Camorra e Mafia”, scritta e interpretata dal cantautore Otello Profazio, assai noto a Reggio Calabria e nella sua provincia, pone grande risalto sulla meticolosità con cui, negli anni, siano state approntate le regole su cui si basa gran parte della forza della ‘ndrangheta: “Lavuraru trint’anni sutta terra, pi fondari li reguli sociali, leggi d’onori di sangu e di guerra leggi maggiori, minori e criminali…” (traduzione: “Hanno lavorato trent’anni sotto terra, per fondare le regole sociali, leggi d’onore di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali”).
Canzoni e valori popolari
La forza della ‘ndrangheta, dunque, si è sempre manifestata nella sua eccellente capacità di strumentalizzare valori popolari in cui chiunque, anche il personaggio più lontano, geograficamente e ideologicamente, dalle cosche e dalla mentalità mafiosa. Una peculiarità che non è sfuggita all’antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani: «I valori che la mafia dice di avere sono quelli della dignità individuale, dell’onore, del rispetto della “parola”: una serie di valori analoghi a quelli della cultura popolare. Il problema è che, mentre i valori della cultura popolare sono realmente perseguiti, voluti, come forme di autorealizzazione, i valori mafiosi sono “detti” per acquisire consenso, e vengono vissuti in maniera però truffaldina, perché servono per coprire il comportamento violento». E anche la musica, in questo senso, svolge un ruolo fondamentale. Come una formula di iniziazione o celebrativa, con titoli emblematici come Sangu chiama sangu, I cunfirenti, Omertà, Cu sgarra paga, Appartegnu all’onorata, Ergastulanu, Mafia leggi d’onuri. Forse non ascolteremo nemmeno queste al Festival di Sanremo…