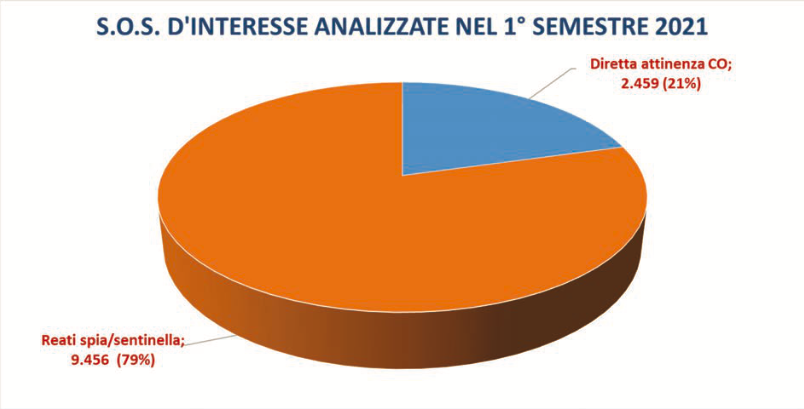[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Il 21 aprile scorso, sui canali della Australian Broadcasting Corporation (ABC) per il programma Foreign Correspondent è andato in onda The Magistrate vs The Mob (Il Magistrato contro la Mafia), un documentario di 30 minuti sul maxiprocesso Rinascita-Scott. Preceduto da un articolo che ne delinea il contenuto, e con la professionalità che contraddistingue il programma e in particolare le produttrici di questo episodio, il documentario spalanca all’Australia le porte del Vibonese e della sua ‘ndrangheta ora a processo.
Rinascita-Scott, il documentario australiano
Con immagini mozzafiato catturate da un drone su Tropea e Capo Vaticano, per poi aggiungerci lunghe riprese su Vibo Valentia città, sulle campagne intorno a Limbadi, sui vicoli di Nicotera, l’episodio inizia dicendo «la Calabria è una terra di feroce bellezza». Il resto del documentario vede riprese a Catanzaro, con il procuratore capo Nicola Gratteri, a cui il maxiprocesso è notoriamente legato, nell’aula bunker di Lamezia Terme, costruita appositamente per Rinascita-Scott, e sul resto del territorio per incontrare vittime di poteri e soprusi mafiosi e anche ovviamente mostrare quella resistenza civile che, seppure ancora ai primi passi, dopo Rinascita-Scott si è sicuramente formata. Il risultato sono 30 minuti godibili, con belle immagini e note emotive, e anche, prevedibilmente, una serie di commenti stereotipati sui rapporti tra mafia e territorio.
L’equivoco iniziale e il piano B
Sono stata invitata a fornire una consulenza per il programma nel gennaio scorso. L’interesse dell’Australia per la ‘ndrangheta non è certo cosa nuova, visto che il paese conosce il fenomeno mafioso calabrese da quasi un secolo e – a volte con più serietà, a volte con molta meno attenzione – fa i conti con una ‘ndrangheta locale dalle molte sfaccettature. Ma i produttori non mi avevano contattato per la ‘ndrangheta australiana, bensì per Rinascita-Scott. «Ci sono dei collegamenti con l’Australia?», mi chiesero. Cercavano un aggancio alla loro ‘ndrangheta, che però in questo processo non c’è – o se c’è non appare affatto chiaro.

Dopo aver precisato che questa era un’altra ‘ndrangheta – vale a dire un processo sulle dinamiche di clan mafiosi del Vibonese – che per quanto collegati alla ‘ndrangheta reggina, preponderante in Australia, non guardava precipuamente a queste connessioni – il programma è stato virato sul territorio ‘straniero’, sul processo, sul procuratore Gratteri (come rivela già il titolo), con buona pace della ‘ndrangheta australiana.
Rinascita-Scott: Italia vs Resto del Mondo
Questo documentario è l’ultimo di una lunga serie di articoli, video, interviste, reportage, che svariate televisioni e testate giornalistiche straniere hanno dedicato a Rinascita-Scott dal 13 gennaio 2021 quando il processo è formalmente iniziato. Decine di notiziari, in inglese, francese, tedesco, turco, spagnolo, portoghese. Anche dopo il gennaio 2021 l’interesse è rimasto alto, basti pensare al reportage di France24 titolato ‘A trial for the history books (Un processo per i libri di storia) del gennaio 2022.
Al contrario, sui giornali o sui canali di informazione italiani, a parte qualche notevolissima eccezione (pensiamo alla puntata di Presadiretta nel marzo 2021 dedicata al maxiprocesso), gli articoli si limitano primariamente alla cronaca, raramente sul nazionale, molto più spesso sul locale. Ed ecco che per alcuni l’interesse della stampa internazionale al processo è segno incontrovertibile che all’estero prendono sul serio l’antimafia e riconoscono il carattere destabilizzante di Rinascita-Scott, mentre in Italia questo non accade.
La retorica su Gratteri
Alcune malelingue poi mettono il carico da novanta, riconducendo il disinteresse italiano al processo (comparato all’attenzione dall’estero) a implicite prese di posizione ‘pro-Gratteri’ o ‘contro-Gratteri’. È questa una retorica di pessimo gusto, perché ovviamente non può e non deve esistere uno spazio del ‘contro-Gratteri’ in questo contesto, essendo il procuratore un bravo magistrato, al pari di tanti altri suoi colleghi, avendo egli la capacità (per alcuni il demerito) di dare alle istituzioni calabresi molta visibilità. Ma soprattutto un processo non si identifica mai con il Procuratore Capo della Procura che l’ha istruito. Specie questo processo che di procuratori, magistrati, funzionari, avvocati e, soprattutto imputati, ne ha davvero tanti.
Quei maxiprocessi tutti italiani
La domanda però sorge spontanea: qual è la ragione dei riflettori puntati dall’estero sul processo Rinascita-Scott, a confronto di un interesse molto più scarso in Italia? La risposta non è semplice; possiamo scomporla in quattro diverse componenti, tecniche e culturali.

Una prima componente sono i numeri e le caratteristiche del processo. Sicuramente vedere un processo con oltre 350 imputati, dozzine di avvocati, decine di collaboratori di giustizia, al punto da dover costruire un’aula bunker ad-hoc per contenerli tutti, non è spettacolo quotidiano. E uso appositamente la parola ‘spettacolo’. Se per l’Italia questo non è il primo né l’unico processo di grandi dimensioni – anche dopo il maxiprocesso di Palermo infatti ricordiamo Crimine-Infinito, Aemilia e altri processi con oltre 100 imputati – fuori dall’Italia questi numeri sono molto inusuali, se non impossibili, in un’aula di giustizia.
La giustizia si fa spettacolo
La giustizia (altrui, cioè la nostra in questo caso) si fa dunque spettacolo proprio per questo profilo di straordinarietà. Non scordiamoci poi che in molte giurisdizioni non esiste l’istituto per noi costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione legale. Soprattutto nei sistemi anglosassoni il pubblico ministero va a processo quando ha una quasi certezza di vittoria dell’accusa (altrimenti si patteggia o si archivia per mancanza di prove o per assenza di ‘interesse pubblico), per questo nel 90% dei casi vince e ottiene condanne.
La tortuosità del sistema italiano, con processi abbreviati, ordinari, appelli, controappelli, rende difficile raccontare i processi, perché appunto non si sa come andranno a finire, se l’accusa reggerà oppure no, e di solito si dovranno aspettare molti anni per saperlo. Ma in questo caso il processo si può spettacolarizzare e non solo raccontare, e questo è più facile per gli stranieri che per noi italiani.
L’eroe contro l’antieroe: Gratteri e Mancuso
Una seconda componente è la simbologia della classica contrapposizione tra l’eroe e l’antieroe, e conseguente glorificazione del primo e dannazione del secondo. Non è un caso che i media esteri si focalizzino sul procuratore Gratteri. Come non è un caso che alcuni media italiani chiamino in causa quella retorica pro-Gratteri/contro-Gratteri di cui sopra. Sicuramente il procuratore capo di Catanzaro è l’incarnazione simbolica dell’antimafia in Calabria (e oltre), anche perché il suo lavoro è sempre stato diffusamente presentato al pubblico, oltre che nella sua attività di magistrato inquirente, anche a seguito del suo intenso impegno quale autore di libri e protagonista di interventi, dibattiti pubblici, eventi. Ciò favorisce la spettacolarizzazione di un processo che ne esalta l’operato, anche nel racconto delle sue difficoltà di uomo sotto scorta da decenni e ostracizzato da varie parti.

All’eroe ecco poi affiancato l’antieroe, che in Rinascita ha un nome e un cognome, Luigi Mancuso, boss di Limbadi e della provincia, onnipresente in articoli e reportage esteri sul processo. Non è il solo boss a processo Luigi Mancuso. Non è neppure la prima volta che va a processo. Eppure spesso, parlando di lui, i media esteri danno a intendere che aver portato Mancuso, l’antieroe, a processo sia una delle vittorie dell’eroe, uno dei caratteri fondamentali di Rinascita. Le due facce, quella del magistrato e quella del boss, spesso affiancate, sono volti nuovi all’estero, meno in Italia e molto meno in Calabria, cosa che ovviamente rende più facile la narrazione giornalistica straniera.
La ‘ndrangheta ovunque
Una terza componente è poi la pervasività della ‘ndrangheta sul territorio come viene raccontata in Rinascita-Scott, soprattutto nei rapporti con la politica e le istituzioni. Ecco che all’estero si racconta dell’avvocato, ex-senatore, Giancarlo Pittelli, che accanto ad eroe ed antieroe rappresenta la corruttibilità del potere (e dunque aiuta anch’egli la spettacolarizzazione), e delle vittime, o famiglie delle vittime, della ‘ndrangheta sul territorio, come per esempio Sara Scarpulla e Francesco Vinci, genitori di Matteo Vinci ucciso da un’autobomba a Limbadi – vicenda per per cui alcuni membri della famiglia Mancuso sono stati ritenuti colpevoli.

Le vittime invocano, giustificano, l’intervento dell’eroe e rendono più nitida, ancor più stilizzata, la figura dell’antieroe. Fuori dall’Italia questi sono ingredienti fondamentali per creare una storia, mentre in Italia sono tutte cose già viste (purtroppo) nei grandi processi di mafia. I rapporti tra mafia e politica, mafia e vittime, mafia e istituzioni per l’Italia sono costanti delle vicende di mafia, ci si aspetta che emergano anche nei processi; così non è all’estero, dove mafia spesso è ancora ‘solo’ crimine organizzato.
Paradossalmente la novità di Rinascita-Scott non è il presunto o reale rapporto tra mafia e politica o la pervasività delle famiglie sul territorio, ma semmai il contrario – cioè il fatto che il processo voglia confermare come certe dinamiche siano in corso e pervasive da decenni al pari di altri territori, come il reggino, in Calabria. Su LaC News, nel programma di approfondimento ‘Rinascita-Scott’, questo emerge non appena si inizia a parlare con vari ospiti e scavare negli archivi giudiziari.

Gli stereotipi sulla Calabria
E qui si arriva alla quarta componente, che è lo stereotipo della Calabria come terra meravigliosa e maledetta. Distante, fonte di nostalgia per i tanti migranti, ma impenetrabile. E soprattutto preda di una mafia potente che ne impedisce sviluppo e progresso. Questo stereotipo, che rende possibile ma non facile relazionarsi con la Calabria per chi non la conosce, non vi è nato o non la studia, assolve tanti (politici, cittadini…) e distorce il potenziale di questo processo. Se il problema è la mafia, certo portare a processo oltre 350 ‘mafiosi’ (perché non è facile poi capire a quanti e a chi tra gli imputati sono contestati reati di mafia) dev’essere un colpo mortale, no? Soprattutto se ci si aspetta, come detto sopra, che vengano condannati.
La realtà è più complessa
Per questo Rinascita diventa il processo per i libri di storia. Eppure così non è, come riconoscono sia alcuni magistrati che tanti rappresentanti della società civile, perché la mafia non è il ‘cancro’ di una società altrimenti sana, e l’antimafia giudiziaria non può essere l’unica ancora di salvezza.
Tra esigenze mediatiche di riduzione della complessità e polemiche sul cono d’ombra informativo, questo processo probabilmente non è stato ancora trattato per come sarebbe auspicabile, tanto in Italia quanto all’estero. Senza spettacolarizzazione, riconoscendo la complessità del territorio, delle sue relazioni sociali e la difficoltà di ‘resistere’. D’altronde, questo non accade spesso anche per gli altri processi di ‘ndrangheta, o di mafia in generale? C’è poco da stupirsi allora.