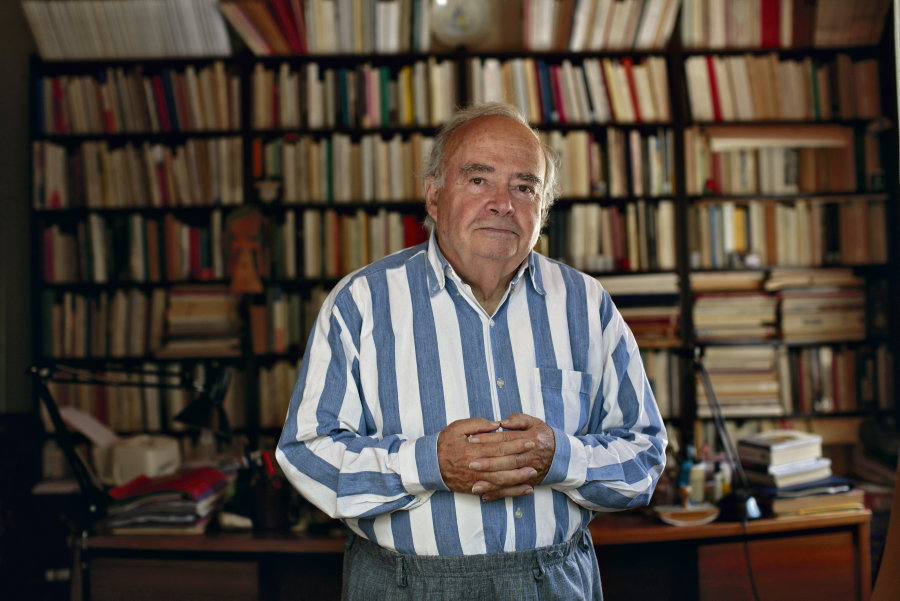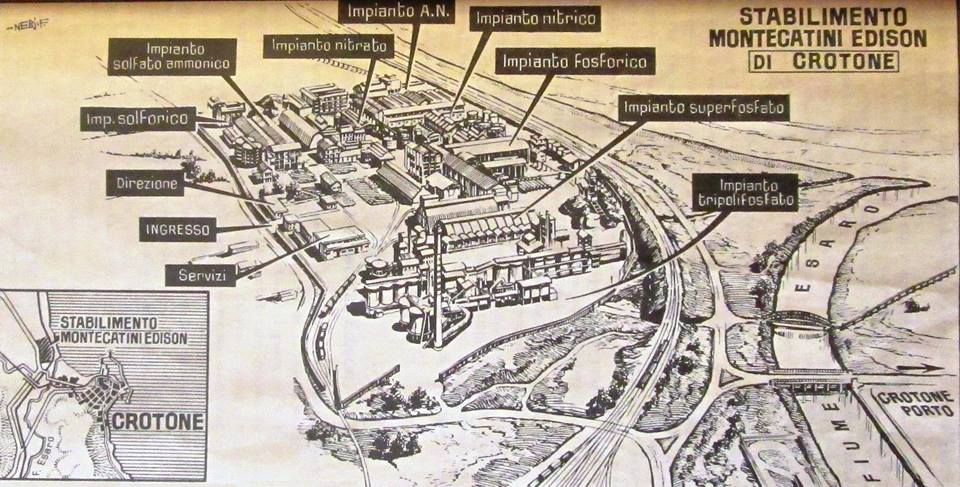Una delle scene più belle del primo film del regista Gianni Amelio, La fine del gioco, girato 55 anni fa a Catanzaro, rimane sorprendentemente impressa dopo averlo visto. È quella che ritrae un gruppo di ragazzini. Prima seguiti dall’alto e poi a livello della strada. L’occhio del regista che li segue, mentre a ritmo lento e dolente, sfilano in corteo.
Una marcia a testa bassa, in silenzio e braccia conserte dietro la schiena, come fossero in ceppi. Il gruppo di adolescenti messi in fila come un plotone sono seguiti lentamente da un’auto, che li tiene d’occhio e li scorta infine dietro un cancello e oltre le mura di un recinto. In quel passaggio sorvegliato tra strade cittadine di una Catanzaro illividita dai toni del bianco e nero, in una controra quasi spettrale, c’è tutta la condizione di privazione di libertà dei giovani che erano detenuti all’interno del carcere minorile di Catanzaro. Il luogo dove il film si ambienta dopo quelle prime scene.

Gianni Amelio a Catanzaro
A lato di quel primo scorcio rivelativo, a quel piccolo gruppo di ragazzi sorvegliati, si contrappone l’allegra e libera frenesia che anima il gioco di un altro gruppetto di figuranti. Un gruppo dei bambini che si svagano sparpagliati e vocianti oltre la transenna di una grande piazza. Loro, uno sciame di liberi, e i separati, gli estranei, già lontani, chiusi da quei confini, in quelle stanze, le camerate del correttorio già così simili a celle. Sembra il distillato del set iperrealista di uno dei film di Amelio più belli, Il ladro di bambini. Catanzaro del dopoguerra, e questi ragazzi che guardano sempre per terra e non si voltano indietro, e in alto non guardano mai.
L’infanzia difficile, il rapporto tra i bambini, i giovani e gli inganni degli adulti, il sentimento del tempo e la nostalgia, gli sfregi alla bellezza e al paesaggio, le rivelazioni che balenano nel movimento che coglie lo spazio e la luce, il senso profondo della storia. In questo piccolo film di 60 minuti, c’è, riassunto in un’epitome tutto il cinema che sarà di Amelio, da quei primi spezzoni di pellicola sperimentale sino ad oggi.
La proiezione organizzata da Fondazione Trame
È merito della Fondazione Trame, guidata da Nuccio Iovene, che da 13 anni organizza il Festival dei libri sulle mafie a Lamezia Terme, e di “Trame a Sud”, lo spin-off affidato al giornalista e scrittore Vinicio Leonetti per promuove iniziative di riflessione artistica e cinematografica legate alla Calabria e al Mezzogiorno, a cui va il merito di aver allestito e organizzato questo primo appuntamento, se a Catanzaro nei giorni scorsi il cinema fuori dalle sale è tornato in luogo della città così significativo, vicinissimo e lontano, il Minorile di Catanzaro, che oggi si chiama Istituto Penale per Minorenni con Sezione per Semilibertà. “Trame a Sud” comincia da questo luogo e da questo autentico, e presto dimenticato, capolavoro riscoperto.
Gianni Amelio gira nel carcere minorile di Catanzaro
La fine del gioco è il primo mediometraggio filmato realizzato e prodotto per la Rai dal regista Gianni Amelio nel 1970. Un film in cui un regista della televisione nazionale, decide di intervistare un bambino molto particolare. Leonardo è un piccolo orfano che senza colpe che non siano la sua condizione di orfano e piccolo lazzaro, si trova chiuso in una casa di correzione. Il regista lo sceglie per farne il protagonista di un film-documentario per la televisione.
E’ sta la straordinarietà del cinema, che diventa il cinema girato proprio lì, con il racconto di una storia che si svolgeva nel recinto del Carcere Minorile di via Paglia, diventato set, con un protagonista che, come quei ragazzi, era uno di loro. Amelio girò La fine del gioco in bianco e nero a soli venticinque anni, scrivendolo insieme ad un altro importante catanzarese del cinema italiano, Mimmo Rafele, che di questa pellicola di Amelio fu aiuto regista e sceneggiatore.
Con gli studenti del Galluppi, il liceo di Amelio
La visione del film, a distanza di più di mezzo secolo dalla sua realizzazione, è stata condivisa adesso dagli studenti del Liceo Classico Galluppi (che fu il Liceo di Amelio), insieme ai ragazzi che entro le mura del Minorile di Via Paglia, sono ancora oggi come allora ristretti. Difficile, se non irrealizzabile per la ritrosia sentimentale e umana che contraddistingue il suo autore, far tornare Amelio, che ha da poco compiuto 80 anni ed è al cinema con il suo ultimo film Campo di Battaglia, nella città del suo debutto di regista per celebrare questa bella e simbolica ricorrenza.
Era presente invece Domenico Rafele, felice di ritornare dopo 55 anni nella sua città e sui luoghi che furono set di quel film. Rafele è uno dei più noti e affermati sceneggiatori italiani. Oltre che con Amelio, ha poi collaborato tra gli altri con registi come Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Tra i suoi film come regista e sceneggiatore si ricordano Domani (1974) Ammazzare il tempo (1979), La piovra, Il giovane Mussolini, Vite a termine, Codice Aurora. Oggi Rafele vive a Roma, dove continua a dirigere film e a scrivere (anche libri; suo il romanzo La forma della paura, scritto con Giancarlo De Cataldo) come sceneggiature per il cinema e la televisione.
Leonardo, il piccolo protagonista di allora
Alla proiezione de La fine del gioco, tra gli ospiti radunati da Leonetti per la proiezione nel piccolo cinema del Minorile, non c’era il regista, ma c’era invece, il suo protagonista di allora, Leonardo. Gino Valentino, che a 12 anni fu preso dalla strada e scelto proprio da Amelio per interpretare il piccolo protagonista del racconto, che nel film si chiama appunto Leonardo. Gino/Leonardo è oggi un simpatico, sorridente, e affabile signore di una certa età. Una vita ordinaria di lavoro e di affetti.
Un tranquillo pensionato quasi settantenne che vive nel quartiere popolare di Fortuna, tra la città e il lido di Catanzaro. Ma quella del film fu per lui un’esperienza indimenticabile, che ha raccontato ai ragazzi e al pubblico con l’incanto intatto di quando era bambino, con ingenuità e fervore, esattamente come allora. «Gianni e Mimmo mi sono stati molto vicino allora, io non avevo mai visto il cinema; mi hanno guidato loro in tutto, ma se feci bene l’attore per quella parte fu perché mi sentivo davvero com’ero nel film».
Un ragazzino di una periferia del Sud, cresciuto in quegli anni faticosi, ingenuo testardo, diffidente e incantato da tutto. Rivisto, nella parte di Leonardo, lui è davvero un magnifico. Anche il giorno della proiezione i ragazzi ristretti del Minorile lo avevano scambiato per uno di loro. Invece Gino allora era solo il ragazzino di un suburbio di case popolari, l’abitante di un quartiere di provincia, cresciuto per le strade polverose di una Calabria fine anni ‘50 povera e piena di speranze, non ancora smagata dalle illusioni del boom. Il Minorile lui, Gino, lo chiama ancora “riformatorio”.
E confessa che ancora oggi tra i suoi conoscenti c’è chi fatica a credere che lui non fosse uno degli adolescenti reclusi lì dentro. Ci tiene a raccontare di non avere mai avuto problemi con la giustizia, né prima né dopo il film. Ma forse fu, dice, solo per caso, per fortuna, aggiunge, se lui fece “le scuole”, ebbe genitori buoni e con loro un destino che lo portò lontano dalle mura del riformatorio di Via Paglia. Racconta come fu che arrivò a fare quella parte.
La troupe si presenta nella sua scuola di Catanzaro. Alla selezione si affollano in tanti, tutti ragazzini delle medie cittadine. Lui ad un certo punto, irrequieto com’era stava per scappare via per tornarsene a casa, quando Amelio lo fermò, interpellandolo in dialetto catanzarese: “Duva fuji tu!, veni accà!”. Era lui quello che cercava per il suo Lorenzo. Gino aveva la faccia giusta, il gesto, i tratti, la voce, la postura che cercava Amelio. Da quel giorno Gino fu per sempre il Lorenzo del film. Lavorò per alcuni mesi fianco a fianco con Amelio e Rafele, ogni giorno sul set, girando diligentemente e con una bravura stupefacente buona parte delle scene tra gli spazi interni al carcere minorile, che ancora oggi è accanto allo Stadio dove gioca il Catanzaro.
Il set per gli esterni fu poi portato anche tra gli scompartimenti deserti di un treno del Sud. Gino recita le sue scene in compagnia del solo grande Ugo Gregoretti, che nel film interpreta il giornalista della Rai che vuole intervistare Leonardo. Gregoretti è l’adulto che lo scruta e lo indaga, lo straniero viene da una città lontana, l’altro che lo avvicina tentando di offrire con il passaggio dallo schermo uno spiraglio redenzione piccolo borghese al piccolo carcerato ribelle. Devono ad un certo punto fare insieme un viaggio, uno spostamento altrove, trasognato, teso, solitario.
Un vagone di un Treno Espresso fu per questo preso in affitto dalle Ferrovie dello Stato. Si girò, ricorda Mimmo Rafele, su un convoglio in movimento che faceva realmente la spola sulla tratta tra Roma e Lamezia.
Colpiscono anche quelle scene prese dal vero e registrate in diretta da Amelio e Rafele. Con i sobbalzi e lo sporco di fondo, mentre dai finestrini del treno scorre un paesaggio del Sud già rotto e privo di bellurie, con voci e rumori che si sovrappongono, con piani sequenza e lunghi silenzi, poche parole spezzate e gli sguardi persi e poeticamente intensi di Leonardo. Furono girate così le scene del viaggio con cui il film nel racconto del piccolo Lorenzo si conclude.
L’Oliver Twist di Amelio
Il piccolo orfano ribelle prima si nasconde, poi scende dal treno a una delle fermate, da solo, scalzo. Fugge. Va via. La vita e la rinascita prospettata per lui restano incerte, ma la strada che sceglie sarà quella che farà, a modo suo. Allo stesso modo Amelio cominciava in sordina ma in forma luminosa e poetica il suo cinema a Catanzaro con questo piccolo film. Lo fece raccontando in pellicola la parabola malinconica del piccolo Leonardo, un lazzaro fantasioso e ribelle – un orfano povero, che parte senza mezzi verso l’età adulta e per compiere la sua avventura dal profondo della provincia fugge via, come fu del resto per lo stesso Amelio.
Come Dickens circoscrisse in letteratura le scabrosità e le esclusioni brutali della società vittoriana dipingendo di speranze e di fidente genuinità il volto del suo Oliver Twist, Amelio lo fa nel suo film riuscendo a dare un volto e un sembiante poetico al suo piccolo Leonardo, dipingendo speranze e ribellione sul volto innocente e riottoso di Gino, aggiungendo scetticismo e malinconia alle gesta minime del suo piccolo protagonista. Non a caso, quindi, da questo luogo di “correzione” e da questo particolare racconto cinematografico era partita l’originale avventura cinematografica di Amelio.
Dal carcere ai vagoni del treno
Il film implicitamente e per contrasto ci appare oggi anche come un discorso figurato sull’immaginario e sull’iconografia culturale catanzarese degli ultimi decenni. Merito anche questo di Amelio, intellettuale e regista transfuga dalle circonvenzioni cittadine. Allievo, come Alvaro, del famoso Liceo Galluppi, dopo una parentesi universitaria messinese, Amelio evade da Catanzaro per rinascere cinematograficamente a Roma. La fine del gioco è anche per questo un film già precocissimo e completo. Compendia il tema del ritorno, sia nel soggetto del film – la storia del ragazzino che appena dodicenne si trova rinchiuso senza colpe in un riformatorio calabrese, da cui cerca faticosamente di fuggire per trovare fuori la sua strada –, sia nella suggestiva e minimalistica ambientazione dei paesaggi, con gli esterni girati a Catanzaro. Mentre nel carcere minorile della città si girarono tutti gli interni, solo le scene della seconda parte in viaggio, furono spostate dentro i vagoni di un treno.
Nella pellicola tutti i temi di Gianni Amelio
Questo primo film catanzarese contiene in cifra, dicevamo, tutti gli ingredienti della filmografia maggiore sviluppata successivamente da Amelio: i temi del contemporaneo, il cinema sul cinema, il rapporto fra padri e figli, quello difficile e irrisolto del richiamo dei luoghi delle origini, con la lotta fra gli integrati e i fragili, i marginali, i fuoriposto, opposti alla logica conformista e feroce della società contemporanea. Centrale, come in tutto il cinema di Amelio, è anche il tema dello spaesamento e del viaggio, narrati come archetipi culturali e umani di un Sud inaridito, slogato e fuori posto. Forse proprio il conflitto intimo e mai risolto di Amelio con la sua Catanzaro resta intatto e ancora aperto come sottotesto implicito del film.
La città per lui «ferma» e «malferma», il suo ricordo di una piccola società di provincia, burocratica, conservatrice e chiusa nei suoi privilegi, a cui si oppone oggi l’immagine contemporanea di luogo di incroci politici e di potere prepotenti e corrivi, riflessi nello specchio rovesciato di paesaggi urbanistici caotici e sconvolti. Un catalogo di contrasti irrisolti che restano ancora oggi il tratto distintivo e perturbante di questa capitale ideale della Calabria di adesso.
Un luogo che oggi scorre ineffabile, immobile e chiazzato di enormi palazzoni e costruzioni fuori scala, lontano dai finestrini delle auto in corsa sui grandi snodi stradali, nel traffico impazzito delle circovallazioni, oltre i ponti vertiginosi gettati su calanchi e burroni di questa Calabria post-tutto. Un paesaggio che sembra un compimento di quel primo set di Amelio, l’apoteosi di quelle cupe location del non-finito sudista di un tempo. Set ideale, magari, per girarci un nuovo film di Gianni Amelio, un’altra fine del gioco.
Il dibattito e la proizione nel carcere minorile
Alla fine del dibattito e della proiezione, la sala-cinema del Minorile era strapiena: studenti, docenti, ma soprattutto tanti giovani in vinculis, i ragazzi in custodia presso il Minorile che hanno visto il film. Tutti bravi, tutti in parte. I dirigenti della struttura di oggi, l’aiuto regista di allora, il protagonista del film, Vinicio Leonetti e i dirigenti di Trame festival, la giornalista e scrittrice Annarosa Macrì, autrice -con Giosi Mancini- di una bella e dettagliatissima intervista ad Amelio per i suoi ottant’anni uscita nei gironi scorsi su Il Quotidiano del Sud. Con la sorveglianza delle guardie carcerarie, che lì per servizio, hanno apprezzato molto anche loro.
Tutti insieme a vedere e compitare le scene di questo bellissimo film, un apologo sull’adolescenza e il senso della vita che dopo più di mezzo secolo da quando fu girato, non smette di interrogarci e farci riflettere. Applausi per tutti. Quindi. A cominciare da quelli che nel lontano 1970 hanno immaginato, realizzato, interpretato questo piccolo prezioso capolavoro nascosto del cinema italiano – che va riportato all’attenzione del pubblico e restaurato prima che sia troppo tardi. Se ai giovani spettatori radunati a vederlo è rimasto attaccato qualcosa della poesia e della luce di questo primo scarno e potentissimo film di Amelio, di questa storia povera e pensosa, in cui un piccolo orfano ribelle, povero e malvissuto, si stacca dagli adulti e prende la sua vita in mano, anticipando “la fine del gioco”, sarà questo di nuovo e soprattutto il suo vero successo.