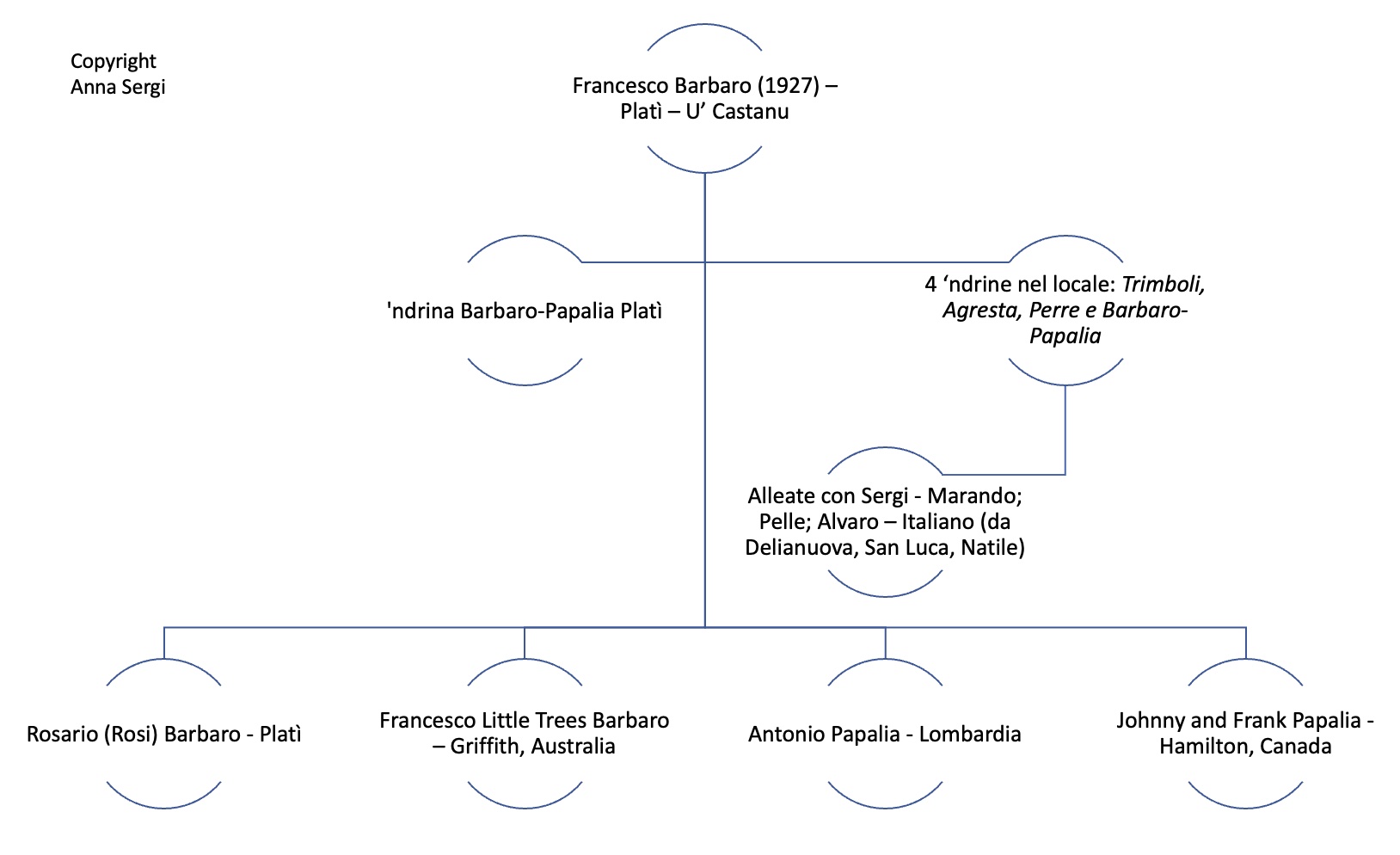Entrare in aula bunker al carcere dell’Ucciardone a Palermo è un’esperienza che induce alla modestia e alla riflessione. La storia scritta in quest’aula, dagli eroi della prima antimafia giudiziaria in Italia, non è solo storia di Cosa nostra siciliana, o storia della mafia italiana. È storia d’Italia. È solenne, la memoria di quest’aula, le parole dette qui dai pubblici ministeri del pool antimafia siciliano durante il maxiprocesso degli anni Ottanta (e dopo), le parole dette dai mafiosi prima e dopo le condanne da dietro le sbarre delle 30 celle, e infine le ore della corte per leggere i verdetti.

La memoria di quei mesi e quegli anni ha cambiato il paradigma di quello che la mafia siciliana, Cosa nostra, avrebbe rappresentato da quel momento in poi per l’Italia e i metodi dei suoi investigatori e martiri, per il mondo. Ecco perché, entrare in aula bunker è un’esperienza emotivamente carica. L’essere italiani è in parte definito dalla storia di questa aula. Per questo The Global Initiative Against Transnational Organised Crime, GI-TOC, ha voluto organizzare il 9 marzo proprio nell’aula bunker una giornata di riflessione e conferenza insieme al Tribunale di Palermo.
L’occasione è stata la discussione dei risultati italiani del Global Organized Crime Index, un imponente lavoro di raccolta dati intorno agli attori e alle attività del crimine organizzato che GI-TOC ha effettuato nel 2021 e si appresta ad aggiornare nel 2023, per tutti i paesi del mondo, con un’infografica snella ed efficace che ben si presta ai canoni comunicativi di oggi.
‘Ndrangheta e stragi: un pezzo di memoria mancante
Nel corso di questa giornata si è discusso dell’apparente paradosso italiano: un ‘punteggio’ molto alto assegnato dall’Index per quanto riguarda alcuni attori criminali (la presenza di gruppi mafiosi), alcune attività criminali (principalmente, il mercato della cocaina e la tratta di esseri umani) assieme a un punteggio molto alto assegnato per la ‘resilienza’ italiana a questi fenomeni. Della serie, l’Italia ha sì un problema di criminalità organizzata molto distinto e molto serio, ma ha anche gli strumenti, non solo giuridici ma anche di attivismo sociale, per rispondere a questo problema. La resilienza italiana al crimine organizzato certamente nasce e si consolida in aula bunker, e ‘scoppia’ in seguito al periodo delle stragi.

Il modo in cui il Global Organized Crime Index vede l’Italia ha certamente molto a che fare con la Calabria e sicuramente con la ‘ndrangheta, coi traffici di cocaina legati ai nostri clan, e con la presenza che le ‘ndrine hanno nel resto del paese. Ma c’è un’altra ragione – per ora non accertata in tutte le sue componenti – per cui la Calabria, e la storia della ‘ndrangheta, è importante per l’analisi dell’Index. E questa ragione riguarda proprio la memoria delle stragi e il ruolo della violenza e dell’arroganza mafiosa in Calabria e la reazione ad esse. Perché, lo sappiamo, seppur solenne e colossale, la memoria nata e mantenuta in quest’aula bunker non è ancora completa. E tra i pezzi mancanti del periodo delle stragi c’è sicuramente la memoria calabrese.
Slitta la sentenza
Questa memoria – o meglio la sua correzione – è il cuore del processo ‘Ndrangheta Stragista, che tra il 10 e l’11 marzo, attendeva a Reggio Calabria il verdetto del processo d’appello. Conferme o ribaltamenti delle sentenze di condanna del primo grado e la definizione (giuridica oltre che storica) dell’apporto che la ‘ndrangheta apicale avrebbe dato ai vertici di Cosa nostra nel periodo delle stragi arriveranno il 23 marzo. Tale apporto sarebbe dietro al duplice omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo nel 1994.

Il verdetto d’appello va posticipato perché, nonostante si tratti di fatti ormai datati, di oltre 30 anni fa, arrivano ancora novità che integrano la mole dei dati a processo. Proprio mentre si attendeva il verdetto, il procuratore generale Giuseppe Lombardo ha infatti chiesto che venissero acquisiti i contenuti di un’intercettazione rivelata all’interno dell’operazione Hybris, di qualche giorno fa, contro il clan Piromalli a Gioia Tauro. Nell’intercettazione, due affiliati, che non sapevano di essere intercettati, discutono del ruolo dei Piromalli nelle stragi e dell’incontro al club Sayonara a Nicotera Marina in cui nei primi anni ‘90 si sarebbe deciso se la ‘ndrangheta si dovesse o meno unire alla strategia siciliana.
Un posto di serie B
Ma cosa c’entra tutto ciò con l’Italia, il global index di GI-TOC e l’aula bunker di Palermo? C’entra perché la ‘ndrangheta come la conosciamo oggi – con alcuni clan che si sono resi leader del narcotraffico, altri clan che si sono distinti per le capacità imprenditoriali, in investimenti pubblici e privati e altri ancora che hanno fatto politica cittadina e regionale, non è stata – per la storia – la mafia delle stragi.
La ‘ndrangheta non è la ragione per cui l’Italia avrebbe sviluppato anticorpi invidiati in tutto il mondo, giuridici e di associazionismo sociale e civile. La ‘ndrangheta violenta delle faide e dei sequestri non ha scritto la storia d’Italia, anzi, è stata relegata dalla storia d’Italia – proprio per la sua violenza primitiva – ad avere un posto di serie B, accanto alla ‘sorella’ siciliana che di quella violenza ne ha fatto politica e strategia di attacco allo stato. Ma, a prescindere dai risultati processuali, e dalle responsabilità personali ivi confermate o meno, sembra accertato che i collegamenti tra Cosa nostra e ‘ndrangheta ci fossero e ci fossero inter pares – tra persone a pari livello.

Ecco perché durante la giornata organizzata in aula bunker a Palermo si è discusso della violenza della ‘ndrangheta e delle scelte durante le stragi: perché che si siano accordati o meno, i Graviano e i Piromalli (tra gli altri), per fare le stragi congiuntamente, alcune tra le dinastie storiche della ‘ndrangheta in quegli anni avevano comunque la facoltà di scegliere se farlo o meno, perché gli era riconosciuto e detenevano il potere per farlo. E questo nella storia ufficiale dell’antimafia ancora non c’è.
Paese che vai, violenza che eserciti
La scelta di essere stragisti – andata o meno a ‘buon fine’ – ci porta ad affermare che, non per la prima volta, i clan di ‘ndrangheta più stagionati e più importanti usano la violenza strategicamente. E lo fanno perché nonostante l’organizzazione frammentata dei clan del territorio – autonomi per signoria territoriale e attività criminale – i boss dei clan apicali sanno che i contraccolpi dallo Stato e dalla società civile coinvolgono tutti, quando c’è violenza manifesta ed ‘esterna’ all’organizzazione.
La violenza, per la ‘ndrangheta, si espone in prima linea spesso solo localmente, dove lascia un’eco per anni ma dove storicamente non ha spesso ispirato atti di denuncia durativi da parte della popolazione. Ma quando la violenza di ‘ndrangheta si è fatta più visibile oltre il locale e l’interno – pensiamo alla strage di Duisburg in Germania o all’omicidio Fortugno – le conseguenze sono state pesanti per l’organizzazione tutta, anche se si trattava di una faida tra due gruppi soltanto.

Inoltre, ricordiamo che la spinta stragista della ‘ndrangheta, diversamente da Cosa nostra, non poteva essere comunque una decisione di ‘tutta’ l’organizzazione, quanto solo di alcuni capi, proprio per la diversa organizzazione delle due mafie. Questo ci conferma che allora come oggi la ‘ndrangheta funziona a compartimenti stagni, dove solo chi deve sapere sa e dove si fanno alleanze strategiche a stretto raggio, con chi serve e con chi è utile senza ‘sprecare’ connessioni. Questo è il modus operandi che si vede nei mercati illeciti, dove la ‘ndrangheta entra ‘piano’ e con alleati misti, dalla cocaina agli appalti, oggi senza il rumore della violenza.
La storia d’Italia e le scelte della ‘ndrangheta
Le scelte – o non scelte – di allora ci hanno consegnato la ‘ndrangheta contemporanea. ll Global Index vede l’Italia come estremamente influenzata da gruppi criminali mafiosi – forti in quanto capaci di entrare in vari mercati legali e illegali – ma allo stesso tempo, resiliente perché le stragi (e non solo) hanno reso il paese consapevole del proprio problema mafioso. Questa fotografia del paese è anche, a sorpresa, il risultato della storia della ‘ndrangheta, oltre che quella di Cosa nostra. Quello che i capi della ‘ndrangheta hanno fatto all’epoca delle stragi, o quello che non hanno fatto ma avrebbero potuto fare, la violenza manifesta e quella ‘trattenuta’, hanno definito la storia d’Italia anche senza far parte della ‘narrativa’ principale della nascita dell’antimafia. Proprio come si confà alla ‘ndrangheta nella sua caratteristica più primitiva, l’essere riservata e ‘dimessa’ come l’altro lato della luna.