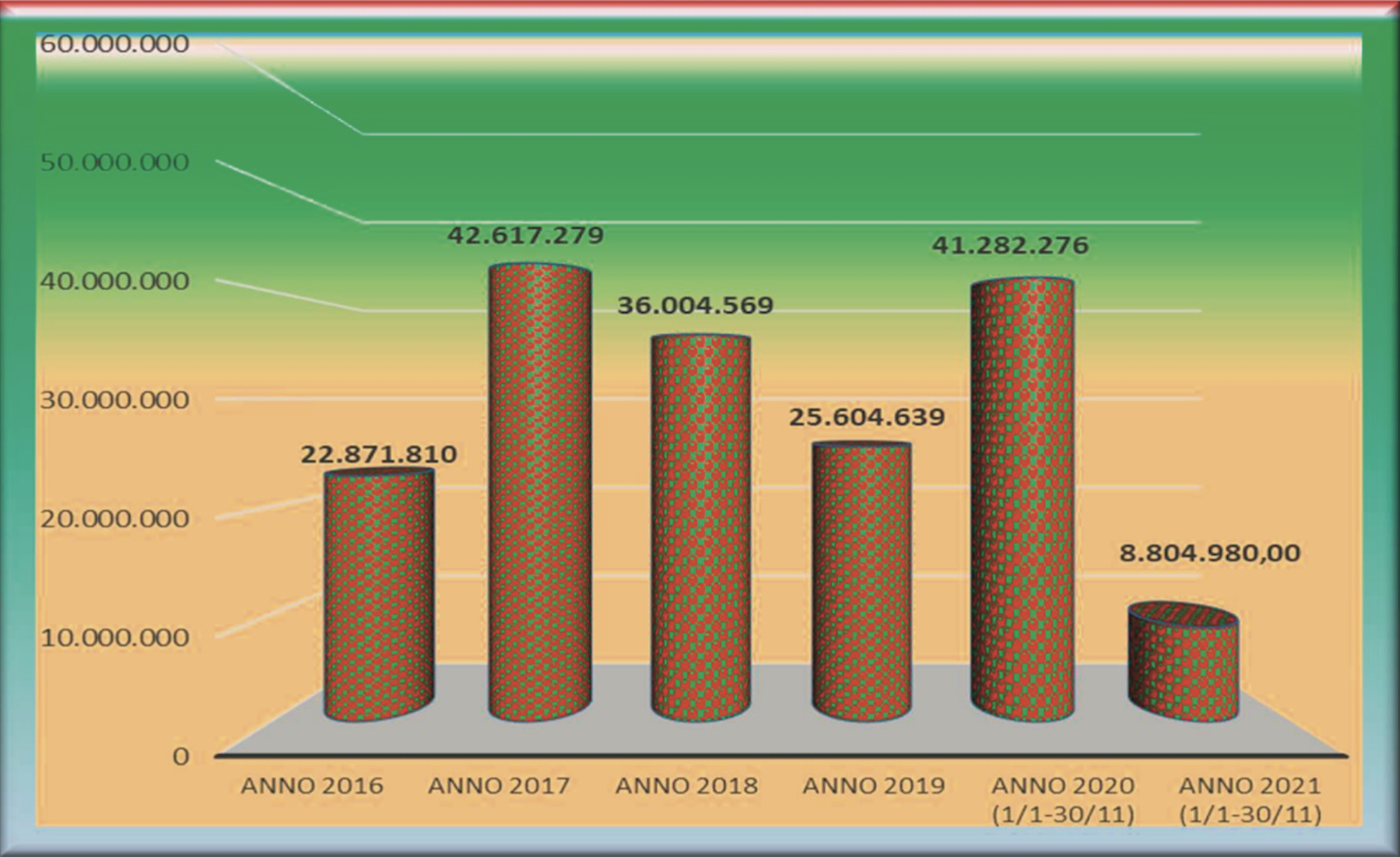Le donne della Marlane, l’ex fabbrica dei veleni con sede a Praia a Mare, molto più dei loro colleghi maschi operai, erano quelle che credevano più di tutti alle potenzialità di quello stabilimenti, alla crescita economica ed alla fine della fame che le loro famiglie avevano subìto nel dopoguerra. Molte di loro erano figlie di contadini. Avevano visto con i loro occhi le proprie madri lavorare la terra o ai telai che avevano in casa, senza riuscire a fare quel salto economico che tutti si aspettavano dal quel duro lavoro. All’arrivo del conte Rivetti nella Maratea degli anni ’50, le donne di Maratea erano riconosciute come brave tessitrici e chi voleva fare un buon corredo alle proprie figlie in sposa raggiungeva questa cittadina per rivolgersi a loro.
Il conte Rivetti arriva nel Sud
Se Cristo si è fermato a Eboli, Rivetti lo sposta oltre. Fino alla Calabria, in un’area dove si incrociano le tre regioni meridionali più povere d’Italia: la Basilicata, la Campania, la Calabria. L’opera di Rivetti comincia grazie a finanziamenti enormi che il conte riuscì a ottenere dalla Cassa del Mezzogiorno, sembrerebbe anche grazie alla sua amicizia personale con il potente deputato lucano Emilio Colombo. La sua prima cattedrale nel deserto fu il complesso industriale chiamato R1 S.p.A Lanificio di Maratea e nacque nel 1957. Nel 1958-59 Rivetti si sposta in Calabria e qui a Praia a Mare fa nascere la R2.

Per queste due strutture, il “benefattore” riceve dallo Stato ben 6 miliardi di vecchie lire. Una cifra per quei tempi astronomica che rientra nella logica di aiuti al Sud. Tra il 1966 e il 1970 il conte Rivetti cede le sue azioni e gli stabilimenti vengono assorbiti prima dall’IMI (Istituto Mobiliare Italiano), poi dalla Lanerossi e infine dall’ENI, che nel frattempo rileva la Lanerossi. Ora nasce la denominazione Marlane S.p.A. Mentre sul conte la stampa del Sud tace, quella dei Nord si scioglie in deliranti e sprezzanti analisi sociologiche antimeridionali al solo fine di mitizzare la figura del pioniere, del nuovo redentore delle zone depresse dei Mezzogiorno.
Il “pioniere” che piaceva a Montanelli
Montanelli scrive: «Prima che un industriale del Nord, l’ing. Rivetti, venisse a restituire questi luoghi al loro naturale destino di ottava meraviglia del mondo, gli abitanti di Maratea vivevano come venti secoli fa: di fichi, di pomodori, di carrube, d’uva e di cacio pecorino». Il “pioniere”, ribadisce il giornalista, «cala in una realtà dove solo le donne lavorano, mentre gli uomini giocano a scopone e briscola, aggrumandosi come mosche nei caffè locali, perché schivi, come tutti i meridionali, per un complesso di paure e abitudini casalinghe del sole e della luce».
Si fanno risaltare le difficoltà e gli ostacoli nei quali ogni giorno si trova questo industriale che anziché portare i capitali all’estero, sente l’impegno morale e nazionale di investirli al Sud affrontando difficoltà burocratiche e tecniche enormi: trovandosi di fronte a gente neghittosa, a pretese salariali senza senso, a persone comunque non disposte ad accettare con disciplina la dura servitù del lavoro moderno.

Le donne sono le prime assunte alla Marlane
Poi la svolta. Il lavoro salariato, la paga a fine mese, i contributi, le ferie, la sicurezza di poter comprare una nuova casa. Le operaie, più degli uomini, pensano al progresso della famiglia, al futuro dei propri figli, al lavoro che un domani avrebbero potuto fare anche i propri figli. Teresa Maimone era una di queste operaie. Arrivava in fabbrica in bicicletta, desiderosa di affermarsi, di andare avanti, di portare il pane alla famiglia. Poi le morti per tumore, una dopo l’altra. Un elenco di donne operaie dimenticato, che nessuno ha intenzione di voler ricordare. A Tortora , esiste una via dedicata a Stefano Rivetti, fondatore della fabbrica, ma non una via dedicata alle donne ed agli uomini della Marlane. Niente esiste neanche a Praia a Mare.
I veleni nei terreni
Lì sono rimasti solo le tonnellate di rifiuti, certificati anche dall’ultima perizia depositata nel tribunale di Paola. Una perizia che dovrebbe essere distribuita casa per casa, per far capire i pericoli esistenti in quei terreni, e quelli che i cittadini corrono in quella cittadina. Il Comune di Tortora, quando il sindaco era Lamboglia, fu l’unico comune della costa tirrenica che si costituì parte civile nel processo contro i dirigenti della fabbrica. Gli altri sindaci, compreso quello di Praia a Mare, fecero finta di non sapere niente.

Ma le morti ed i veleni ci sono. E nessuno oggi ha voglia di ricordarsene. Come nessuno ricorda le donne operaie, in questo 8 marzo:
- Francesca Bocchino di Maratea è morta nel 1995 all’età di 49 anni per carcinoma al colon;
- Maria Rodilosso di Aieta è morta nel 1998 all’età di 50 anni per carcinoma mammario;
- Nelide Scarpino di San Nicola Arcella è morta nel 1999 all’età di 60 anni per tumore allo stomaco;
- Teresa Maimone di Maratea è morta nel 2000 all’età di 54 anni per tumore all’utero;
- Pasqualina Licordari, di Gallina è morta nel 2002 all’età di 61 anni per carcinoma del colon;
- Resina Manzi di Aieta è morta nel 2005 all’età di 62 anni per tumore mammario;
- Domenica Felice di Tortora è morta nel 2003 all’età di 48 anni per carcinoma midollare della mammella;
- Maria Iannotti di Trecchina morta nel 1988 all’età di 48 anni per tumore maligno del colon.
Un ricordo per le donne e gli uomini della Marlane
Sono solo alcune delle decine di operaie della fabbrica Marlane di Praia a Mare, molte delle quali colpite da tumori maligni riconducibili ai fumi cancerogeni che venivano fuori dalle vasche del reparto tintoria e dalle polveri dell’amianto sparse per il capannone. Lavoravano tutte senza mascherine, né tute di protezione, né guanti. In un unico ambiente, con al centro macchine in cui si impiegavano, all’insaputa di tutti, veleni chimici.

Nel 2013, durante il processo Marlane, in primo grado, nel tribunale di Paola l’ironia della sorte volle che un’udienza capitasse proprio un venerdì 8 marzo. Un processo che si chiuse in primo e secondo grado con la completa assoluzione di tutti gli imputati compreso il capo Marzotto. Si attende la fine del secondo processo, ancora impelagato in perizie tecniche , nella speranza che si giunga alla verità. Perché queste donne, così come le centinaia di altri operai, ottengano finalmente giustizia. Ed una piazza che ne perpetui il ricordo.