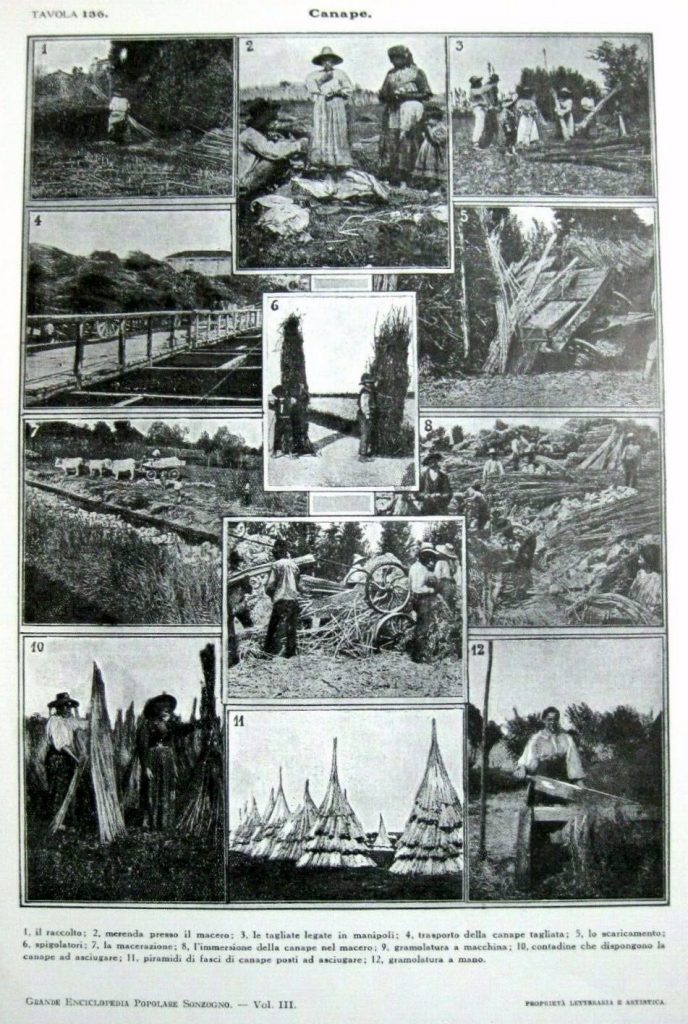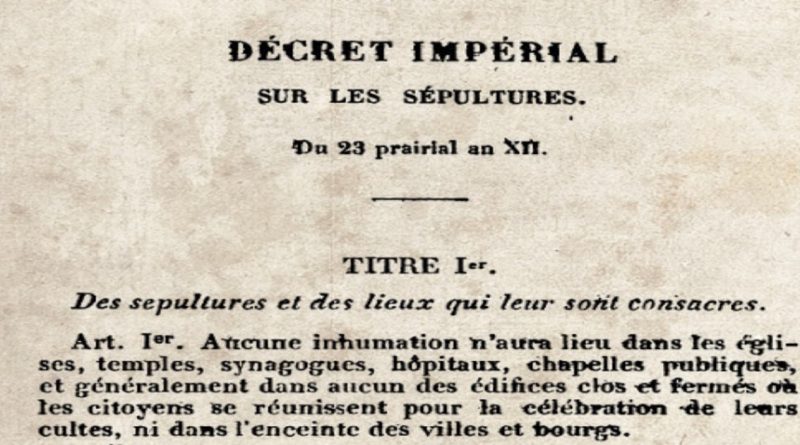[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
A San Lucido i pescatori under 30 hanno mangiato pastina e acqua salata da piccoli, hanno deciso che da grandi avrebbero fatto questo lavoro già alle prime uscite in mare con i nonni e con i papà. Oggi salgono sui pescherecci di notte come navigatori fenici. Non è un mestiere semplice. I rischi sono diversi. E adesso che il gasolio è aumentato, per una battuta di pesca bisogna fare i conti fino all’ultimo centesimo. Una notte in mare costa almeno 400 euro soltanto di carburante. Bisogna tornare con un bel carico per non perderci.
Riposa in pace capitano Mazza, tra i primi morti per Covid
Nel minuscolo porto della terrazza sul mare, così è chiamato il paese del basso Tirreno cosentino, per decenni il San Giovanni e la Nuova speranza sono usciti e rientrati con al timone il capitano Gianni Mazza. Era il più autorevole dei pescatori ed è stato una delle prime vittime di covid in Calabria, morto nel marzo del 2020 a 75 anni. Anche i colleghi del Nord Italia lo hanno ricordato tributandogli manifesti e saluti tra le onde.
Le barche di famiglia sono accompagnate dal suo volto, formato poster, sulla plancia. Suo nipote ha 20 anni, porta orgogliosamente lo stesso nome, fa lo stesso mestiere. «La prima volta mio padre Andrea, che ha 45 anni, mi ha portato in mare con la pastina a tre anni e mezzo. Siamo una famiglia di pescatori. Io i miei due fratelli, uno di sedici anni e l’altro quasi quindici, mio padre, due zii e quattro cugini».

A un passo dalla laurea, poi ha scelto il mare
È sabato mattina. Nel porto di San Lucido l’acqua brilla, una famiglia di papere scivola sul mare, mentre sui pescherecci si srotolano le reti per riparare il tremaglio. Un’arte che solo i pescatori conoscono, che apprendono senza bisogno di teoria, osservando i più anziani. Con gli occhi fissi sulle trame e le mani che si muovono veloci, è questo il momento della condivisione, dei racconti e degli aneddoti che viaggiano da una barca all’altra.
Francesco Maria Tonnera, 27 anni, è qui da prima dell’alba. Lui e il suo equipaggio sarebbero dovuti uscire presto per la pesca, ma hanno rimandato a causa del vento. «Un giorno, avrò avuto otto anni – racconta, – ho detto a mia madre: io continuerò a studiare, però tu mi devi fare andare in mare. Trascorrevo la notte sul peschereccio, tornavo alle cinque del mattino, facevo una doccia, mi mettevo il grembiule e andavo a scuola».
Quella di Francesco Tonnera (un destino già scritto nel cognome), è la terza generazione di una famiglia di pescatori. La promessa fatta a sua madre – purtroppo scomparsa due anni fa – l’ha mantenuta: con i buoni voti ha sempre meritato borse di studio, si è diplomato ed era a un passo dalla laurea in Giurisprudenza e da una vita completamente diversa da quella dei suoi. «Ero stato selezionato per un colloquio per un posto in banca a Milano, ma non me la sono sentita: una vita in giacca e cravatta non fa per me, ho scelto la libertà». La libertà è la pace e la poesia delle notti sulla barca sotto un cielo stellato. «Non so descriverla, è una sensazione unica».

Il pescatore 4.0 di San Lucido su Tik Tok
Ne è passato di tempo da quando si buttavano le rizze a mare e poi si vendevano i pesci sul molo del porto facendo a gara a chi urlava più forte. Francesco non ha l’aspetto del lupo di mare, è piuttosto un pescatore 4.0: da una parte la tradizione, la sapienza e i riti che si tramandano; dall’altra le innovazioni, per esempio le telecamere a bordo per filmare il pescato e un uso efficace dei social. Basta digitare il suo nome e su Tik Tok è un trionfo di seppie e polipi e altri pesci ancora nella rete ma pronti ad arrivare sulle tavole dei clienti che possono ordinare on line.
A San Lucido i giovani scelgono ancora di fare questo lavoro duro ma soprattutto usurante perché l’umidità e la fatica alla lunga compromettono la salute. A muovere tutto è la passione, ma le difficoltà sono tante.

Concorrenza sleale
«Le leggi europee stanno ammazzando il nostro lavoro – dice Tonnera – viviamo con il terrore delle sanzioni, con la costante incognita dei controlli dei militari della Capitaneria che salgono a bordo a controllare il pescato, ma si fa troppo poco invece per arginare la concorrenza del pesce che arriva da altri paesi», il malepesce lo chiamano.
«La nostra famiglia ha perso tre pescherecci, uno più bello dell’altro», interviene il padre Tullio, 57 anni, cinquanta anni di lavoro, due figli, entrambi pescatori. «La Michelangelo, 18 metri, è stata affondata nel porto di Vibo per pesca illegale del pesce spada. Un altro è finito bruciato. Là – indica la strada – è ferma la Mariella, 14 metri di peschereccio, sequestrata per disastro ambientale, poi ce l’hanno ridata ma a questo punto non è più utilizzabile».

Pesce azzurro e delfini che t’inseguono
È tanta la voglia di mollare ma alla fine vince il richiamo del mare. Di notte, lontano dalle coste, si capisce quanto inquinamento di luci trasfigurino il cielo. Sul mare quelle delle stelle sono abbaglianti, dicono i giovani pescatori.
Poi, con le reti in acqua, tutto può succedere. Perché laggiù è un turbinio di pesci che si muove sotto la barca. «È in quei momenti che capisci che dovrai agire col pugno fermo e i nervi saldi, perché ogni tua decisione avrà una conseguenza», dice Francesco Tonnera. E l’obiettivo è rientrare nel porto, quando il sole è già sorto, con un bottino ricco. «Con quello che costa il gasolio, se qualcosa va storto il danno sarà enorme».
Il mare di San Lucido è uno scrigno di pesce azzurro: alici, sarde, sgombri soprattutto. E il Tirreno regala spettacoli improvvisi di delfini che inseguono il peschereccio o che giocano intorno alle barche ferme, di notte. «Ce ne sono tantissimi, noi pescatori sappiamo quanto possano essere addirittura “infestanti”, perché nel loro periodo di transito spesso danneggiano le reti e le imbarcazioni».
La maledizione delle tartarughe
E nonostante l’esperienza, lo stupore è sempre grande davanti alle tartarughe – «tante, enormi, meravigliose», dice Tonnera – che si incontrano lungo il cammino. «Specialmente di notte capita di avvistarle in acqua, stanche, affaticate. Quando possiamo le teniamo un po’ a bordo per farle riprendere e poi le rimettiamo in mare». Guai a far loro del male e non solo perché le sanzioni in caso di controlli della Capitaneria sarebbero altissime, ma soprattutto perché secondo una credenza popolare, «le tartarughe bestemmiano», quando sono in pericolo o vengono catturate emettono dei suoni cupi e quella è una maledizione che colpirà chi le uccide.

Azzannato dallo squalo azzurro
Hai mai avuto paura? La domanda è rivolta a Francesco, ma risponde suo padre Tullio: «Paura unn’avi mai». Francesco ha il suo trofeo, mostra una enorme cicatrice sul polpaccio, è il morso di una verdesca, lo squalo azzurro. «Era finita nella rete e dovevamo smagliarla per poi farle riprendere il largo. Io e mio padre abbiamo dovuto tirarla a bordo, è un pesce molto mobile con una torsione rapidissima: uno scatto e mi ha azzannato alla gamba, il risultato è questo, hanno dovuto mettermi 75 punti di sutura».

La donna che perse marito e figli in mare
Sulla gente marinara di San Lucido veglia Cilla, la moglie e madre ormai leggendaria che ha perso i suoi uomini in mare. È ritratta da una scultura di Salvatore Plastina che sembra una donna in carne e ossa affacciata sul belvedere. I sanlucidani raccontano che nelle notti di mare grosso la sentono lamentarsi.
Ha pianto lo scorso venti agosto. Gianni Mazza, il giovane pescatore di razza, era al largo di Belmonte insieme con l’equipaggio della Nuova speranza e «all’improvviso ci siamo trovati davanti una tromba marina, con onde alte fino a tre metri. È stato un momento veramente difficile. Ma siamo riuscito a tornare nel porto. Mio nonno ci ha insegnato a capire il mare. Lui, diceva non vuole caputoste, non si può sempre sfidare, altrimenti soccombi».
Il grande squalo bianco
Gianni Mazza è stato il capitano di tante imprese. Nel lontano 1978 prese lo squalo bianco, la creatura più temuta dai bagnanti, che rare volte si è vista nei mari calabresi.
Lui e la sua famiglia sono i protagonisti del documentario dell’antropologo Giovanni Sole “Pescatori d’argento. Alici e lampare in Calabria”.
È anche nelle notti calme e silenziose che possono accadere cose starne. «Una volta eravamo a motore spento con le reti calate – racconta Francesco Tonnera – c’era una pace assoluta e soltanto la luce delle stelle. Ero a prua, quando all’improvviso ho visto sollevarsi l’acqua per una lunghezza di circa dieci metri, come se ci fosse un pesce in superficie. Ho seguito l’enorme sagoma che lentamente si muoveva di fianco alla barca a filo d’acqua. Sono certo che si trattasse di un enorme capodoglio».