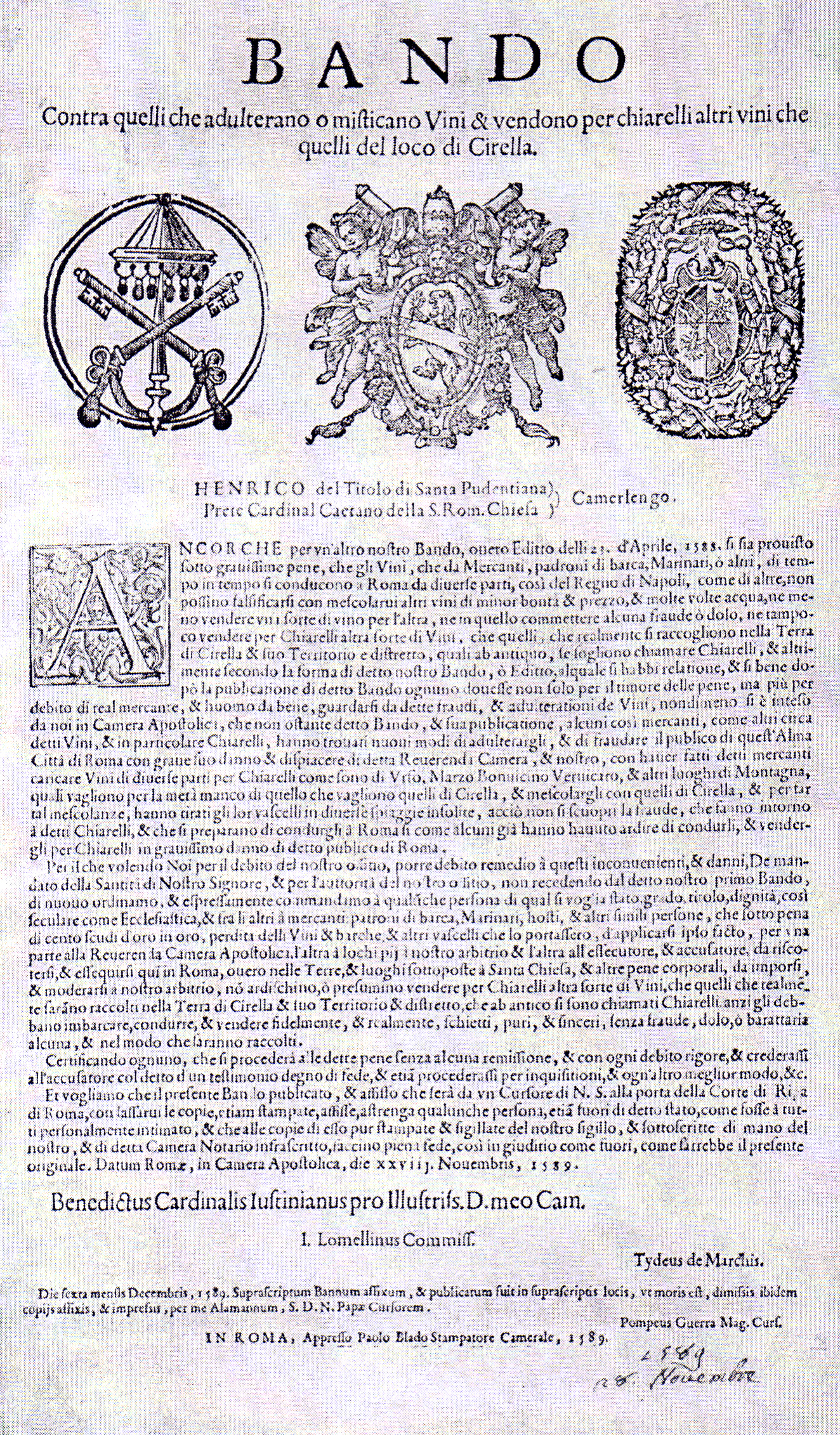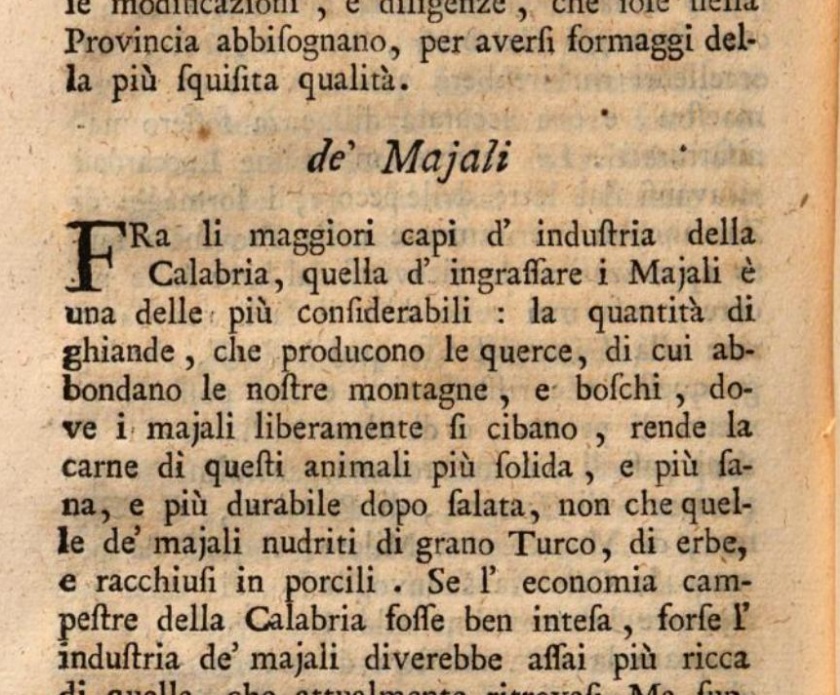L’arte di arrangiarsi, tipica delle nostre latitudini, è stata la carta vincente che ha portato sei cosentini sul podio dei Campionati Italiani di Cucina 2022 a Rimini. Medaglia d’argento per Daniele Mannarino e Danilo Liparoti (categoria Mistery box); medaglia di bronzo per Domenico Trentinella, Biagio Girolamo e Luca Grillo (categoria street food) e Eugenio Caloiero (categoria singoli).
Un ottimo risultato per la Federazione Provinciale di Cosenza. Medagliere amaro, invece, per la Calabria che si classifica al nono posto, ben distante da un podio tutto “terrone” con i primi tre classificati Campania, Sicilia e Puglia.
La competizione
La sesta edizione dei Campionati della Cucina italiana, nata dalla collaborazione fra Italian Exibition Group e la Federazione italiana dei Cuochi, ha ospitato nelle ultime edizioni più di 500 concorrenti tra team italiani ed esteri. La manifestazione è riconosciuta dal circuito Worldchefs. La prossima sfida della FIC saranno i campionati mondiali, il tanto prestigioso Bocuse d’Or.
Sebbene caratterialmente distanti anni luce dallo chef stellato Adam Smith, interpretato da Bradley Cooper ne Il sapore del successo, i cuochi cosentini vivono la cucina con la “cazzimma”, l’inventiva e l’amore viscerale per il proprio lavoro tanto da indentificarsene con l’obiettivo di soddisfare ed emozionare i propri clienti.

Cucina al buio
Una sfida nella sfida per i cosentini Danilo Liparoti e Daniele Mannarino che hanno conquistato il secondo posto nella finalissima con una mistery box dedicata ai piatti crudisti, vegetariani e vegan.
Ma come si fa ad essere i secondi cuochi d’Italia per inventiva? «Con sacrificio, passione e determinazione».
“Linguino”, cuoco per dovere
Daniele Mannarino è quasi un figlio d’arte. I suoi genitori erano titolari di un alimentari e pasta, pane e scatolette sono sempre stati i suoi “giocattoli”. Ha iniziato a cucinare a sette anni. Non per passione, ma perché doveva preparare il pranzo ai genitori.
«A convincermi furono le lacrime di mio padre il giorno della firma dell’iscrizione alle scuole superiori. Avevo scelto l’Industriale ma lui mi convinse a iscrivermi all’Alberghiero, per lui avevo talento”. E visti i risultati, come dargli torto.
Tante le esperienze professionali maturate, dall’esordio a 14 anni in un villaggio a Soverato ad oggi che di anni ne ha trentasette. È stato cuoco a Rimini, Firenze, Stoccarda ma il cuore l’ha lasciato lo scorso anno in una struttura cinque stelle lusso, tre forchette Gambero Rosso di Seby Sorbello a Zafferana Etnea (Catania).
«È stata la mia esperienza formativa più importante», anche se il suo punto di riferimento rimane il titolare dell’Osteria Francescana, Massimo Bottura.
Nella cucina di Mannarino non può mancare un piccolo orto di aromi e spezie, perché «a fare la differenza è sempre la qualità della materia prima».
I suoi piatti forte sono tutti a base di pesce, primi piatti in particolare; da qui il suo soprannome “Linguino”.
«La cucina inizia nella testa, passa dal cuore e finisce nelle mani. Il tutto condito – dice – da una giusta dose di amore, territorio e passione».
Il lato oscuro dell’essere cuoco è lo «stress piscofisico, i sacrifici, il rinunciare agli affetti più cari: amici e famiglia». «È una scelta di vita – spiega – non può essere altrimenti». E sull’esito del Campionato non ha mai avuto dubbi. «Mi aspettavo di vincere sia per la mia propensione a creare piatti nell’immediatezza, sia per le qualità di Danilo, il mio compagno di squadra».
Mannarino è già proiettato all’edizione dei Campionati 2023, resta solo da scegliere la categoria tra singoli, squadre o street food.

Il sacro fuoco dei fornelli
Ha sempre saputo che nella vita avrebbe fatto il cuoco. La sua prima frittata Danilo Liparoti l’ha preparata a cinque anni, rimediando anche una scottatura. Ma non si è arreso. Anzi. Testardo e determinato ha iniziato a lavorare a 13 anni e mezzo, nonostante le lacrime della madre che ora è la sua supporter numero uno.
Malgrado i 24 anni d’età ha più di quindici competizioni culinarie alle spalle e nove anni di esperienza nelle principali località turistiche calabresi, italiane con una parentesi in Svizzera. A segnarlo maggiormente il periodo livornese. Entrato in cucina da 17enne aiuto cuoco di brigata è diventato quasi subito il capo cuoco.
«Una soddisfazione- ricorda – ma allo stesso tempo una grande responsabilità. Non è facile dare ordini a persone più grandi di te».
Per Danilo cucinare «è sperimentazione, essenzialità, colore. Il blu su tutti». Blu come il mare, blu come il pesce, ingrediente base per le sue specialità di antipasti e primi piatti.
Oltre a materie prime di qualità e aromi (il finocchietto è il suo ingrediente segreto), nella cucina di Liparoti non manca mai la buona musica. «La cucina è passione, se non si sta bene d’umore non si conclude nulla».
Per Liparoti non esistono esperienze negative: «Ogni volta si impara qualcosa di nuovo». Come quella volta che dopo un piatto tornato indietro ha passato giornate a rifarlo finché non è uscito perfetto: «Perché la soddisfazione passa dal sacrificio».
«A Rimini la gara si è svolta in un contesto corretto e leale ma il livello della competizione è stato altissimo. E sentire il proprio nome accoppiato ad una medaglia è stata un’emozione indescrivibile».
La determinazione di Danilo la si legge negli occhi. Il suo sogno è avere un giorno una struttura tutta sua. Il suo chef di riferimento? «Sicuramente Cannavacciulo».
La sua strada da sei anni si è incrociata con il suo compagno di gara Daniele Mannarino. Oggi entrambi sono le punte di diamante del Fellini Restaurant di Cosenza che con la sua cucina raffinata e ricercata ha conquistato i palati dei cosentini dopo appena sei mesi dall’apertura.
Cucina di strada
È stato cuoco del Fellini Restaurant anche Mimmo Trentinella, terzo classificato nella categoria Street Food insieme a Luca Grillo e Biagio Girolamo. (FOTO 4)
E se è praticamente impossibile avere una foto dei piatti della competizione a causa dei diritti esclusivi della FIC, per il suo street food Trentinella condivide la foto di una delle tante prove fatte prima di arrivare a Rimini.
Mesi e mesi di ricerca per sfornare un pan brioche di semola farcito con crema di melanzana cotta sottovuoto al microonde insaporita con aglio e menta, stracotto di maialino nero, cipolla caramellata di Tropea, ‘nduja e caciocavallo Dop; il tutto pastellato e fritto. (FOTO 5)
«Lo street food – spiega Trentinella – è sempre stato un mio pallino, sin da ragazzo». Negli anni Mimmo ha viaggiato molto in Europa per il suo lavoro. «Ad attrarmi sono sempre state le cucine di strada tipiche dei mercati inglesi, polacchi e francesi che, poi, è anche un modus operandi tipico di una parte del Mezzogiorno d’Italia, basti pensare alle pizze fritte campane o agli sfincioni siciliani». Le regioni del Sud hanno tutte un grande potenziale.

Cuochi e chef
Trentinella è diventato cuoco per una sorta di sfida con la sua famiglia: lui uscì di casa ed entrò nel primo ristorante aperto. E lì capì quale sarebbe stata la sua strada.
A 42 anni Mimmo è meno disincantato di tanti suoi colleghi. È pragmatico e lavora con un obiettivo ben chiaro nella testa: «Tramandare la passione per la cucina ai più giovani che oggi sembrano aver perso mordente».
Guai a chiamarlo chef. Come il compianto Tonino Napoli dice: «Siamo tutti cuochi, cucinieri. Chef significa capo, cuoco è colui che fa da mangiare con amore».