Oltre la morte non si può andare.
Non si dorme, non si ama.
Si riposa infinitamente.
Il riposo infinito che giunge soltanto dopo la fine. Sì, perché la vita dell’autore di questi versi fu tutt’altro che serena e sgombra di affanni. Afflitto dall’angoscia di vivere, Lorenzo Calogero fu un poeta solo. E solo un poeta.
Considerato, post mortem, fra i più alti poeti del Novecento da molti insigni pareri – fra questi anche quello di Carmelo Bene –, Calogero è tuttora poco conosciuto nella sua terra di origine, la Calabria, sempre molto incline a sostenere la liceità della locuzione latina d’evangelica memoria di Nemo propheta in patria.
Gli studi e le prime poesie
Nato il 28 maggio 1910 a Melicuccà, paese dell’entroterra Reggino, a breve distanza da Palmi e dalla Costa Viola, Lorenzo Calogero è il terzo dei sei figli – cinque maschi e una femmina – di Michelangelo Calogero e Maria Giuseppa Cardone. Cattolici, abbienti, possidenti terrieri, i Calogero-Cardone sono una delle famiglie melicucchesi più in vista del tempo.
Dopo i primi anni di studi – dapprima nel paese natio e poi a Bagnara, presso dei parenti della madre –, nel 1922 Lorenzo Calogero si trasferisce con la famiglia a Reggio Calabria, dove il ragazzo consegue la maturità scientifica, e nel 1929 a Napoli per iscriverlo alla facoltà di Ingegneria della prestigiosa Università Federico II. Si tratta di una breve liaison quella con l’ingegneria, sicché dopo poco lo studente passa alla facoltà di Medicina. L’insicurezza sul percorso accademico da intraprendere lascia intravedere la fragilità caratteriale del poeta fin dalla giovinezza.
Disinteressato alla politica del periodo, agli inizi degli anni Trenta Lorenzo Calogero comincia a soffrire di un arcano disagio che lo accompagnerà fino al termine dei suoi giorni: patofobie, vale a dire il terrore, spesso confuso con la convinzione, di contrarre o già essere affetto da gravi malattie. Nel caso di Calogero, la tubercolosi e il cancro.
In quel decennio, comunque, il giovane compone i primi versi. Risalenti al triennio 1933-35 sono le liriche poi raccolte in Poco suono, stampato, nel 1936 e a pagamento, da Centauro, editore che l’anno precedente aveva pubblicato sedici sue poesie riconosciute meritevoli dalla giuria del Premio Poeti di Mussolini.
Nel ’37 Lorenzo Calogero consegue la laurea in Medicina e ottiene a Siena l’abilitazione alla professione che, dopo nuovi tentennamenti, inizia a esercitare in Calabria: prima nella natia Melicuccà, poi, sempre per parentesi brevi o brevissime, in numerosi paesi come Sellia Marina, Gimigliano, Zagarise, Jacurso e San Pietro Apostolo.
Lorenzo Calogero, dal primo amore alla Val d’Orcia
Caduto il fascismo e trovato un abbozzo d’indipendenza economica – seppur le patofobie non accennino a svanire, tanto che nel 1942, preso dallo sconforto, si spara un colpo in petto (parlare di tentativo di suicidio ci pare irriguardoso dell’intelligenza del poeta e del lettore, considerato che il nostro era comunque un medico e un medico sa bene come ammazzarsi e come non ammazzarsi) –, nel 1944 Calogero fa la straordinaria scoperta di un altro aspetto della vita: si innamora e fidanza con una studentessa conosciuta anni prima a Reggio Calabria. Purtroppo, le angosce, l’insoddisfazione cronica e le continue manie di cui soffre il giovane medico – in quel periodo è convinto di aver contratto la rabbia da un cane – inveleniscono il rapporto. La ragazza tenta in tutti i modi di tirare fuori Calogero dalle secche in cui sta scivolando, ma ogni tentativo si rivela vano. La complicata relazione si interrompe già con la fine di quell’anno.
Conclusa la guerra, Lorenzo Calogero riprende a comporre poesie e fa ritorno a Melicuccà. Qui resta per un periodo abbastanza lungo, sino al principio del 1954 quando, dopo aver vinto un concorso, viene nominato medico condotto a Siena e spedito nel paesello collinare di Campiglia d’Orcia. La sua esperienza professionale in Val d’Orcia, però, è sì tanto disastrosa che appena un anno dopo è costretto a lasciare l’incarico. Scrive al fratello Paolo: «Come medico non godo alcuna simpatia da parte della popolazione»; la gente di Campiglia, infatti, aveva fatto presto a non fidarsi e a disertare lo studio di quel dottore così introverso e nevrastenico. Di fatti, l’isolamento in Val d’Orcia ha peggiorato il nervosismo e la suscettibilità del medico-poeta e ha acutizzato un’altra sua dannosa tendenza, quella di abusare di barbiturici e tabacco.
Nessun sostegno dal mondo letterario
Lasciatasi alle spalle l’esperienza infausta in terra toscana, Lorenzo Calogero si getta totalmente nella poesia cercando un editore che possa pubblicare i componimenti scritti nel dopoguerra e quella montagna di inediti giovanili che si porta appresso da anni. Dopo il rifiuto ricevuto da Einaudi, nel 1955 è costretto ancora una volta a ricorrere alla stampa a pagamento, in questa occasione presso la casa editrice senese Maia. Le due raccolte portano il titolo di Ma questo… e Parole del tempo.
Uomo dotato di scarsissimo amor proprio, in vita Lorenzo Calogero non ha avuto – e non ha saputo condurre a sé – il sostegno di alcun esponente del mondo letterario, un universo prevenuto e distratto che non riusciva proprio a trovare le ragioni e il tempo per comprendere quel poetuccio venuto fresco fresco dal Sud più misterioso. L’unica eccezione è costituita da un altro poeta meridionale: si tratta di Leonardo Sinisgalli.

Lucano di origini – era nato nel 1908 a Montemurro – Sinisgalli è stato il solo a dimostrare amicizia e interesse per Calogero e le sue poesie. I due condividono pure la passione per l’ingegneria e il critico e poeta lucano non si tira indietro quando il collega calabrese gli chiede, durante il loro primo incontro a Roma, di firmare la prefazione per il suo prossimo scritto. È Come in dittici, raccolta di centosettantasei liriche scritte tra il ’54 e il ’56 e edite sempre da Maia.
Il tentativo di suicidio e il ricovero a Villa Nuccia
Il 1956 e il 1957 rappresentano due anni decisivi, in senso negativo, per l’esistenza di Calogero. Alla scomparsa della madre, cui era profondamente legato, il poeta tenta il suicidio. L’esaurimento nervoso oramai manifesto a tutti, porta i famigliari alla decisione di ricoverarlo nella clinica per malattie nervose di Villa Nuccia, a Gagliano di Catanzaro. Questo periodo di internamento – durante il quale verga gran parte dei versi che finiranno ne I quaderni di Villa Nuccia, volume postumo, nominato dal poeta melicucchese Canti della morte – non giova affatto alla psiche di Calogero. Imprigionato entro le alte mura della casa di cura, egli si sente tradito dalla famiglia, capisce di non potere più contare su di loro.
È così che chiede nuovamente aiuto a Leonardo Sinisgalli, sempre più unico legame col mondo fuori da sé, solo faro visibile dalla sua bagnarola in preda alla tempesta.
Il Poeta ingegnere non gli volta le spalle e il 3 marzo 1957 firma la presentazione di alcune liriche calogeriane pubblicate sulla Fiera letteraria. Nell’estate del medesimo anno giunge la prima e unica gioia letteraria – effimera – dell’autore calabrese con la vittoria del Premio Villa San Giovanni.
La drammatica premiazione di Villa San Giovanni

Oramai divorato dai suoi demoni, in un primo momento Calogero non accetta l’invito ed è soltanto grazie all’intervento dell’amico Sinisgalli che decide di presentarsi alla cerimonia. La serata, però, è un colpo allo stomaco per chi vi assiste. Minato nella salute e incapace financo di camminare con fluidità, Lorenzo Calogero viene praticamente trascinato sul palco e ritira senza un sorriso il riconoscimento.
L’episodio ricalca i contorni della premiazione di Cesare Pavese al Premio Strega 1950, consegnatogli sessantaquattro giorni prima del suicidio nella notte tra il 26 e il 27 agosto.
“Tornato da Roma, da un pezzo. A Roma, apoteosi. E con questo? Ci siamo. Tutto crolla.” Queste le meste parole dello scrittore langhetto qualche giorno dopo la vittoria.
«Mi cugghjuniàru». Questa la colorita ma tetra risposta, in dialetto calabrese, di Lorenzo Calogero a un compaesano che gli aveva chiesto come fosse andata al Premio Villa San Giovanni.
La morte di Lorenzo Calogero
Morte mi chiama
col suo peso leggero
come in un sogno.
Gli ultimi anni del poeta sono segnati dai continui ricoveri e susseguenti fughe da Villa Nuccia. Abbandonato da tutti, al termine del 1960 si ritira in solitudine nella dimora di Melicuccà riempendo le sue giornate di innumerevoli cuccume di caffè, manate di sigarette e boccette di sonniferi.
Qui l’inquietudine di una vita cessa, quando il 25 marzo 1961 è trovato morto. Le circostanze del decesso di Lorenzo Calogero non sono state mai chiarite. Con buone probabilità si era tolto la vita da almeno tre giorni con un sovradosaggio di barbiturici, altro episodio che ne paragona la parabola esistenziale a quella di Pavese. Un ultimo punto in comune con lo scrittore de La luna e i falò è il biglietto d’addio che, all’apparenza semplice ma pregno di delirio, arrendevolezza, distacco, apprensione, terrore, Lorenzo Calogero lascia accanto al suo corpo: «Vi prego di non essere sotterrato vivo».
La poesia
E quel che mi rimane
è un poco di turbine lento di ossa
in questo orribile viavai
dove è alzato anche
un palco alla morte.
Da voracissimo lettore, Lorenzo Calogero accolse nella sua opera, come sostiene Luigi Tassoni ne Il gioco infinito della poesia (Giulio Perrone, 2021), “detriti, tessere, parole chiave, scie ritmiche” di tutti gli autori letti, rimodellati perché potessero aderire con coerenza alla sua poesia, ché questa non ne uscisse come una scialba parodia. Come abbiamo visto, però, i suoi versi ostinatamente tormentosi, scevri di speranza con cui consolarsi, anche antistorici rispetto alla poesia del tempo, non trovarono né lettori né editori interessati a pubblicarli.
Il poeta morì in quell’alba di primavera del ’61, ma la sua poesia risorse, o, per meglio dire, sorse, facendo vedere quanto essa sia inconsumabile, prendendo in prestito le parole di Pier Paolo Pasolini.
Estate ’62: Lorenzo Calogero diventa un caso letterario
La diffidenza verso l’opera di Lorenzo Calogero crolla dopo la morte, come sovente accade e come era accaduto poche stagioni prima a un altro gigante della letteratura italiana del Novecento: Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nell’estate del ’62 non si parla di altro che di quel poeta calabrese morto poco più di un anno prima in circostanze tragiche. Ne scrivono nomi illustri della cultura: Eugenio Montale, Giorgio Caproni, Alberto Bevilacqua, Mario Luzi, Leonida Repaci, Sharo Gambino, Carlo Bo, Franco Antonicelli. Addirittura Giuseppe Ungaretti si lascia andare a una frase divenuta celebre: «Questo Lorenzo Calogero ci ha diminuiti tutti».

Il nome di Calogero compare su tutte le testate nazionali, La Stampa consiglia i suoi libri tra quelli da portare sotto l’ombrellone, qualcuno avanza paragoni con i Poètes maudits. L’ultimo poeta dell’ermetismo, il nuovo Rimbaud, l’ultimo dei poeti maledetti. I titoloni si sprecano. Poi, passata l’ondata emotiva e modaiola, sul nome di Lorenzo Calogero cala di nuovo il silenzio.
Nel 1966 l’editore Lerici, che aveva pubblicato in due volumi le Opere Poetiche di Calogero e che aveva in cantiere una terza pubblicazione, chiude l’attività lasciando inedita un’altissima catasta di manoscritti.
Gli inediti all’Unical
In centinaia, infatti, sono i quaderni zeppi di poesie del melicucchese oggi conservati all’Università della Calabria – dipartimento di Studi Umanistici, laboratorio Archivi letterari novecenteschi – in pazientissima attesa che qualche anima volenterosa decida finalmente di pubblicarli.
Di e su Lorenzo Calogero, poeta consumato dal suo mal di vivere e dimenticato dal mondo culturale italiano, possiamo leggere:
- Opere Poetiche I, a cura di Roberto Lerici e Giuseppe Tedeschi (Lerici, 1962);
- Opere Poetiche II, a cura di Roberto Lerici e Giuseppe Tedeschi (Lerici, 1966);
- Poesie, a cura di Luigi Tassoni (Rubbettino, 1986);
- Lorenzo Calogero, di Giuseppe Tedeschi (Parallelo 38, 1996);
- Itinerario poetico di Lorenzo Calogero, di Giuseppe Antonio Martino (Qualecultura/Jaca Book, 2003);
- Parole del tempo, di Lorenzo Calogero a cura di Mario Sechi con una introduzione di Vito Teti (Donzelli, 2010);
- Avaro nel tuo pensiero, di Lorenzo Calogero a cura di Mario Sechi e Caterina Verbaro (Donzelli, 2014).
Melicuccà oggi ricorda il suo insigne figlio con una via e un monumento, sito lungo la principale via Roma, dell’artista scillese Carmine Pirrotta. L’opera (datata 1966) è stata finanziata con fondi degli emigrati d’Australia e commissionata dal Circolo culturale Lorenzo Calogero.













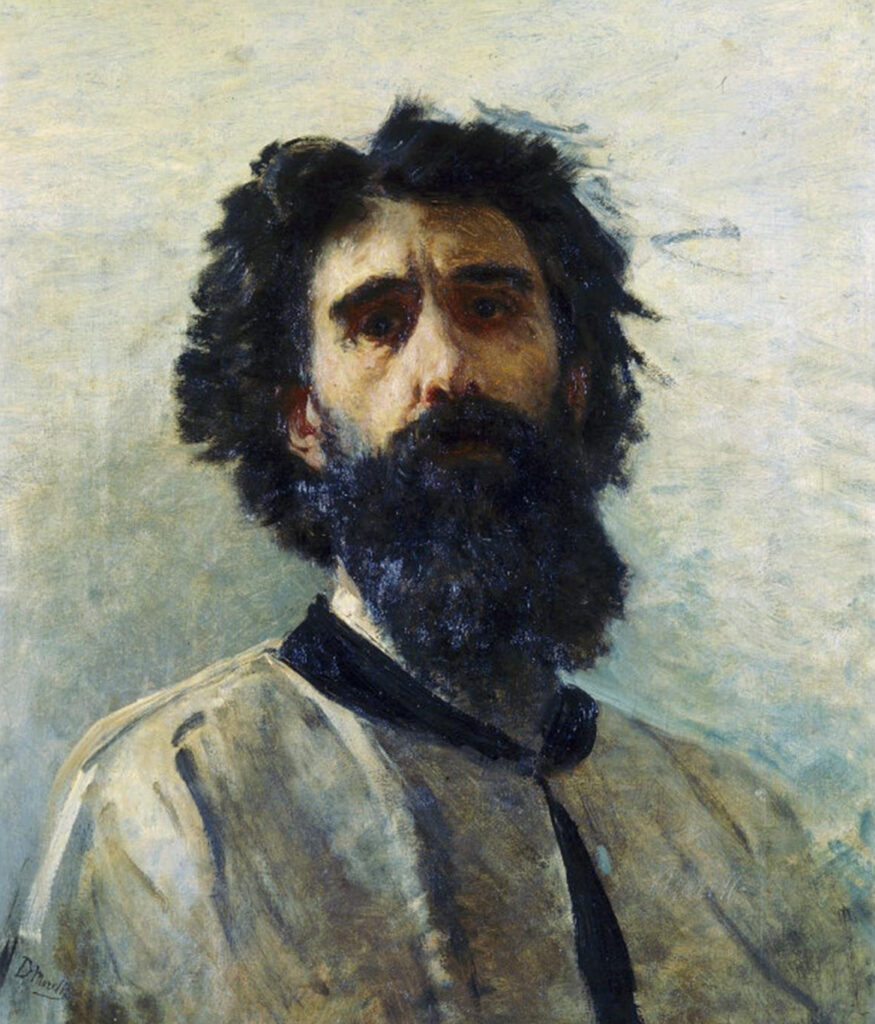
































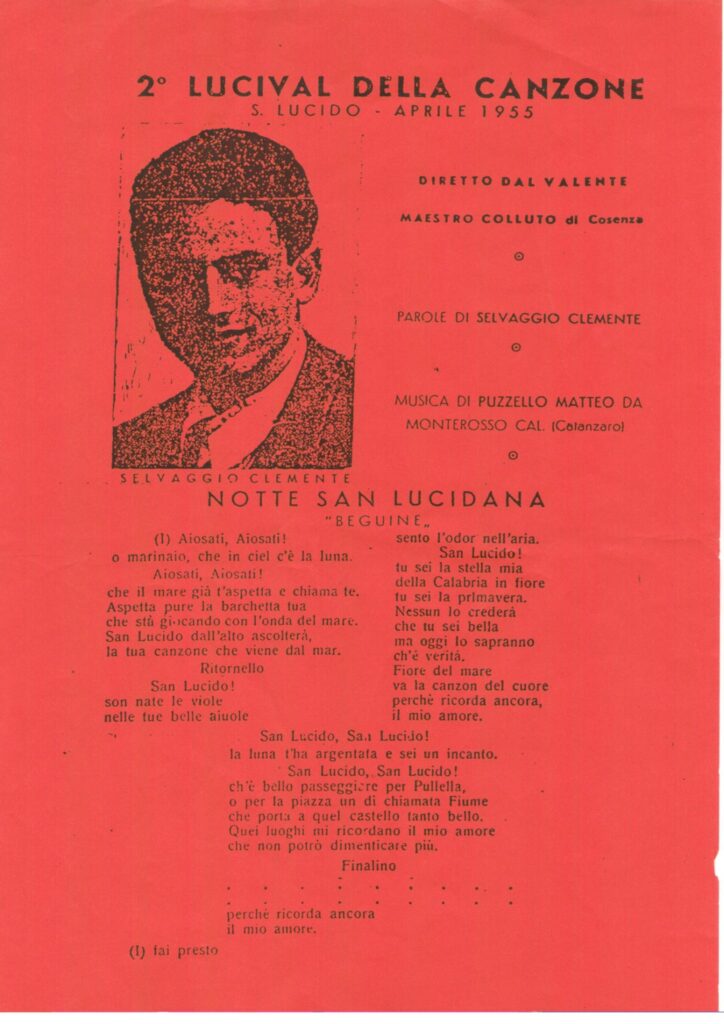


















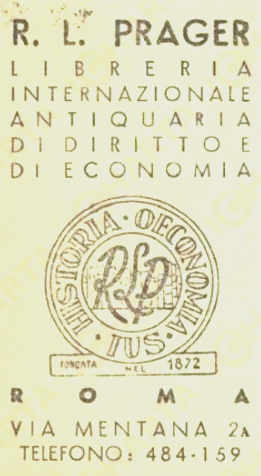 Werner Prager, protagonista – forse inconsapevole – di questa storia libresca, nacque nel 1888 a Berlino, dal libraio Robert Ludwig (1844-1914) la cui bottega aprì nel 1872. Assieme alla moglie Gertrud, continuò a gestire la società R. L. Prager e, pensando poi di scampare ai provvedimenti antisemiti, trasferì ingenuamente l’attività da Amsterdam a Roma nel 1937, ovvero solo un anno prima della promulgazione delle
Werner Prager, protagonista – forse inconsapevole – di questa storia libresca, nacque nel 1888 a Berlino, dal libraio Robert Ludwig (1844-1914) la cui bottega aprì nel 1872. Assieme alla moglie Gertrud, continuò a gestire la società R. L. Prager e, pensando poi di scampare ai provvedimenti antisemiti, trasferì ingenuamente l’attività da Amsterdam a Roma nel 1937, ovvero solo un anno prima della promulgazione delle 



