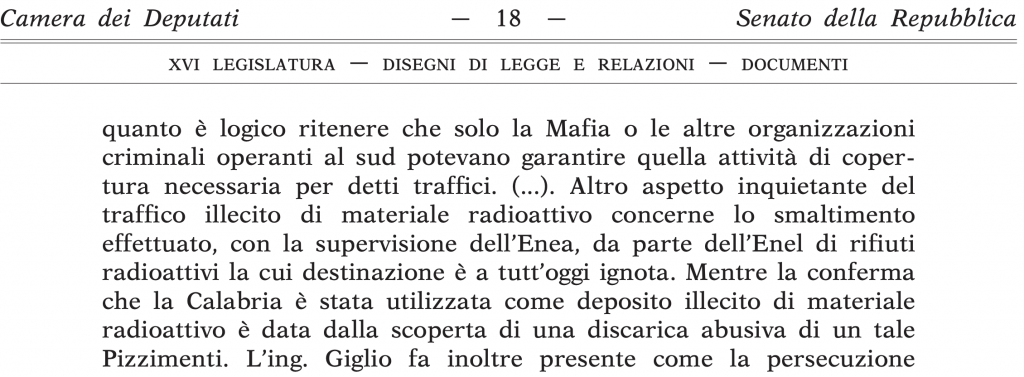Case che diventano aziende agricole, nuovi capannoni che si nascondono dietro anglicismi tattici, limiti ambientali cancellati d’imperio, strade che non esistono e su cui dovrebbero passare decine di camion al giorno: è finito, inevitabilmente, a carte bollate il braccio di ferro tra la Regione e il comune di Siderno sul “rinnovo” dell’impianto di trattamento dei rifiuti di San Leo. Un ricorso al Tar, presentato sull’ultima curva disponibile dalla terna commissariale che regge la cittadina jonica dopo l’ennesimo commissariamento per mafia, che mira a una sentenza sospensiva per i previsti lavori di profonda ristrutturazione dell’impianto gestito da Ecologia Oggi, società del gruppo Guarascio che in provincia di Reggio già gestisce il termovalorizzatore di Gioia Tauro.
Il ricorso ai giudici amministrativi che potrebbe avere sviluppi già nei prossimi giorni. Presto gli si affiancherà quello che i cittadini dell’associazione «Siderno ha già dato» stanno preparando a supporto e integrazione del primo. Una battaglia che tra riunioni infuocate, consigli comunali aperti e manifestazioni di protesta, covava da mesi. E che è esplosa quando dal dipartimento di Tutela ambientale della Regione, è arrivata l’autorizzazione all’ampliamento.
Le tappe
Quella del raddoppio dell’impianto di San Leo è una storia vecchia. Dal dicembre 2016 – quando il Consiglio regionale approvò il Piano regionale di gestione dei rifiuti – incombe su un pezzo di Calabria sottratto alla fiumara e piazzato a poche centinaia di metri dal mare, più o meno a metà tra i territori di Siderno e Locri, i centri più grandi dell’intero comprensorio. Nel piano originario approvato a Palazzo Campanella nel 2016, San Leo sarebbe dovuta diventare un eco-distretto attraverso la creazione di nuove linee di produzione per i rifiuti differenziati e l’adozione della tecnologia anaerobica per il trattamento della forsu e del “verde” per la produzione di biogas.
Una trasformazione profonda a cui si misero di traverso cittadini e amministrazione comunale in un braccio di ferro durato fino all’aprile del 2018. All’epoca la struttura regionale fa parziale marcia indietro accogliendo le istanze del territorio e limitando i lavori previsti nel centro di San Leo ad un profondo restyling che passava attraverso la riqualificazione delle linee di trattamento dei rifiuti e il potenziamento delle sezioni di aspirazione e biofiltrazione.
Un progetto differente
Quando la pratica per i lavori al centro di San Leo sembrava essere finita stritolata negli elefantiaci ingranaggi burocratici della cittadella di Germaneto, nel 2020 c’è una decisa accelerazione dell’iter. A settembre, sull’onda dell’interminabile emergenza monnezza, sul sito del Dipartimento Ambiente spunta la pubblicazione del progetto: un progetto che però, sostengono gli uffici comunali della cittadina jonica, si differenzia in maniera sostanziale dalla bozza venuta fuori durante la conferenza di servizi e gli incontri con i cittadini e a cui la terna prefettizia risponde quindi con parere sfavorevole ai lavori.
Quel parere non ferma però gli uffici regionali che, lo scorso 12 agosto «decretavano il provvedimento autorizzativo n° 8449» per la trasformazione dell’impianto di San Leo. Un muro contro muro che, inevitabilmente, è finito in tribunale con i giudici amministrativi chiamati a valutare il ricorso presentato dalla terna prefettizia lo scorso primo ottobre.
La relazione tecnica
Sono tanti i punti critici evidenziati dalla dettagliata relazione degli uffici comunali contro il piano regionale per San Leo. A cominciare dalle nuove strutture da realizzare: da una parte il progetto regionale, che parla di «modeste modifiche all’attuale assetto morfologico dell’area interessata… che possono determinare un ulteriore moderato impegno di territorio necessario per garantire le nuove e più complesse funzioni operativi dell’impianto», dall’altra gli uffici comunali che, nero su bianco, rispondono «alla bizzarra tesi» avanzata da Catanzaro quantificando le modeste modifiche in «62mila metri quadri di nuova superficie pesantemente trasformata ed edificata che produrrà più di un raddoppio delle dimensioni fisiche dell’attuale impianto».
Nella sostanza, dicono da Siderno, tutto quello che non era entrato dalla porta, sta rientrando dalla finestra. Quello delle nuove costruzioni rappresenta però solo la punta di un iceberg che rischia di mandare a monte l’intero programma regionale sui rifiuti: nel ricorso presentato al Tar infatti sono evidenziate tutte le criticità avanzate in conferenza di servizi e “superate” di forza dalla Regione.
La monnezza tra le eccellenze
L’impianto di San Leo è stato costruito infatti «nelle immediate vicinanze di un nucleo abitato» che nel progetto diventa invece magicamente «azienda agricola non residenziale» e, «adiacente alla fiumara Novito e quindi estremamente vulnerabile alla pericolosità idraulica della stessa». Ricade quasi interamente «all’interno dei 150 metri dalla fiumara e quindi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico». E poi l’impatto sulle produzioni agricole di pregio: la zona in cui sorge l’impianto di trasformazione dei rifiuti e che si troverebbe a dovere ospitare nuove strutture per 62mila metri quadri, ricade «in quella porzione di territorio comunale dove è più spiccata la presenza di produzioni di vino greco Doc, vino della Locride Igt e bergamotto, clementine e olio di oliva Dop».

E ancora, la strada di collegamento – che sulle carte non esiste e che nella realtà è una mulattiera sterrata costruita su una lingua di terra strappata alla fiumara e divenuta nel tempo, discarica a sua volta – e il documento definitivo di impatto ambientale che non sarebbe mai stato presentato, per una rogna sociale prima ancora che legale, che rischia di esplodere nelle mani del nuovo sindaco di Siderno. Dal canto suo, la neo eletta Mariateresa Fragomeni prende tempo: «Sono sindaca da meno di 24 ore, nei prossimi giorni leggeremo tutte le relazioni e valuteremo come muoverci anche sentendo la Regione e la città metropolitana».