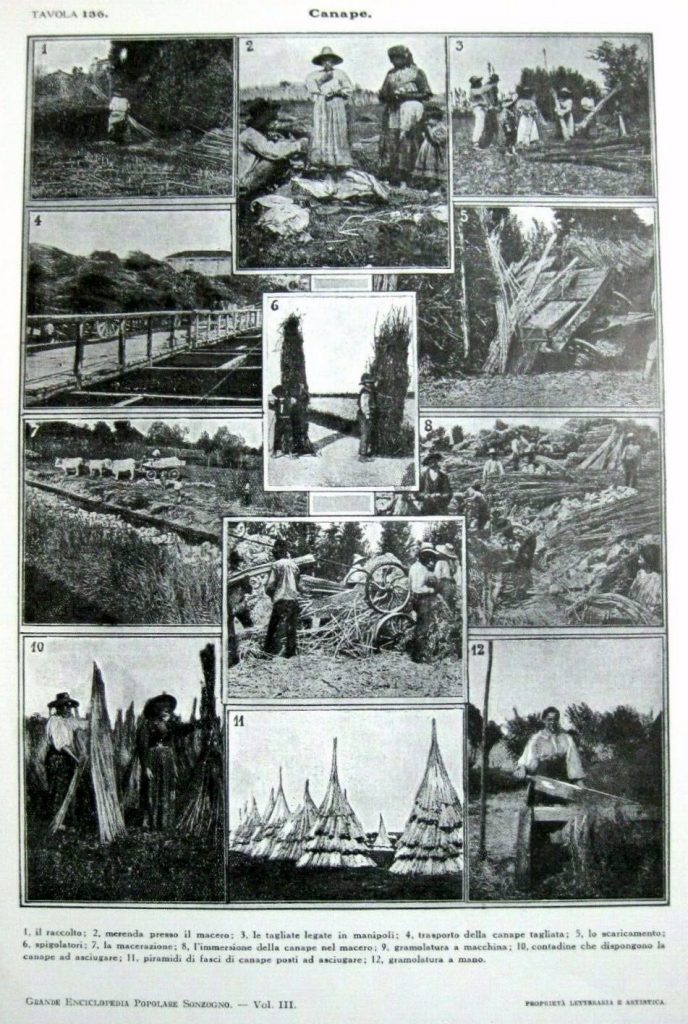[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Silvio Berlusconi disse una volta che a parlare troppo di mafia si danneggia la reputazione del Paese. Venne allora verbalmente redarguito dalle vittime di mafia e dalla società civile, eppure esprimeva un pensiero diffuso, nella politica così come nella società. Gianfranco Micciché, all’epoca candidato alla presidenza della Regione Sicilia, lo espresse con altrettanta decisione nel criticare la titolazione dell’aeroporto di Palermo: «Continuo ad essere convinto che intitolare l’aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino, significa che ci si ricorda della mafia. L’aeroporto di Palermo lo intitolerei ad Archimede o ad altre figure della scienza, figure che suscitano pensieri positivi».
La Calabria a Londra
Sulla metropolitana di Londra una sera di novembre mi trovo a chiacchierare con un signore italo-britannico. Abbiamo appena assistito alla proiezione di un film – Una Femmina – di Francesco Costabile, seguito da un dibattito con il regista collegato su Zoom dalla Calabria (sì, Francesco Costabile è di Cosenza).
Il film, potente, nero e, direbbero in inglese, chilling, raggelante, è una storia di mafia che prende spunto dalla storia di Maria Concetta (Cetta) Cacciola e di altre donne ribelli raccontate dal giornalista Lirio Abbate nel suo libro Fimmine Ribelli. Racconta la storia di Rosa, una bambina che vive in Aspromonte e assiste, senza capire, all’omicidio di sua madre Cetta a opera della nonna e dello zio, e che una volta cresciuta, vuole vendetta nella sua famiglia di ‘ndrangheta.

Non è raro che a Londra si proiettino film di questo genere – indipendenti, emergenti. Complici un cinema che ama le gemme, il Garden Cinema, un festival, il Raindance, che da trent’anni si occupa di portare sul grande schermo promettenti lavori di artisti nascenti, e una comunità italiana locale appassionata e partecipe, la proiezione di Una Femmina ha seguito infatti A Chiara di Jonas Carpignano, che a luglio scorso aveva debuttato in UK nello stesso cinema. Anche A Chiara racconta una dimensione familiare e intima della ‘ndrangheta.
‘Ndrangheta e reputazione, il niet dell’Istituto di cultura
Il signore italo-britannico sulla metro aveva assistito anche alla proiezione di A Chiara e in quell’occasione c’eravamo conosciuti. Ha letto il mio ultimo libro Chasing the Mafia (che racconta della mia ricerca sulla ‘ndrangheta nel mondo) e mi ha chiesto di autografarlo. E poi mi dice, senza forse rendersi conto del peso delle sue parole, che aveva parlato con un responsabile durante un evento all’Istituto Italiano di Cultura di Londra e aveva suggerito che si facesse un evento sulla ‘ndrangheta o sulla mafia, suggerendo che io potessi essere coinvolta nell’evento, magari aiutando a organizzarlo. Si era sentito rispondere, un po’ ridendo ma nemmeno troppo, che certo era interessante ma che forse l’Istituto Italiano di Cultura preferisce eventi che danno un’immagine positiva dell’Italia.

Certo, si possono fare eventi sulla commemorazione delle stragi – la memoria è positiva. Si possono fare eventi su questioni spinose della storia d’Italia – la storia è anch’essa positiva, quando affrontata come insegnamento. Ma parlare di mafia, di ‘ndrangheta, oggi, quello non interessa. Argomenti cupi, che restituiscono una pessima immagine dell’Italia e della Calabria, che rovinano la reputazione della regione e dunque del paese. Ovviamente non è questa un’accusa rivolta all’Istituto Italiano di Cultura di Londra, anche perché non so con chi, intraneo o estraneo, è avvenuta la conversazione. Ma non è la prima volta che mi sento dire che parlare di ‘ndrangheta non è parte del concetto di ‘cultura’ italiana, non promuove la cultura calabrese. Mi venne detto anni fa dalla direzione di un altro Istituto Italiano di Cultura in Australia: «Interessante quello che fai, ma la ‘ndrangheta non è ciò che vogliamo chiamare cultura italiana».
La Calabria che stupisce
Falso. Il film Una Femmina è girato in Calabria, in un paese che dovrebbe essere in Aspromonte, ma è invece nel Pollino. Ci sono montagne immense, verde scuro, case diroccate e rovine, costruzioni aggrappate alla montagna e una natura dalla forza dirompente. Tra gli spettatori – italiani e non – ci si chiede dove siano quei posti, dove sia tutta quella bellezza. Si cantano canzoni popolari nel film, si balla la tarantella, si intonano litanie liturgiche. Gli spettatori sono ammaliati dalla musica, invasi dalla gioia delle danze, commossi dalle liturgie. Si chiedono, persone che di ‘ndrangheta e di Calabria nulla o poco sanno, com’è possibile che in una terra così bella succedano certe cose. Ci si indigna.

Per il film A Chiara, una storia simile: c’è tutta la forza delle immagini del porto, del lungomare di Gioia Tauro, c’è la cittadina della Piana con le sue feste di paese, le celebrazioni familiari tra vino e musica. In quel caso, a chi assiste alla rappresentazione cinematografica viene da chiedersi come sia possibile che una cittadina con un porto che è il vanto del Mediterrano e una voglia di vivere prorompente nella musica e nell’intrattenimento, abbia una sorte così macabra.
Dal letame nascono i fior
E questo non succede solo per i film ben fatti. Succede per le serie tv e per i documentari, succede per i libri, quando hanno la capacità di raccontare la ‘ndrangheta, i suoi inferni privati e le sue bassezze umane all’interno di un contesto più ampio che si integra – non si separa – dalla Calabria, dalla sua bellezza ferita, dal suo potenziale inaspettato, dalla sua cultura centenaria e stratificata tra colonizzazioni, resistenza, autonomia e autoaffermazione. L’ho sperimentato io stessa, da calabrese, che non ha senso tentare di spiegare o studiare la ‘ndrangheta senza prima raccontare le incongruenze del fenomeno rispetto alla sua regione d’origine. La bruttezza vicino alla bellezza.

Grazie alla reputazione della ‘ndrangheta – quella stessa che, si badi bene, fomenta stereotipi negativi sui calabresi all’estero – l’arte produce cultura e il mondo conosce la Calabria e i suoi patrimoni. Si resta ammaliati dalla bellezza sugli schermi, si leggono la storia e le storie sui libri, si apprezza la civiltà e l’umanità del popolo calabrese, si ascolta il dialetto, si sfoglia la letteratura da Corrado Alvaro a Gioacchino Criaco, si ammira l’intraprendenza contadina.
‘Ndrangheta, Calabria e cultura
Il problema non è che la ‘ndrangheta non sia cultura, e peggio ancora che distrugga la cultura e la bellezza della Calabria, o che rovini la reputazione dell’Italia. E il problema non è nemmeno che a furia di parlare di ‘ndrangheta, dell’organizzazione mafiosa più importante d’Italia e tra le più importanti al mondo, si oscura il patrimonio – positivo – della Calabria. Il problema è forse proprio il contrario. Che si insiste nel pensare alla ‘ndrangheta come corpo estraneo alla regione, un virus, una forza malvagia e aliena, dai confini chiari e precisi – diversa da noi – alimentata di uomini (e occasionalmente donne) il cui unico scopo è abusare del patrimonio e della ricchezza di una regione altrimenti bellissima e dal potenziale enorme.

Una rimozione che deriva forse dalla paura di identificarsi con il fenomeno stesso: se la ‘ndrangheta è figlia della sua terra e della sua cultura (in modo distorto e abusivo certo), cosa dice tutto ciò di noi Calabresi? Lo diceva bene Nietzsche: «Chi lotta con i mostri deve guardarsi di non diventare, così facendo, un mostro. E se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te». L’alternativa non può essere quella di evitare di guardare nell’abisso o di negare i mostri. Perché è nell’alternanza di ombra e luce, nelle guerre contro i mostri, nei racconti delle emozioni e nelle sublimazioni delle paure, è in questi spiragli che si fa cultura.
Cicatrici di cui andare fieri
Continuava Micciché su Punta Raisi: «Ritengo, comunque, che sia una scelta di marketing sbagliata… Non ci si presenta ai tanti turisti con il sangue di una delle più profonde e, ancora non sanate, ferite della nostra terra». Eppure, come ci ricorda la pratica nipponica del Kintsugi, la cultura aiuta a trasforma una ferita in bellezza: mostrare con orgoglio le cicatrici è solo un racconto sulla forza della resistenza e sulla voglia di riparazione.