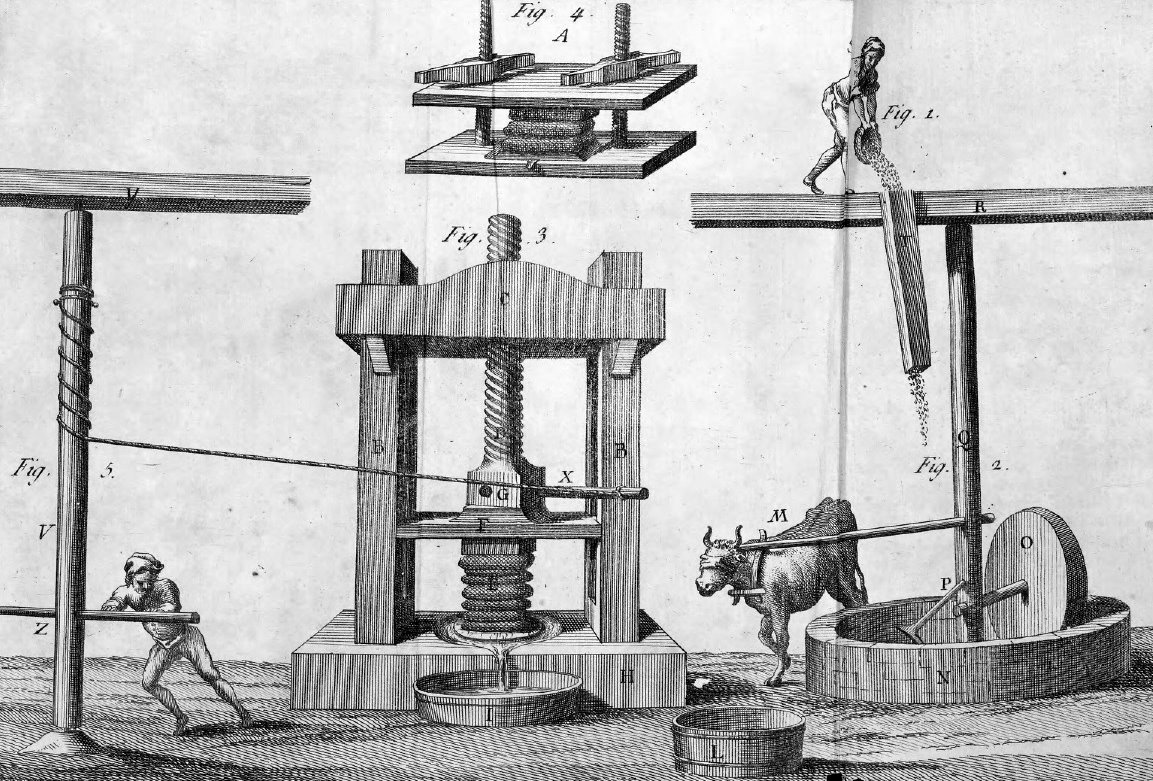[…] Un altro dei simboli popolari della crisi d’identità che affligge oggi la Grande Cosenza è il calcio cittadino. Precipitato nelle polemiche della gestione Guarascio e ben al di sotto dei fasti del passato. Un adagio ben noto tra gli appassionati di pallone dice che la piazza calcistica di Cosenza ha un tifo da serie A, una storia da serie B e una dirigenza di quarta serie. Oggi la squadra che fu arena consacrata da atleti simbolo come Bergamini e Marulla, è rimasta orfana di calciatori-bandiera. Quelli che segnano un’epoca e diventano leggenda, anche lontano dai campi di calcio.
[CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DELL’ARTICOLO]
Un bar semideserto
Una serata fredda di dicembre di anni molti fa, un po’ prima di Natale ero in un bar di Roges, periferia urbana di Cosenza, e mi capitò di incontrare forse l’ultimo dei grandi pedatori passati dal prato declassato del San Vito-Marulla di Cosenza. C’era un’aria ferma, i vetri appannati. Fuori quasi si gelava per la gala di ghiaccio che scende dalla Sila. Dentro solo pochi avventori. Un paio seduti a un tavolino. Poi io e una mia amica bionda che rivedevo dopo molto tempo. Un po’ di chiacchiere lontano dagli affanni.

Solo, in piedi, affacciato sui gomiti davanti al banco, c’era un ragazzo magro e dinoccolato. Un tipo sopra la trentina, i capelli lunghi tirati indietro a coda, fermati da un elastico. Qualche filo di grigio già a inargentare le tempie. Un orecchino gli dava invece un’aria un po’ truce. La ragazza che serviva dietro al bancone con lui fa la gatta. Si mostra, si affaccia col petto sul bancone. Gli fa smorfie per invogliarlo. Lui sembra il più annoiato e taciturno dei presenti. Addosso ha una tuta sportiva e un marsupio, calza scarpe da ginnastica. Ha la faccia stanca e un’aria persa e stralunata. I suoi gesti sono lenti, come rappresi nell’aria. Poche parole scambiate con la barista gli escono di bocca come spezzate dalla noia dell’abitudine.
«Un lattuccio»
Potrebbe essere uno dei tiratardi, borgatari del posto. Però parla troppo basso, senza la voga strascicata di questi rioni di periferia. Un buon italiano corretto e senza accenti, che gli esce di bocca con un rintocco gentile e malinconico. A un certo punto è lui che si rivolge alla ragazza del banco, dopo che lei gli aveva chiesto con smorfie più insistenti cosa poteva preparargli. Lascia cadere l’invito in una pausa che dura quasi un minuto, l’aria assente. Poi le dice piano piano: «Per favore puoi scaldarmi un lattuccio?». Dice proprio: «un lattuccio».
Uno così mi sembra d’averlo già visto, lontano da questo bar di periferia. Certe cose non sono mai come te le immagini. Quella sera nel freddo di quel bar di Roges mi sono chiesto cosa stava a farci a Cosenza in una squadretta da campetti parrocchiali scivolata nell’inferno della D uno bravo come lui. Prima di ricominciare dalla quarta serie del pallone, gli avevano offerto di nuovo soldi buoni e ingaggi di prestigio la Fiorentina in B e pure la Sampdoria in A. Ma quel ragazzo triste aveva preferito il Cosenza in D ed era pronto a dare una mano alla squadra che aveva lasciato in B prima del fallimento.
Capitani impolverati
E invece era stato messo fuori squadra da allenatori da oratorio. Si era allenato, ma è chiaro che in D non erano i suoi soliti ritmi. Non si gioca di fino sui campetti spelacchiati dei semiprofessionisti. Sono ring da zuffa, rettangoli sconnessi dove si suda e si sgomita senza complimenti. Dicevano che ormai era spompato, che gli mancava la partita vera. Ma aveva lavorato con gli altri per fare il capitano, per presentarsi bene. Non giocava, ma non se l’era sentita lo stesso di lasciare Cosenza.

Chissà se c’è un vero perché in storie così. Forse era rimasto per un amore che voleva resuscitare, forse per la speranza di ricominciare in provincia una vita normale dopo le mille illusioni ruffiane del grande calcio. Forse a 35 anni Gianlugi Lentini era solo un uomo che non aveva più voglia di rientrare nel tritacarne del sistema-calcio. Uno che viene solo per tirare calci alla palla, che gioca solo per giocare e non per caricarsi di responsabilità che ti schiantano, di nuove delusioni. Pensai che forse era rimasto perché ancora, non importa su quale campo, davvero gli piaceva correre così come sapeva fare lui. Scartando e caracollando dietro a una palla persa per inventare un cross che non ti immagini, per cercare lo spazio più imprevisto, come un acrobata che rimane in bilico sul filo bianco teso a bordocampo.
Campioni malinconici
Forse a Cosenza ci si poteva stare senza farsi male, perché in un bar di periferia, da solo in una serata fredda di dicembre, uno come lui, un campione vero, può chiedere «un lattuccio» alla ragazza che serve al bancone senza vergognarsi, senza sentirsi addosso tutta la nostalgia e il peso del declino. Un artista malinconico del football, Lentini. La sua era una storia di passione luminosa, di grandezza vera. Di quelle rare nel calcio già ridotto a un Barnum per televisioni e affaristi magliari.
Sarà sempre così. In questo sport contano gli incanti della fantasia, le ascese degli uomini quanto le cadute. Senza la passione il football è una cosa morta. Solo 22 uomini grandi e grossi che corrono su un prato e danno calci ad una palla. Sono solo la passione e la fantasia che ci mettono certi giocatori di genio a farlo diventare una cosa importante, una cosa estetica. Un istante di bellezza adolescente, un’acrobazia figurata che somiglia all’arte.
Tre generi di giocatori
Sono passati molti anni da quella sera, ma ricordo bene. Il Cosenza di adesso se la batte malissimo in B, una squadra raccogliticcia, senza capitani veri e uomini simbolo come fu Lentini. Raccolgo a mente i ricordi e gli ultimi istanti di quello strano incontro in una notte d’inverno al bar di Roges. Non c’erano stelle in cielo, e nemmeno la luna. Tirava il vento della Sila, quella tramontana che taglia la faccia. Io e la mia amica ci avviamo senza parlare. Poi mi torna in mente un grande racconto all’interno di Fútbol di Osvaldo Soriano.
«Lo conosci?», chiedo alla mia amica distrattamente, prima di accompagnarla fuori nelle strade senza nome di quella periferia. Ad un certo punto, le dico che c’è una pagina in cui Soriano scrive che “ci sono tre generi di calciatori. Quelli che vedono gli spazi liberi, gli stessi spazi che qualunque fesso può vedere dalla tribuna, e li vedi e sei contento e ti senti soddisfatto quando la palla cade dove deve cadere. Poi ci sono giocatori che all’improvviso ti fanno vedere uno spazio libero, uno spazio che tu stesso e forse gli altri avrebbero potuto vedere se avessero osservato attentamente. Quelli ti prendono di sorpresa. E poi ci sono quelli che creano un nuovo spazio dentro un rettangolo di gioco, dove non avrebbe più dovuto esserci nessuno spazio, nessun pallone”.
Quello lì, quello che alla barista lì dentro chiedeva di scaldargli «un lattuccio», è uno di loro. Uno di questi profeti dell’innocenza che inventa figure impossibili, uno che aveva nei nervi quel tremore che spinge gli uomini a giocare su un prato dietro a una palla di cuoio. È un poeta sconfitto, era un astro tramontato del gioco del pallone. Tu non lo conosci. Si chiama Gianluigi, Gigi Lentini, era un campione.

Prima di andare via dal bar con la mia amica, mi sono avvicinato. Ho chiesto un autografo a quel ragazzo dalla faccia triste. Sorrise, sorpreso che qualcuno lo avesse riconosciuto in quel posto, a quell’ora, in quella situazione. Qualcuno che si ricordava di lui come calciatore, quando fino a qualche anno prima calcava i palcoscenici del calcio vero. Lentini scrisse su un pezzetto di carta, con una biro che le passò la ragazza dietro al bancone, calmo e gentile. Poi quasi sottovoce mi chiese per chi era l’autografo. «È per mio figlio», rispondo io. Non è vero. L’ho tenuto per me.
Cosenza oggi
Oggi Cosenza per me è questo: l’aria di periferia di certi bar e negozietti fuori moda, certi angoli svisti tra i palazzoni di periferia, l’odore delle cucine che la domenica preparano il pranzo di buon’ora tra le case popolari. Rumore di stoviglie, i balconi spalancati sul mattino, i panni stesi, le stanze che si affrettano al riordino. Un vecchio in pigiama che è sceso nel cortiletto di una vecchia casa colonica assediata dal cemento ad annaffiare del basilico che cresce in una grossa lattina di conserva arrugginita. Una imprecazione che sembra un proverbio antico, qualche risata di gola che arriva da lontano, una donna che rimprovera un bambino in un dialetto che sa ancora di cantilena.
Sullo stradone il camioncino del venditore viaggiante di patate della Sila che chiama a raccolta donne col suo verso da muezzin, la macchina con gli scarichi truccati che passa correndo via e lo stereo acceso forte sulle canzoni di un cantante neomelodico. Il buongiorno di una domenica qualsiasi in un posto senza grilli per la testa, le officine e i gommisti che armeggiano tra i marciapiedi e le strade piene di buche, il mercato degli ambulanti, i saluti e la festa del mattino nel quartiere popolare in cui sono venuto ad abitare da un paio d’anni.
La città-chimera
Da qui, da questo margine, si dileguano come in una nebbia opalescente le sagome tristi della teoria infinita di casermoni, strade e circonvallazioni, luci al neon, semafori intermittenti e file d’auto incolonnate nel traffico del rientro pomeridiano. La vita che ristagna tra le siepi di palazzoni multipiano degli attici in vetrocemento che riflettono il profilo scialbo della Grande Cosenza. La città-chimera, che non c’è mai stata e che non si farà. E con lei eclissa forse per sempre da queste sponde antiche anche il mito della città ribelle, socialista, colta, libertaria.

Restano solo le spoglie del suo centro storico svuotato di senso e popolato solo da invisibili e clandestini. La ridotta sbriciolata dei palazzi patrizi di Cosenza Vecchia, nobile e decaduta, e fuori da quella cerchia vetusta, a far perno nel vuoto del cielo invernale solo il lungo traliccio strallato del ponte di Calatrava. Poi le orbite involute del traffico e i pilastri di cemento armato di quella foresta di cubature sfuse che occupa lo spazio sfilacciato come una bandiera al vento che si prolunga per miglia e miglia oltre i ponti nella valle del Crati.
Una periferia senza centro
Il fiume di cemento si arresterà mai prima di sboccare la sua corsa finale verso lo Ionio? Fin lì Cosengeles per ora è solo un groviglio di centri commerciali, strade che si perdono nella campagna scassata dagli abusi, tra gli avamposti delle burocrazie e del terziario rigonfiato. Cosenza è oggi un organismo aspira-tutto che prospera risucchiando il vuoto intorno a sé e assommando intorno ad un’enorme periferia senza centro tutta la popolazione di giovani che si raccoglie nei paraggi dell’Università.

Qui si radunano nel posatoio provvisorio degli studi, delle lauree tecnologiche e delle specializzazioni da Silicon Valley in riva al Crati, i pochi giovani rimasti a vivere in tutta la Regione. Ma anche loro restano giusto il tempo di ripartire. Prima che volino via altrove, come uccelli di passo. Un flusso provvisorio che ancora per un po’ terrà viva Cosenza e tutta la sua cosiddetta area urbana.
Mito e apparenze
È questa in fondo l’unica forza viva che alimenta da quarant’anni il mito della Grande Cosenza. Un mito provvisorio che sembra di tanto in tanto risorgere senza mai diventare vero oltre le apparenze. Ma solo perché è la Calabria intera che si squaglia intorno a Cosenza, che ogni giorno rimpicciolisce e diventa sempre più scarsa, più scolorita e spaesata.