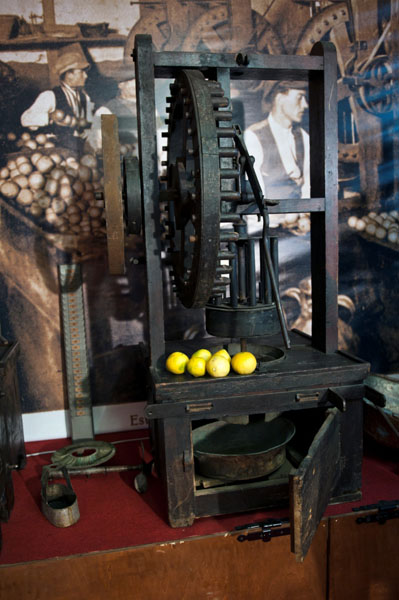Ancora sul nostro Nord-Est… Perché visitare Canna? Perché è un involontario set cinematografico fatto di pietra, o perché è un pezzo di Sette-Ottocento arrivato sano sano fino a noi. Canna resta per nulla indagata (e non mi correggo: il femminile, messo inavvertitamente, si giustifica in realtà con la parlata locale, che vuole si vada ‘alla’ Canna, che si sia ‘della’ Canna e così via) e la bibliografia locale è muta, non esistendo neppure un solo libro sulla storia generale del paese, e sì che meriterebbe. Vi si stava accingendo il compianto Salvatore Lizzano e dispiace che il suo decesso prematuro non gli abbia consentito di ripetere i risultati già ottenuti nell’altra sua opera, quella su Roseto Capo Spulico.
Canna, il paese dei portali
Altra ragione per scegliere di addentrarsi tra i vicoli di Canna sta nel fatto che il suo patrimonio araldico è stranamente e quasi sfrontatamente superiore a quello di qualsivoglia paese dello stesso circondario, se non di tutta la Calabria: tra le quinte di una ridottissima manciata di stradine si accalcano infatti ben undici portali di qualche rilevanza artistica, per un totale di ben quindici stemmi. Questa densità non si spiega in altro modo, in un borgo tanto minuscolo, se non attraverso una sola interpretazione: la storia di Canna va sempre letta in stretta connessione con quella di due paesi limitrofi, Rocca Imperiale e Nocara.
Ma mentre Rocca Imperiale restituisce visivamente l’impianto medievale, col castello posto in cima a un rovescio di case popolaresche digradanti verso la piana che conduce al mare, Nocara rimanda, al contrario, all’idea di un vecchio avamposto d’avvistamento, una sorta di accampamento rude, diventato poi stanziale sulla cima della sua scarpata inospitale. In mezzo a questi luoghi – e dunque, volendo, tra autorità, popolo e difesa – si piazza Canna, che appare subito come qualcosa di diverso, una sorta di appartato buen retiro per la nobiltà e la borghesia locale.

Status symbol di una volta
Intendo dire che a Canna deve essere successo qualcosa, ed esserci stato quantomeno un momento in cui il paese cominciò ad essere letteralmente di moda, quando possedervi un palazzo con un portale pregiato e possibilmente uno stemma dovette essere una sorta di status symbol irrinunciabile per il notabilato del circondario. Aggiungo: una cappelletta privata, eventualmente annessa al proprio palazzo nobiliare, e con campana propria, era un valore aggiunto. Un po’ come oggi la piscina per le ville. Sono almeno sei i palazzi cannesi che hanno o hanno avuto cappelle annesse:
- Toscani,
- Ricciardulli,
- Campolongo,
- Troncellito (poi Bruni),
- Crivelli (poi Favoino)
- Crivelli bis (poi Pitrelli).

Scripta manent
E poi c’è qualcosa di anche più antico, e sempre scolpito nella pietra (evidentemente a Canna o si scrive per sempre o non si scrive): un’iscrizione rozza e piccola, apposta nel 1605 in cima alla parete esterna di Palazzo Rinaldi, si palesa nientemeno come frammento di un distico di Catone (I, 5): NEMO SI/NE CRIMI/NE VIVIT, inno a un’indulgenza fatalista che mi richiama alla mente due cose. Innanziuttto l’adagio napoletano “e si tiene figli mascule, nun chiammà mariuolo, e si tiene figlie femmene ecc. ecc.”, e poi quell’altra citazione latina che troviamo a Cosenza, su una chiave di volta nel rione Portapiana, dove viene scomodato Orazio (Odi, III, 3, 8) e il suo verso “IMPAVIDU[M] / FERIENT / RUIN[A]E” che il poeta riferiva all’inattaccabile rettitudine umana mentre, con tutta probabilità, il committente cosentino deve aver riferito alle sorti dell’edificio dopo il terremoto del 1638.

Ma restiamo “sulla” Canna: un’altra iscrizione, più antica e altrettanto consunta, è quella di una lapide cinquecentesca poggiata oggi su un muretto di pietra a secco, che credo possa essere sciolta così: HA[N]C ECCL[ESI]AM F[IERI] FECER[UN]T PLURES [CON]FRAT[RES] / […]CO TARENTINO DE CANNA A[…] / [SANC]TISSIMI ROCCHI S[TATUERUNT] A[NNO] D[OMINI] 1529. Delizia per i paleografi, questa lapide potrebbe essere proposta all’esame di archivistica, visto che si presenta come spaventoso compendio delle più svariate brachigrafie (abbreviature per contrazione con lineetta sovrascritta, per troncamento finale con lettere sovrapposte e finanche con segni abbreviativi propri… ma non mi dilungo).

Non solo Canna
E dicevamo dei portali… la loro presenza così fitta mi aveva spinto, qualche tempo fa, a svolgere una ricerca mirata ad una specie di improbabile censimento di quelli del circondario altoionico calabro-lucano, e almeno di quelli che avessero caratteristiche comuni ai tanti portali cannesi. Finii per impelagarmi invece in una sorta di genealogia delle maestranze artigiane locali, che però la dice lunga, anzi lunghissima, proprio in termini geografici. I portali ‘alla cannese’ – con o senza stemma – hanno valicato i confini calabri pur essendo scolpiti senza alcun dubbio dalla stessa mano (o dallo stesso paio di mani) e sono decisamente più di quelli che ci si potrebbe aspettare. Una prima traccia, dunque, della mobilità delle maestranze.
Provare per credere, confrontando – se solo si avesse la pazienza – i palazzi:
- Mazzario, a Roseto Capo Spulico (1821);
- De Pirro, a Nocara (1825);
- Carlomagno, a San Giorgio Lucano (1826);
- Tarsia (poi Troncellito, ora Bruni), a Canna (1845);
- Rinaldi, a Noepoli (1845);
- Mesce o Morano (ora Rago), a Canna (1846);
- Crivelli (poi Pitrelli), a Canna (1848);
- Pignone (poi Minieri, ora Solano), a Montegiordano (1860);
- Troncellito (ora Marcone), a Senise;
- Donnaperna, a Senise;
- Guida, a Tursi;
- Giannettasio, a Oriolo Calabro;
- Tarsia-Sanseverino (poi Toscani), a Canna;
- Melazzi, a Canna;
- Silvestri, a San Giorgio Lucano;
- Camodeca, a Castroregio;
- Pace, a San Costantino Albanese;
- Ricciardulli, ancora a Canna.

Fermiamoci un attimo: intanto, giusto per rimanere in tema di citazioni classiche, non mi va di tralasciare altri due motti, ovvero quello del Palazzo Rinaldi di Noepoli (VIS UNITA FORTIOR) e poi il motto sullo stemma del penultimo dei palazzi citati, nientemeno ΚΑΤΕΦΙΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ, deformazione della traduzione greca del salmo 84.11 (ελεος και αληθεια συνηντησαν δικαιοσυνη και ειρηνη κατεφιλησαν): “misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno”. Poi va annotato da qualche parte, a futura memoria, che lo stemma di Palazzo Melazzi di Canna – di cui resta ora, solitario e allusivo, il gancio – è da individuare senza alcun dubbio nello stemma che oggi campeggia – in linea con intricati passaggi ereditari – sul Palazzo Blefari Melazzi di Amendolara, il cui portale fu realizzato in tutt’altro stile e materiale.

I fratelli Calienno
E fin qui si tratta di proprietari bizzarri. Ma, per non allontanarci dalla genealogia delle maestranze, bisogna notare altre due “firme”: il primo di questi palazzi riporta, sotto la chiave di volta, la dicitura M. RAFAE. E / PASCA. CALIE., mentre il Palazzo Crivelli (poi Pitrelli) di Canna porta sull’architrave la dicitura PASCALIS CALIENNO FECIT. L’enigma è fin qui parzialmente risolto. Ora, senza addentrarmi nella descrizione di tutte le peripezie della ricerca storica, si viene a scoprire che Raffaele e Pasquale Calienno erano due fratelli evidentemente attivissimi tra Calabria e Lucania almeno nella prima metà dell’Ottocento.
Di più, a questo punto dobbiamo attribuire loro il copyright di un vero e proprio stile inconfondibile, perché il loro portale è sempre uguale, quale che fosse il committente. Andrebbe definito, volendo dargli vera e propria dignità di tipo architettonico, “modulo Calienno”. Confrontiamo un leone scolpito dai Calienno e uno dei leoni sui portali a loro solamente attribuibili: la mano è assolutamente la stessa, è quella mano che taglia la criniera in modo netto, dal garrese al petto, che scava oltremodo l’occhio, che allunga a dismisura la lingua e si fa goffa nell’eseguire gli arti posteriori.

Scarpari, cappellari, falegnami ed ebanisti
Ma la farina è tutta del loro sacco? Proprio per niente. Cosa sappiamo di questi Calienno, richiestissimi e abili scalpellini (ma un po’ meno abili disegnatori di leoni)? Da quanto si può ricavare dagli atti dello Stato Civile di Amendolara (le tracce sono più lì che altrove), Pasquale è meno rintracciabile, mentre il nucleo familiare di Raffaele è abbastanza completo: “scalpellino e marmoraro”, nasce a Napoli – da Salvatore – intorno al 1798 e muore ad Amendolara nel 1869. Ma si scopre anche, con qualche triplo carpiato con avvitamento, presso quale scuola artigiana avessero appreso l’arte.
Se si ficca il naso tra gli atti ottocenteschi dello Stato Civile della città di Napoli, si nota che i non pochi Calienno sono per la maggior parte servitori, camerieri, domestici, portieri. A parte un cappellaro, uno scarparo e due falegnami generici, troviamo solo due artigiani indicati con la più sottile definizione di ebanisti. Ma nessuno scalpellino. La pietra, insomma, non è cosa loro e l’arte deve essere stata appresa altrove e forse proprio in Calabria.
Scalpellini da generazioni
E, come volevasi dimostrare, si scopre che Raffaele Calienno sposa una giovane amendolarese nata in una vera e propria stirpe di scalpellini e mastri fabbricatori, strettamente legati da generazioni a questo mestiere: scalpellino il suocero, il fratello e il padre di questi, il loro nonno castrovillarese e gli antenati di quest’ultimo, provenienti da Cetraro (dove erano stati addirittura incaricati, nel 1761, della ristrutturazione della Torre di Rienzo) e, prima ancora, da Rogliano.
E, si sa, quello delle stirpi artigiane roglianesi ha sempre costituito un vero e proprio monopolio artistico (proprio la chiesa cetrarese di San Benedetto fu oggetto di abbellimenti da parte di maestranze roglianesi), la cui accortezza ha lasciato testimonianze celebri sia in ambito scultoreo che architettonico. C’è poco da fare, quindi: per una volta si può dare a Cesare quel che è di Cesare: il “modulo cannese” è tutto, essenzialmente e orgogliosamente, calabro: peregrinato dal Savuto al Tirreno e poi allo Ionio, oltre la Lucania non s’è azzardato a metter piede. Dicesi autoctonia.