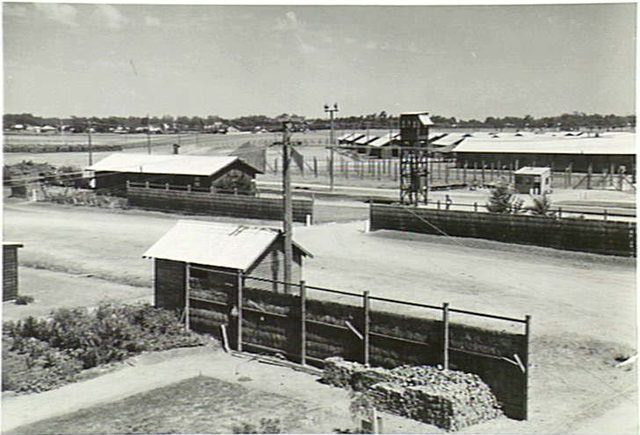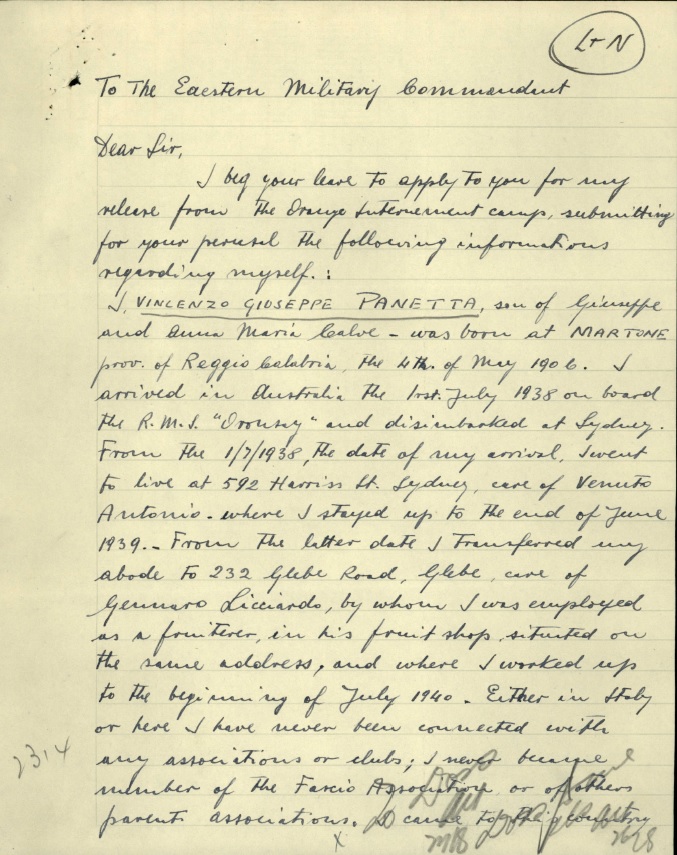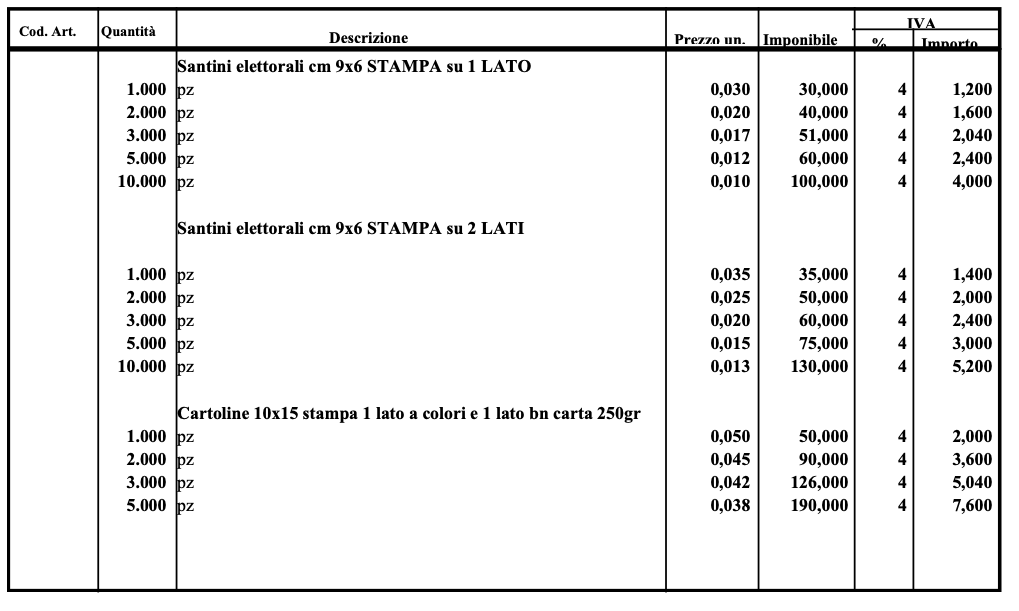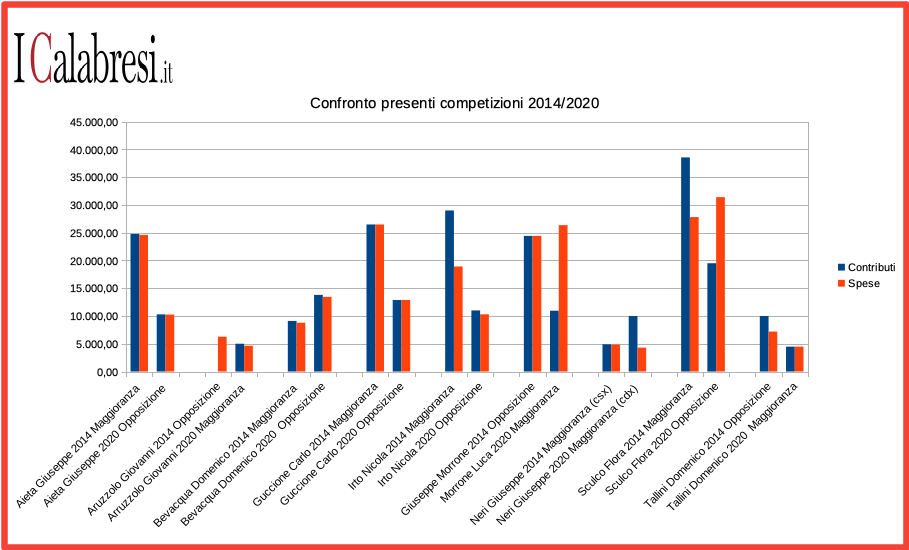In Argentina, a metà degli anni ’70, c’è un uomo alto alto che passa le giornate a trovare il modo di salvare vite. Fabbrica uno a uno i documenti che servono per spedire donne uomini e bambini lontano dalla violenza del regime argentino. Riesce a salvarne centinaia ma, ciononostante, dorme con il dispiacere di non aver potuto fare nulla per tantissimi altri di quelli che hanno bussato alla sua porta. Passa e ripassa a mente i loro volti, cerca di capire cosa può fare per capire che fine hanno fatto, se in qualche modo possono ancora essere salvati. Va avanti così per molti anni E per un ragazzo in particolare: suo nipote Eduardo.
Il sindaco emigrante
È una storia, quella di Filippo Di Benedetto, che inizia sulle pendici del Pollino, a Saracena. Quinto di sette figli, assorbe la passione per gli ideali comunisti da suo padre, Leone di Benedetto, il primo abbonato al quotidiano comunista L’Unità. Lavorava in una piccola falegnameria e affiancandosi all’opera del pedacese Fausto Gullo, durante gli ultimi anni del regime fascista, all’età di 21 anni, contribuì a organizzate le prime proteste antifasciste del comprensorio. Per questo fu arrestato, torturato e rinchiuso nel carcere di Castrovillari nel 1943. Poi cadde la dittatura e alle prime elezioni democratiche del 1947 divenne sindaco di Saracena.

Organizzò una manifestazione in paese contro chi si opponeva a portare il servizio idrico nelle case di campagne: un corteo che quando arrivò nei campi trovò la strada sbarrata da un cordone di uomini in divisa con i fucili pronti a sparare. «Sparate a me», disse Di Benedetto mettendosi alla testa del corteo, ma «nessuno tocchi questi lavoratori». Un episodio rimasto negli occhi dei molti presenti a lungo, che tuttavia non lo aiutò a far crescere le condizioni economiche della sua comunità, alle prese con un dopoguerra ricco solo di miserie e soprusi.
«Sparate a me», disse Di Benedetto mettendosi alla testa del corteo, ma «nessuno tocchi questi lavoratori»
Con il Comune in grave dissesto, la sua decisione nel 1952 fu quella di provare a raggiungere suo fratello Orlando in Argentina. Avrebbe cercato di rimettersi in forze e di tornare a Saracena, ma gli eventi della vita ebbero il sopravvento e dall’Argentina tornò in Calabria diverse volte, ma come faceva un emigrante.
Ebanismo e sindacato
A Buenos Aires diventò Felipe per gli affetti, e sposò una calabrese emigrata che si chiamava Rosa Garofalo, originaria di Cosenza. Ebbero due figli maschi, Mario e Claudio. Di Benedetto imparò il mestiere di ebanista e provò a integrarsi nella nuova realtà, piena di emigrati come lui. La passione politica lo aiutò parecchio: si iscrisse al Partito comunista e nel 1975 fu nominato responsabile del patronato Inca Cgil di Buenos Aires. A centinaia si rivolgevano a lui per questioni sindacali e ancora di più quando iniziò a frequentare l’Associazione calabrese di Buenos Aires, della quale fu eletto presidente nel 1976.

Non era un periodo facile, l’Argentina, in quel momento l’ultimo baluardo democratico del Cono Sud dell’America latina stava per capitolare sotto i colpi di un conflitto latente. Il 24 marzo del 1976 arrivò il colpo di Stato, e in poche settimane la repressione si fece durissima, fino ad arrivare al crimine contro l’umanità noto come “Sparizione forzata”. A migliaia furono presi clandestinamente, incarcerati, torturati, uccisi e fatti sparire.

Sulle orme di papà
Oggi Claudio Di Benedetto, proprio come faceva il papà a Buenos Aires, restaura mobili antichi alle pendici del Pollino, a Castrovillari. Negli anni ’80 ha vinto una borsa di studio in restauro del mobile e ha svolto un corso di perfezionamento in Brianza. Poi ha deciso di vivere in Calabria.
«Mio padre veniva due o tre volte all’anno in Italia. Portava in Argentina i prodotti locali della Calabria e parlava in dialetto calabrese. Perciò, qui era tutto familiare e mi colpì della Calabria la natura: 10 minuti il mare, 10 minuti la montagna… tutto vicino, mentre in Argentina abbiamo delle lunghe distanze difficili da coprire, e un brutto clima. Soprattutto a Buenos Aires».
Riprese di Gianluca Palma, montaggio di Marco Mastrandrea.
L’intervista fa parte dell’Archivio Desaparecido, un progetto di memoria attiva promosso dal Centro di Giornalismo Permanente di Roma
Claudio è molto fiero della storia del padre, anche se è cosciente che per l’indole schiva del carattere che ha ereditato se n’è parlato poco e niente. «Successe che un giorno nel suo ufficio incominciarono ad arrivare alcuni genitori di origine italiana. Raccontavano che alcuni dei loro figli erano stati rapiti e non avevano avuto più notizie di loro. Così mio padre, immediatamente, va a chiedere spiegazioni sia all’ambasciata che al consolato italiano di Buenos Aires, dove era conosciuto. Da parte delle autorità italiane bocche cucite però: nessuna informazione. E questo fa capire la complicità del governo italiano con quella giunta militare».
L’unico ad aiutarlo
A Buenos Aires, a quei tempi un’autorità italiana che ha deciso di non rimanere cieca davanti a tutto quello in realtà c’è. Si chiama Enrico Calamai e fa il viceconsole. La storia lo riconosce come un gigante, sono innumerevoli le opere che raccontano il suo impegno, nel 2004 è stato decorato dall’Argentina con l’Orden del Libertado General San Martín e il suo nome figura fra quelli del Giardino dei Giusti a Milano. Nella sua biografia ricorda il contributo di Di Benedetto, è fra i pochissimi ad averlo fatto: «Aveva una tosse infernale, una giacca logora, ma sapeva da quale impiegato delle Poste andare per spedire un telegramma senza essere denunciato».

Ai tempi a Di Benedetto diede anche un consiglio importante, lo ricorda il figlio Claudio: «Decisero insieme di aiutare vite umane, salvando centinaia e centinaia di persone da morte sicura; aiutandoli a espatriare anche con passaporti falsi, nascondendo molti di loro in luoghi sicuri e denunciando alle autorità italiane quello che stava succedendo. Io mi ricordo che Calamai molte volte diceva: ‘Filippo, non ti esporre in questo modo… io sono un console, ho l’immunità, ho la scorta, ma tu non hai nessuno che ti protegge. Così metti a repentaglio la tua vita e quella della tua famiglia’. Ma mio padre continuò a salvare vite».
Eduardo è sparito
Ha continuato fino a quando è stato possibile, cercando di non raccontare a nessuno cosa faceva. In famiglia non ne parlava mai, teneva separati gli ambiti, anche perché era molto pericoloso. Difatti, dopo poco tempo, l’orrore che stava piombando nel cuore della notte di migliaia di case argentine bussò anche alla porta di casa Di Benedetto. Domenica Maria Alba Di Benedetto, figlia di suo fratello Orlando, insieme al marito Antonio Eduardo Czainik, vennero presi dagli squadroni della morte mentre erano intenti ad accompagnare a scuola i due figli. Vennero portati in un centro clandestino di detenzione, dove furono brutalmente torturati. Perché?
Eduardo era nato nella capitale federale il 27 aprile del 1947 e faceva il meccanico in un’officina a Posta de Pardo, Ituzaingó, Buenos Aires. Era un militante del gruppo rivoluzionario Forze Armate di Liberazione 22 agosto (FAL 22), ecco perché era su una lista. Ufficialmente risulta sequestrato il 25 agosto 1977 in via Nazca 920, dove abitava. Al quotidiano argentino Pagina/12 Christian Czainik, uno dei figli di Eduardo, ha raccontato che la famiglia riuscì a ottenere qualche informazione attraverso canali non ufficiali, ma che queste informazioni non sono servite a nulla perché hanno respinto il ricorso di habeas corpus e la denuncia al Ministero dell’Interno presentate dalla madre.
Il cruccio più grande
I tentativi furono i più disparati, Domenica in quegli anni ha girato in lungo e in largo le caserme alla ricerca del marito, riuscendo a incontrare anche il celebre agente dei servizi Raul Guglielminetti, ritenuto l’uomo che avrebbe portato gli archivi segreti della dittatura in Svizzera, più avanti processato in Argentina per aver sequestrato imprenditori a scopo estorsivo. Nulla è servito a sapere qualcosa di Eduardo, desaparecido all’età di 30 anni.

Di Benedetto prendeva informazioni e segnalava più casi di giovani perseguitati possibile, si spingeva fino al limite, ricevendoli nel suo ufficio e accompagnandoli in consolato. Li nascondeva fino al rimpatrio permesso dall’opera diplomatica di Calamai. Rischiava grosso, ma riuscì a contribuire al salvataggio di più di 300 persone, secondo le stime ufficiali. Moltissimi riuscirono a farsi passare per turisti, arrivarono in Italia e scamparono a una fine orribile anche grazie all’impegno di Filippo Di Benedetto, ma fra loro non c’era il nipote Eduardo. Per lui non ci fu niente da fare, era troppo tardi, e questo fu un cruccio che si portò appresso per tutta la vita.
Di Benedetto muore in Argentina nel 2001 sostanzialmente in povertà, senza nemmeno gli onori della cronaca. Solo 18 anni dopo, il 7 settembre del 2019, a Saracena decidono di intitolargli una strada. L’evento non ha l’eco che meriterebbe, ma in prima fila c’è un uomo che ha fatto tanta strada per esserci. Prende il microfono e di Filippo Di Benedetto dice: «Eravamo in contatto continuo e lo ricordo come una persona di un grande calore umano, generosa, molto umile e pure pieno di una grande saggezza ed intelligenza, di una grande cultura vera di civiltà». Parola di Enrico Calamai.











 A tenere una tragica conta delle vittime e a chiedere giustizia e interventi strutturali è, da anni, l’associazione Basta vittime sulla SS 106. Almeno un morto al mese tra il 2014 e il 2018. E ben 200 vittime in sette anni. Con la morte del brigadiere Romeo e della moglie, è salito a 15 il numero delle vittime nel 2021. Quindi, siamo già oltre l’inquietante media. Si è rivelato un dato fuorviante il calo degli incidenti (circa del 20%) nel 2020. Con le vittime scese a 11, mai così poche dal 1996. Ma era tutto dovuto, evidentemente, alle restrizioni emesse per contenere la pandemia da Coronavirus. E, quindi, alla ridotta mobilità. Con il ritorno alla “normalità”, la SS 106 ha ricominciato a uccidere come e più rispetto agli altri anni.
A tenere una tragica conta delle vittime e a chiedere giustizia e interventi strutturali è, da anni, l’associazione Basta vittime sulla SS 106. Almeno un morto al mese tra il 2014 e il 2018. E ben 200 vittime in sette anni. Con la morte del brigadiere Romeo e della moglie, è salito a 15 il numero delle vittime nel 2021. Quindi, siamo già oltre l’inquietante media. Si è rivelato un dato fuorviante il calo degli incidenti (circa del 20%) nel 2020. Con le vittime scese a 11, mai così poche dal 1996. Ma era tutto dovuto, evidentemente, alle restrizioni emesse per contenere la pandemia da Coronavirus. E, quindi, alla ridotta mobilità. Con il ritorno alla “normalità”, la SS 106 ha ricominciato a uccidere come e più rispetto agli altri anni.