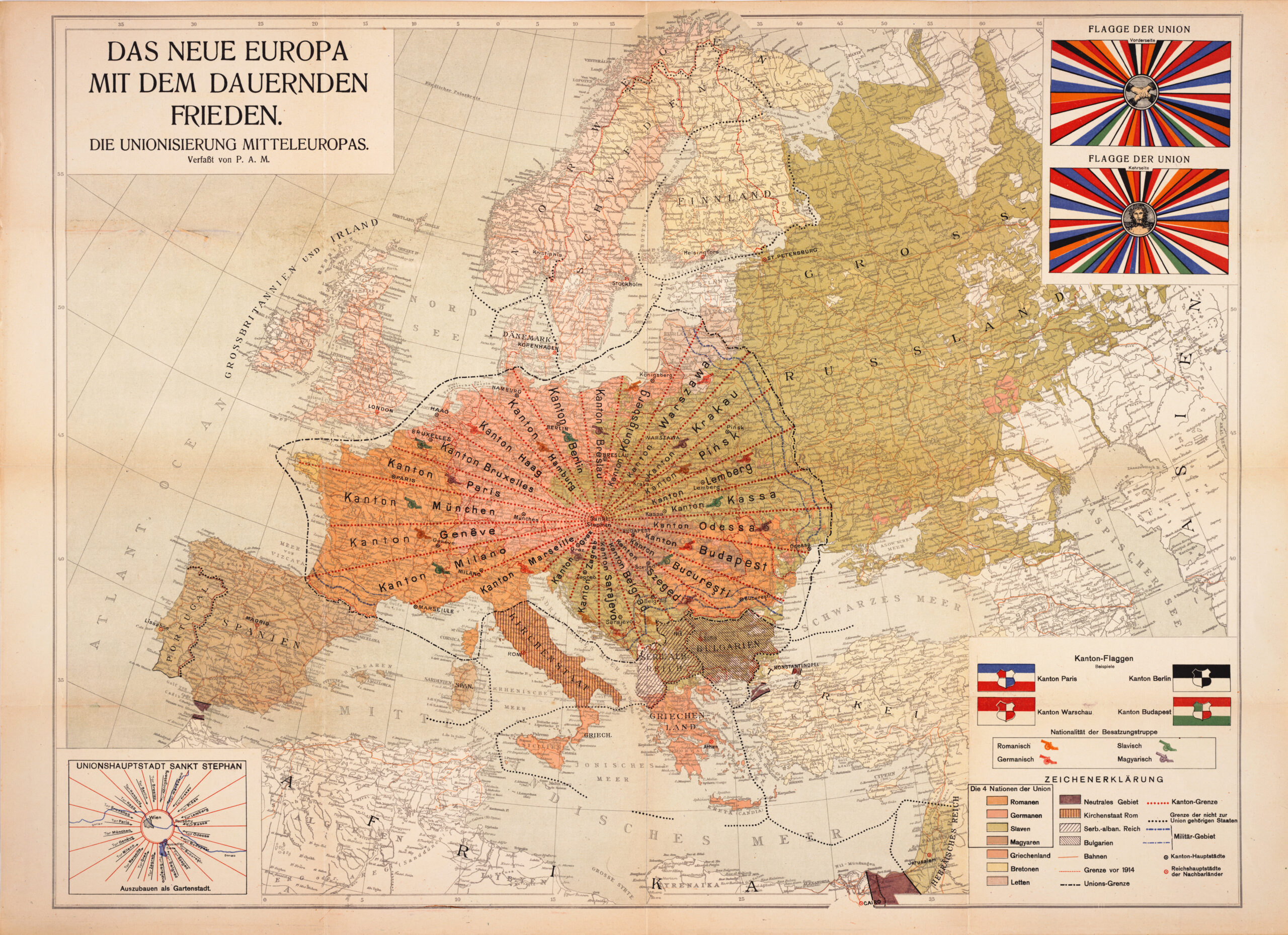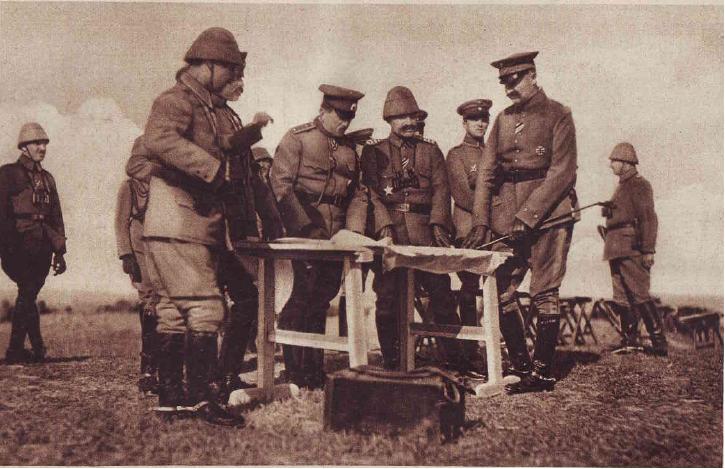Il 18 dicembre si è conclusa la 45° edizione dei Premi Ubu. Come ogni anno, in diretta streaming in staffetta con quella di Radio Tre, è arrivato l’annuncio con i nomi dei vincitori per la stagione 2022/2023 del Premio che Franco Quadri ideò nel 1977. Nell’elenco, anche l’attore, drammaturgo e regista calabrese Saverio La Ruina.
Ancora una volta La Ruina porta a casa il più prestigioso e importante riconoscimento del teatro in Italia. Lo aveva già fatto nel 2007 con Dissonorata (Miglior attore italiano e Miglior testo italiano), nel 2009 (Premio speciale per Primavera dei Teatri), nel 2010 con La Borto (Miglior testo italiano), nel 2012 con Italianesi (Miglior Attore italiano). In quest’ultima edizione vince con Via del Popolo come Miglior testo italiano o scrittura drammaturgica messa in scena da compagnie e artisti italiani.
La Ruina, l’Ubu e “l’Oscar dei poveri”…
Saverio La Ruina è un vincitore seriale di premi Ubu, un irriducibile artigiano del teatro che non si lascia inglobare, assorbire e omologare nella cultura liquida della contemporaneità. Rimane fedele al teatro, arte lontana dalle logiche dell’evento che la società dei consumi impone trasformando la cultura in una merce destinata esclusivamente all’industria del divertimento.
Con Via del Popolo, un testo drammaturgico di straordinaria semplicità, dimostra che la cultura è qualcosa di profondamente radicato nella memoria individuale come valore della storia collettiva, capace di definire percorsi di crescita, o di decrescita, spingendoci ad inevitabili riflessioni di natura sociale, culturale e anche politica.

Ma partiamo con ordine: quando parliamo di Premio Ubu c’è sempre la necessità, quasi a giustificarlo nel tentativo di attribuirgli autorevolezza e prestigio, di spiegarne il valore. E l’unico modo per farlo è l’inevitabile comparazione con gli Oscar o i David di Donatello. Già solo questo basta a raccontare il valore che nella nostra cultura assume il teatro, qualcosa che resiste ed esiste solo per una fetta di pubblico che spesso finisce per identificarsi con gli stessi addetti del settore. Un’isola sperduta, raggiungibile per strade poco percorribili e scomode. Allora il teatro diventa anche un fatto politico perché ci dice che le istituzioni, in barba ai dettami costituzionali, poco si occupano di valorizzare, diffondere e sostenere un’arte antichissima e strettamente connessa con le manifestazioni dello stesso spirito umano.
Nemo propheta in patria
Via del Popolo è un racconto autobiografico. Parla della realtà di una strada nel centro di Castrovillari, di quando era piena di negozi, di gente, ricca di relazioni umane in uno spirito del luogo ormai passato. Quanto tempo occorre per percorrere duecento metri di strada? La risposta è negli anni di chi la percorre, perché il tempo non ha lo stesso valore per tutti: c’è chi lo vive assaporandolo e chi lo consuma fagocitandolo, perché le catene della grande distribuzione hanno cancellato i rapporti tra le persone.

Via del Popolo parla la lingua del posto, uno tra i tanti dialetti calabresi che come tutti gli altri difficilmente è riuscito a varcare i confini regionali per diventare lingua di scena, relegato al ruolo di vernacolo per un teatro amatoriale, quasi una lingua da nascondere o da sbeffeggiare.
La Ruina, che riesce a rendere comprensibile e universale anche quei modi di dire decifrabili solo per chi vive lo spirito dei luoghi, porta il suo dialetto e i tipi fissi della nostra realtà del Sud nei più importanti teatri della penisola. Non importa che sia a Messina, a Roma, a Trento o a Milano perché La Ruina trova consenso, applausi e successo ovunque, ma non in Calabria. Qui non c’è spazio.
Meglio Muccino per la Calabria?
A questo punto dovremmo chiederci perché l’immagine della nostra regione passa attraverso la promozione di quelle piste di ghiaccio davanti la stazione di Milano, negli spot con gli asini, le tovaglie a scacchi, i verbi coniugati male, i capodanni da milioni di euro. Tutto intriso da terribili luoghi comuni, come se i calabresi fossero solo mare, sole, nduja e soppressata. Invece non si valorizza mai il patrimonio culturale contemporaneo, costruito faticosamente da uomini e da donne lasciati soli da una politica troppo impegnata nella lotta quotidiana per i consensi elettorali.
La Calabria trascura il passato e del presente culturale preferisce non occuparsi. Non si investe in progettazione culturale, in distribuzione. Se non fosse per le iniziative dei privati, a livello istituzionale, non potremmo che assistere a traslochi di spettacoli televisivi di dubbio gusto negli spazi pubblici delle nostre città.
Abbiamo comunque una speranza perché esiste un movimento che potremmo definire di resistenza. Si tratta di tante piccole compagnie teatrali di elevato spessore professionale che ogni giorno combattono per preservare la cultura del teatro in un luogo politicamente ostile.
L’Ubu a La Ruina e il teatro in Calabria
Di questo si occupa anche Scena Verticale, la compagnia teatrale fondata nel 1992 da Saverio La Ruina e Dario De Luca, ai quali si unirà successivamente anche Settimio Pisano. Grazie a Primavera dei Teatri, il festival sui nuovi linguaggi della scena teatrale, riescono a trasformare ogni anno Castrovillari nel più importante avamposto del teatro in Calabria e in un punto di riferimento internazionale della scena contemporanea.
Riescono in un’impresa grandiosa, una realtà che non riesce a costruire neanche il mondo accademico nonostante un corso di laurea in Discipline della Musica e dello Spettacolo, troppo chiuso in se stesso, autoreferenziale e incapace di creare sinergie con le compagnie teatrali del territorio calabrese.

Il Premio Ubu a Saverio La Ruina è un premio che torna in una Calabria che ignora questo settore culturale. E allora è come se il brutto, panciuto e grottesco Ubu percorresse, in lungo e largo, le strade vuote di una via del popolo che attraversa tutta una regione abitata da istituzioni che, alla cultura, preferiscono l’educazione all’allineamento di quel pensiero unico che esclude ogni forma di partecipazione culturale e sociale.