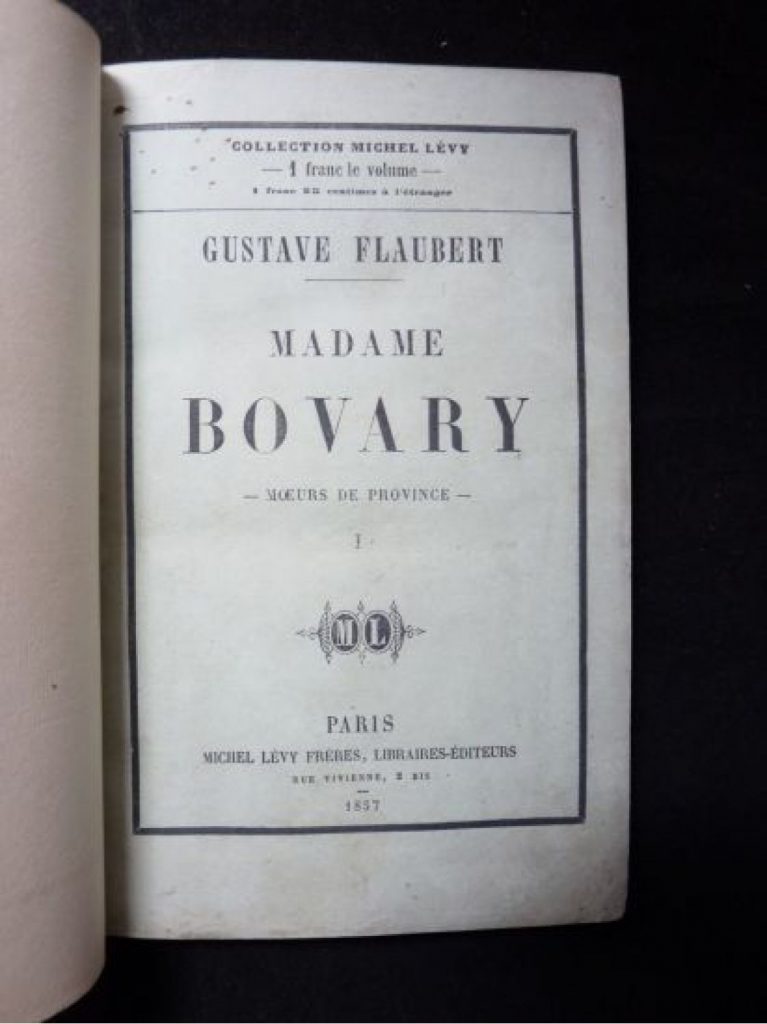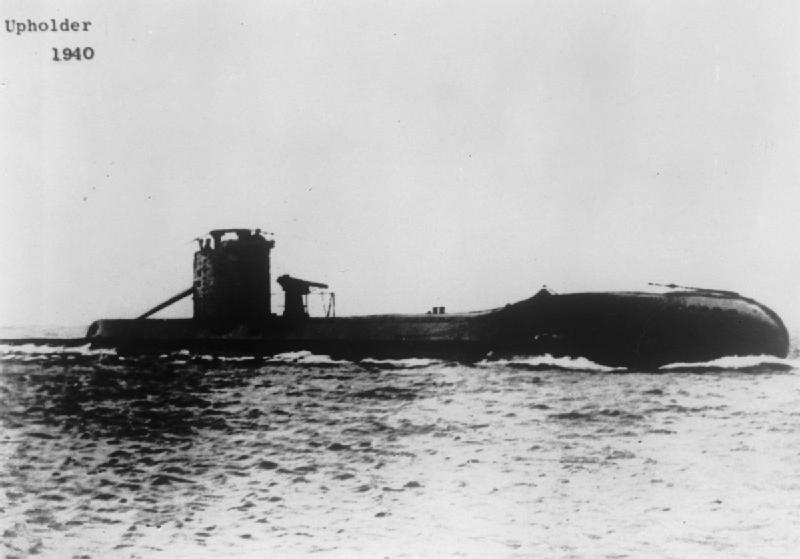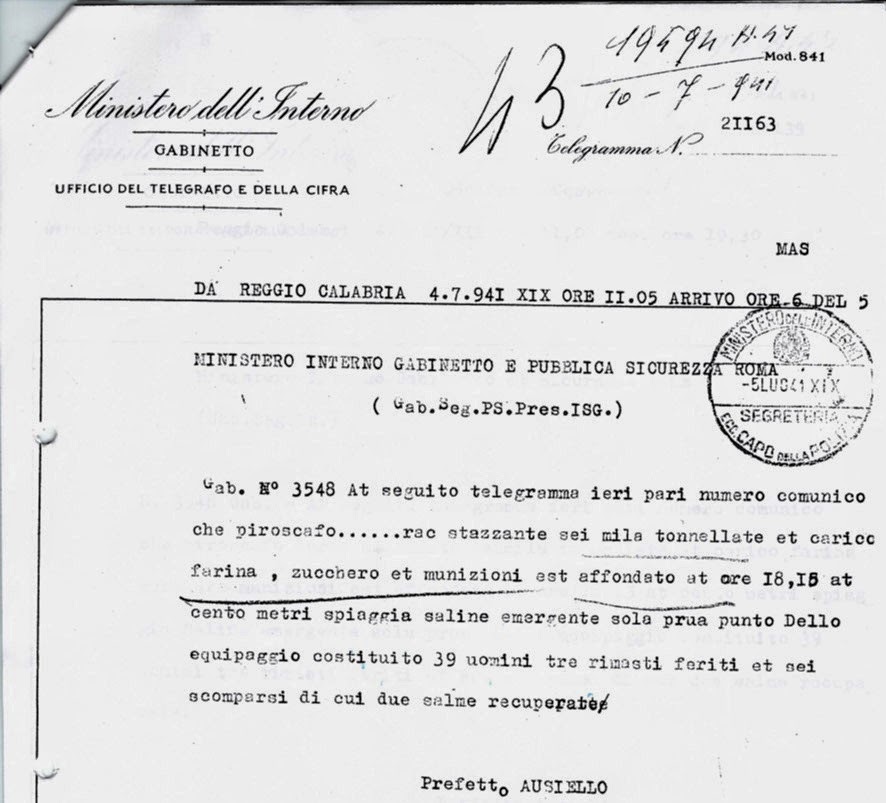C’è quel brano di Alvaro, divenuto col tempo un comodo luogo comune, che dice che la Calabria e i calabresi hanno bisogno di essere parlati: «il calabrese “vuole essere parlato”. Bisogna parlargli come a un uomo che ha sentimenti, doveri, bisogni, affetti: insomma, come a un uomo». Poi ce ne sarebbe un altro, in cui lo stesso Alvaro immagina che: «Di qui a cinquant’anni, se ai moti esteriori della civiltà risponderanno quelli interiori, la regione sarà una regione totalmente cambiata».
A elezioni regionali 2021 chiuse si può dire che a distanza di quasi un secolo da queste osservazioni che identificavano l’idealtypus dell’escluso calabrese da romanzo verista, rovesciando lo stereotipo alvariano, oggi i calabresi per parlare parlano (e non poco). Ma di sicuro non hanno ancora imparato a cambiare, o non vogliono proprio che nulla cambi nella loro regione.
Nulla è cambiato
All’indomani del fatidico voto, presentato da più parti come una sorta di ultima spiaggia, un redde rationem per la politica della Calabria e dei calabresi per i prossimi cinque anni, rispetto a prima del voto, infatti nulla, ma proprio nulla, è cambiato. La Calabria ha scelto il proprio futuro. E ha scelto Occhiuto, con gli stessi consensi che andarono alla Santelli. Forza Italia, caso unico in Italia guida di nuovo la Calabria come trent’anni fa. La Bruni e il centro-sinistra a guida Pd è di nuovo l’alternativa principale, come da quando è nata la Regione.
L’astensionismo cresce
Il numero percentuale dei votanti in una Calabria che perde costantemente elettori interessati al voto con lo stesso ritmo con cui la gente emigra e abbandona paesi e città, è sceso persino più in basso di quello di gennaio 2020. Siamo al 43%. Molti dei calabresi residenti altrove e all’estero, ma anche in Calabria, sono rimasti a casa. Il non voto continua a crescere.
Azzoppato Lucano dopo l’abnorme sentenza di condanna, bandiera delle opposizioni antisistema, neanche la consolazione di vederlo eletto. Lo straniero Luigi de Magistris, capo della coalizione civica, avversato dal centrosinistra ufficiale, pur respinto dal voto popolare, fa con le sue liste un 16% di voti. Che equivale a circa 127mila calabresi che hanno immaginato e creduto in uno strappo risolutivo alla continuità del sistema. Pochi, troppo pochi. Ma non una frazione insignificante.
Segnali di resistenza
A Cosenza, città che votava anche per il Comune, De Magistris ha superato il 30%, battendo la Bruni e limitando il distacco da Occhiuto a circa il 13%. Risultato, due consiglieri regionali eletti in Consiglio, e con l’introduzione della preferenza di genere, nello schieramento DeMa Anna Falcone tra le donne ottiene diversi consensi. A Rende, il comune dell’Università della Calabria, de Magistris sta al 33% dei voti. Segno che le aree urbane, con quel poco di opinione pubblica che la Calabria libera riesce ancora a mettere in campo, rappresentano forse le ultime sacche di resistenza alla politica del malgoverno e del malaffare, un argine residuo allo strapotere della corruzione e delle mafie. Non sono, credo, segnali da sottovalutare.
La rivoluzione eternamente rimandata
Ma il cambio di rotta, la discontinuità, la rinascita civica, i diritti di cittadinanza, la rottura del sistema, la “rivoluzione”? Sarà per la prossima volta. Per i calabresi il cambiamento vero non è cosa necessaria. Anzi, è un trauma, un salto nel vuoto da scongiurare. Accade nonostante il buco nero della sanità, l’occupazione azzerata, l’emorragia continua dei giovani, i paesi che si spopolano, lo strapotere dei gruppi criminali e l’inanità di una classe dirigente da terzo mondo e incapace di farne una buona. Tranquilli tutti. Per i calabresi va benissimo continuare così.
Il sistema è salvo
Il malcostume politico, l’impianto inveterato delle clientele, l’assistenzialismo, la dipendenza parassitaria, il consociativismo e lo scambio orizzontale “cazzi mei/cazzi tuoi”: il sistema è salvo ed è anzi più saldo che mai. Altro che opinione pubblica libera e fluida, altro che cittadini attivi e consapevoli come vorrebbe la moderna politica post-ideologica.
Le vecchie clientele in Calabria sono ancora oggi il nucleo pesante del sistema di potere. Sono fortezze inespugnabili, formano una sorta di enclave etnica, in cui i bisogni fondamentali e la vita quotidiana dei gruppi sociali sono scanditi con metodo orwelliano, ottenendo per chi ci sa fare consensi duraturi e serene carriere da politico di lungo corso.
Chiedere favori invece che reclamare diritti, inginocchiarsi per ottenere privilegi e grazie, è ancora oggi una cosa normale in una terra in cui la libertà è ritenuta un lusso per pochi. E la gente continua a sottomettersi a scelte, comportamenti e simboli che dilatano lo spazio del silenzio complice dell’obbedienza, con le prassi e i riti di un potere vetusto e prepolitico.
Lontani anni luce
Un recente sondaggio pre-elettorale aveva dimostrato che su un significativo campione di elettori, solo pochi cittadini calabresi avevano manifestato liberamente le loro intenzioni di voto. Insomma neanche davanti ai test impersonali di internet e dei social i calabresi si sbottonano, non si dichiarano, temono. Restiamo lontani anni luce dalla fluidità ideologica del mondo post-industriale e delle libertà del post moderno. Eterogenei al laicismo e alla mobilità che contraddistinguono altri campioni di popolazione italiana nei confronti delle risorse civili della politica e della partecipazione democratica.
Ma nonostante l’abbarbicamento al passato, anche in questo perdurante panorama di conservazione, alcuni profili cambiano. Non solo nell’elettorato. Anche la politica politicante si mostra capace di stare al passo con le tendenze, e a modo suo in sintonia coi tempi. Si profila anche in Calabria una figura ibrida di politico (aspirante o in carriera, il modello è il medesimo): una sorta di populista iper-presenzialista, ruzzante e rampante. Personaggi che si pongono tra l’olocrate arruffapopolo e l’influencer della porta accanto. Sempre presenti sui social e nelle piazze virtuali, come “uno di noi”.
Lamentele e azioni
È l’olocrazia della governance alla plebea, la fenomenologia del politico pop che si fa vedere allo stadio con la sciarpa della squadra di casa, che addenta un panino nella calca di una sagra di paese, quello che incontri per strada e a cui si dà populisticamente del tu. È l’olocrazia dei Cicc’ dei Nanà, dei Pinuzz’, dei Maruzz’, dei Carlett’, dei Totonn’. Mestieranti, ingegni modesti, macchiette da strapaese. Che però una volta sbalzati oltre il proscenio social mettono le mani sul potere vero, quello della politica che decide, e che poi pesa per anni sul groppone di una Calabria che soffre e si lamenta. Si lamenta sì, ma non agisce.
Un casting sui generis
In Calabria il casting senza fine che approvvigiona il ceto della politica dice che oltre ai soliti inossidabili mestieranti che hanno fatto il giro delle sette chiese (e sono sempre lì incollati alle poltrone e agli ambiti scranni con annesse prebende garantite da un posto nel parlamentino regionale), a fare la fortuna di un carneade debuttante non può bastare un profilo da influencer politico di mediocrissimo calibro strapaesano. L’empireo degli ottimati tra i politici regionali non può essere raggiunto senza certe requisiti di qualità che fanno potere e consenso. Come aver amministrato un comune, diretto un’ASP, o avere alle spalle una professione di quelle che la politica trasforma in fonti di clientele e di varie utilità.
La politica come risorsa
Vale però tanto per debuttanti che per i politici di lungo corso, prima che per i loro elettori, un principio di ferro: che la politica è e resta per loro una risorsa. Un ascensore sociale. Per arricchimenti, carriere, vite comode. Un’occasione quindi da non perdere. Perciò si battano i territori con i vecchi strumenti del galoppinaggio di buona tradizione calabra: il clientelismo, le promesse di lavoro, i voti contati casa per casa, con la spesa fatta nel supermarket di riferimento. Perché in Calabria c’è chi, tra gli elettori, il voto lo esce solo all’ultimo momento. C’è chi lo mette all’asta, chi lo promette a tutti. Mentre, invece, molti altri elettori neanche ci vanno più a votare. Come dimostra la massa crescente di indecisi e di restii del voto. Sono coloro che vivono in una condizione assicurata, che nulla o quasi hanno da chiedere alla politica.
Crisi d’identità
Il voto fotografa quindi in Calabria un panorama di fenomeni assai complessi. Conseguenze della regnante confusione sociale (c’entra qualcosa anche l’impoverimento e l’ulteriore fragilità inflitta dal Covid), con la crescente opacità che avvolge la realtà di questa regione-laboratorio. Da un lato la democrazia rappresentativa, sempre più esposta a forze demagogiche che si consolidano e riorganizzano, sfruttando anche la potenza digitale dei nuovi mezzi di comunicazione. Dall’altro, le emergenze e il caos di una regione in profonda crisi di identità collettiva, dove vecchi gruppi di potere e nuova poliarchia politica cozzano senza sintesi, ma volentieri si associano e stressano i limiti da valicare per giungere a conquiste democratiche moderne, a soluzioni laiche, rapide e incisive.
Dicevamo anche degli indifferenti: quel 57% che resta a casa, che da anni si disinteressa e non vota. È la maggioranza silente. Il nocciolo di un’opinione pubblica potenzialmente libera, più consapevole, mobile e laica. Che invece finora accondiscende e legittima i piani di coloro che, a turno, comandano. Questi ceti, dalla fisonomia sociale e dai confini ancora incerti e indecifrati, che fanno a meno della risorsa politica, sono forse gli unici in Calabria in grado di cambiare il gioco, di aprire ad un altro futuro. Ma per ora restano fuori e privi di rappresentanza.
Aspettando il cambiamento
Stando così le cose, la Calabria cambierà mai? C’è ancora qualche speranza? Esiste la possibilità reale che accada? Per chi proponeva il cambiamento, dopo l’ennesima delusione, dopo la cocente sconfitta, è d’obbligo chiedersi come andare avanti, che fare in questa regione. Di strade ne restano solo due. Andare via: molti continueranno a farlo. L’altra è continuare a resistere e a combattere, con ostinazione, civilmente e per il bene di tutti. E in parecchi continueranno a farlo ancora.
Sarà però impossibile se non spazziamo via, una volta per tutte, la retorica e la prassi vittimistica della resa al peggio, della lamentazione rituale, della subalternità autoinflitta dal nostro cattivo agire, individuale e collettivo. Se ai nostri comportamenti e al nostro orizzonte sociale asfittico, in cui il privato vale sempre più del pubblico, non ridiamo lungimiranza e dignità di cittadini. Per davvero, o così o non avremo speranze.
Sessant’anni dopo
La Calabria è il cuore malato della Questione Meridionale. È una condizione cronica, che va affrontata con coraggio, assumendosi nuove responsabilità culturali, civili, umane, respingendo le solite scorciatoie dell’assoluzione collettiva per giustificare tutti i nostri mali. Si smetta di fuggire. Si resti davvero, per il bene di tutti. E «senza dramma, senza rancore», con tutte le sue forze migliori, finalmente la Calabria trovi il coraggio di reagire «ad una condizione inferiore o servile» che dura da troppo tempo. Cerchi di meritare finalmente «una condizione in cui l’uomo sia padrone di sé e del suo destino». Anche questo lo diceva Alvaro. Più di sessanta anni fa.