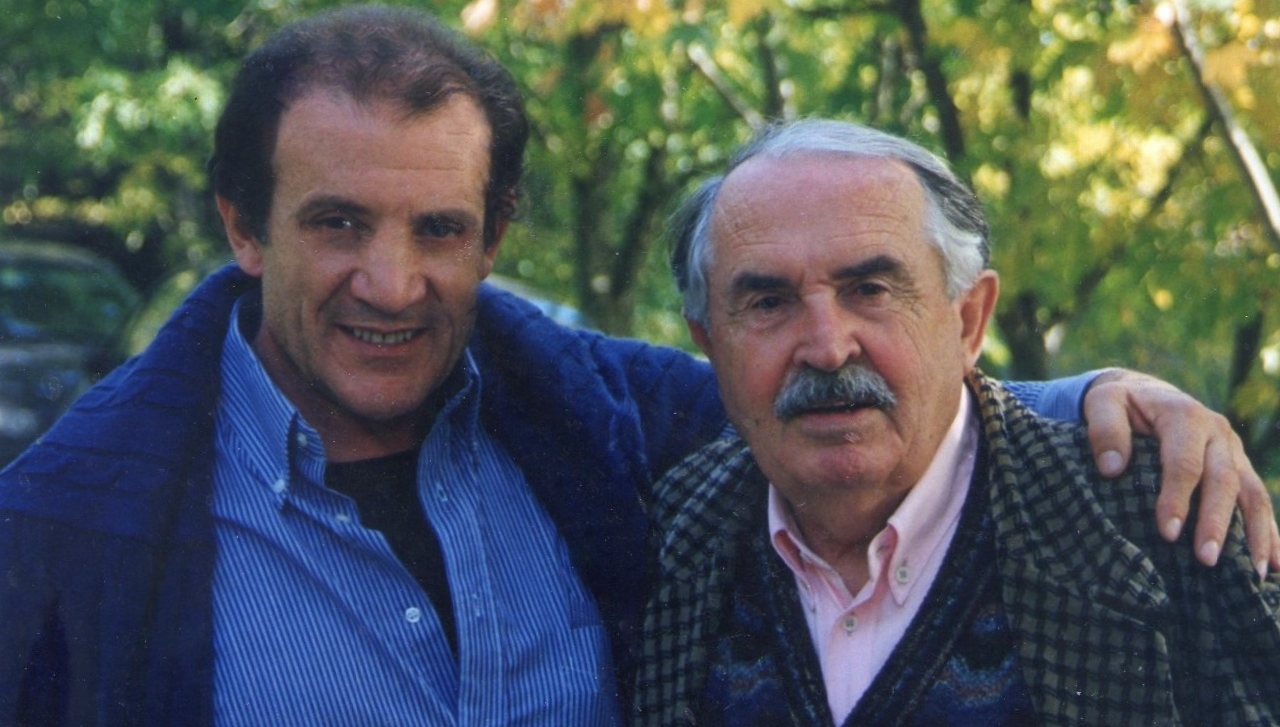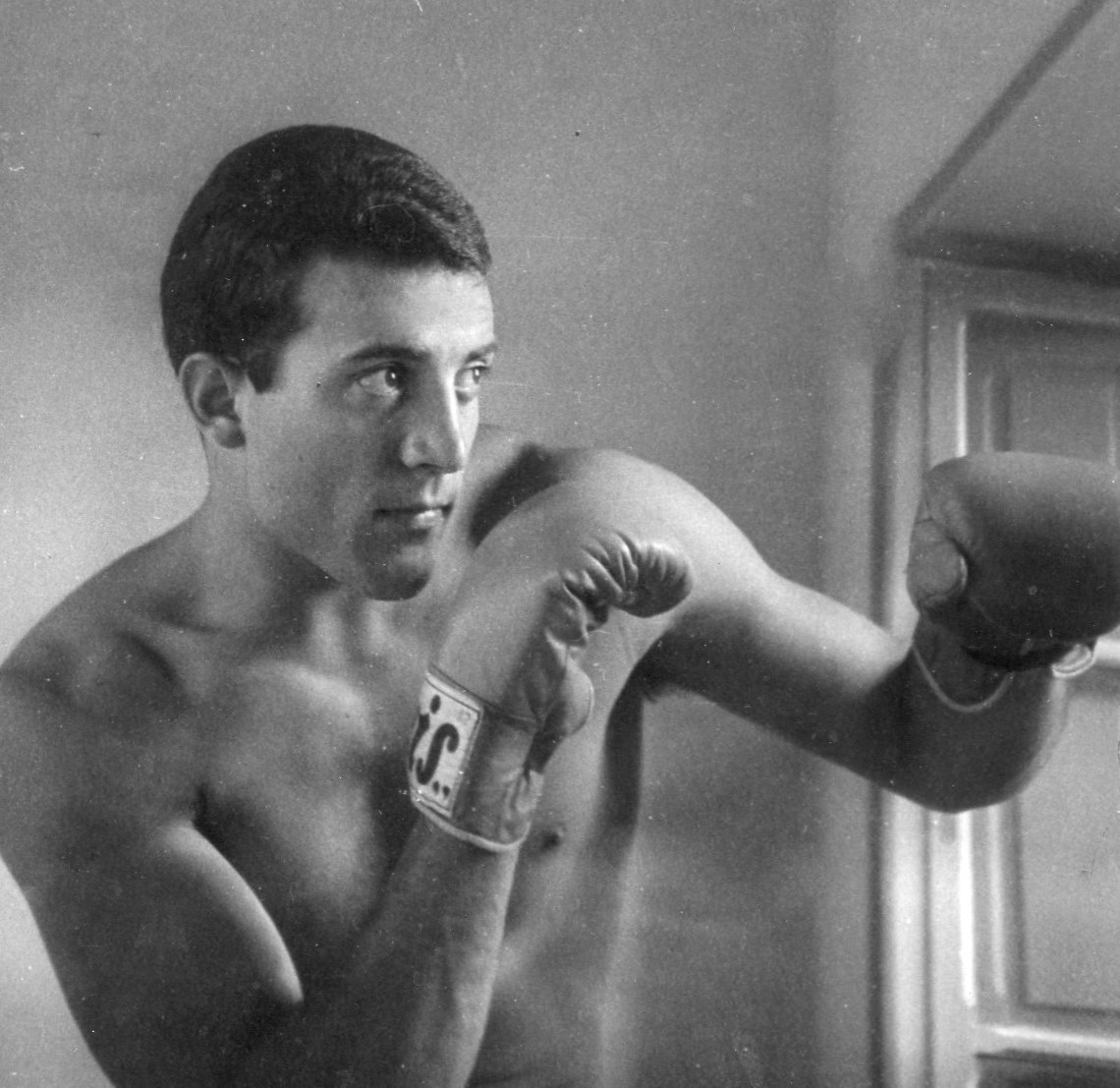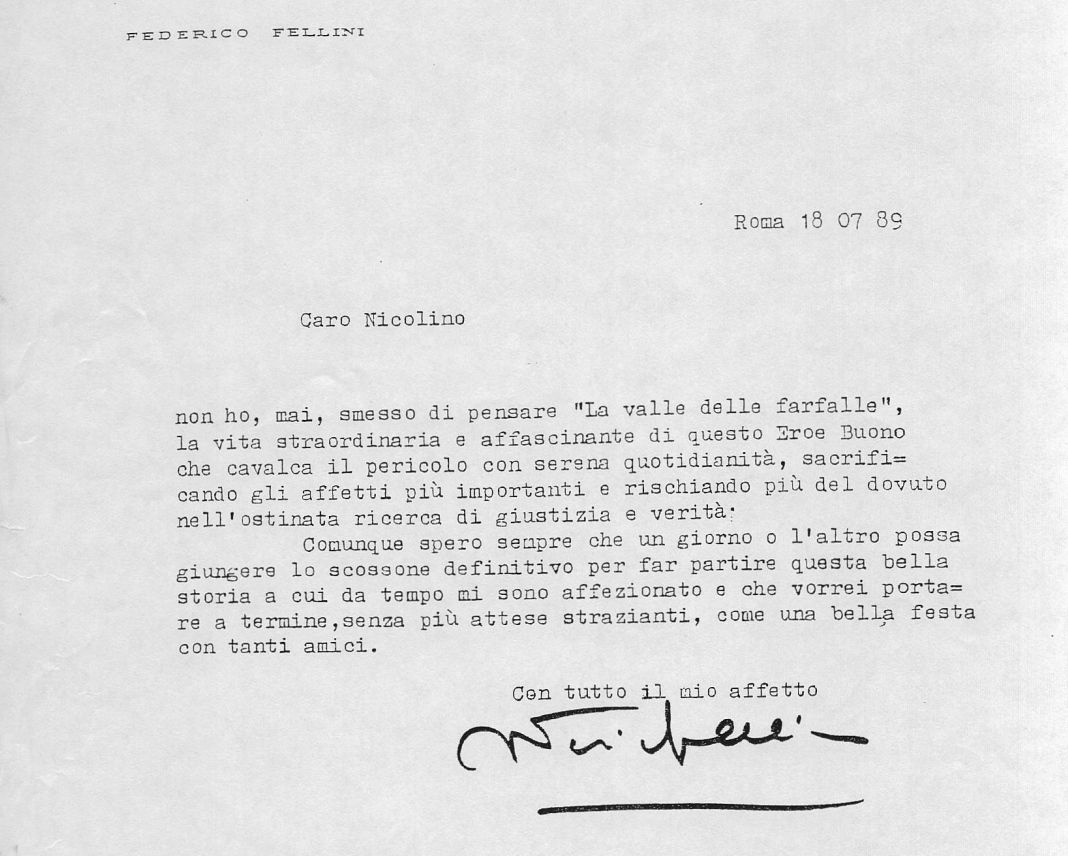[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Misteri, ma anche sospetti: sono parole che, se si parla di massoneria, quasi sempre finiscono nella stessa frase. Ma è davvero così? Lui si schermisce. Non si considera affatto un “tuttologo” della massoneria. Ma la sua è un’opera monumentale: I Liberi Muratori – Storia Mondiale della Massoneria, edito da Laterza. John Dickie, professore all’University College di Londra, è un esperto di fama internazionale su molti temi della storia italiana. Si è dedicato molto alle dinamiche di natura mafiosa e ‘ndranghetista. Lo ha fatto con testi di rango scientifico. Ma anche con lavori televisivi, come alcuni documentari di successo trasmessi da History Channel.
Con il suo lavoro, John Dickie mette al centro del ragionamento l’entità che più di tutte al mondo ha attirato le più arzigogolate teorie: la massoneria e i massoni. Membri di una confraternita dedita alla filantropia e all’etica o una società segreta complice dei peggiori misfatti? Dalle Rivoluzioni alle stragi e le trame oscure della storia repubblicana: cosa c’è di vero sui massoni e cosa, invece, appartiene al mito complottista? Il docente inglese ne parla in un’intervista esclusiva a I Calabresi.
Nel suo libro “I liberi muratori – Storia mondiale della Massoneria” ripercorre le varie epoche vissute dalla Fratellanza. Qual è la genesi della Massoneria? Quali i valori che la ispiravano nel momento della sua nascita?
«I massoni amano rifarsi alle arti dei mestieri del medioevo inglese, e in particolare all’arte dei lavoratori in pietra. Secondo i massoni, sarebbero state queste radici della Libera muratoria come organizzazione a plasmare allo stesso tempo i loro valori fondamentali (cioè fratellanza, umiltà, solidarietà e beneficienza, pretesa di stare al di fuori della lotta politica, tolleranza religiosa, politica, sociale e etnica…) e la simbologia che sta al centro della vita delle Logge. Tant’è vero che i simboli massonici più importanti (grembiulino, squadra, compasso, ecc.) sono arnesi i quali, per la massoneria, sono ormai diventati metafore di qualità morali.
Secondo il codice massonico, lo scopo della loro fratellanza è quello di “costruire” uomini migliori così come i lavoratori in pietra di una volta costruivano castelli e chiese. La realtà storica è, inevitabilmente, diversa rispetto a questa mitologia delle origini. L’arte dei lavoratori in pietra era, per una serie di motivi pratici, molto debole e incapace di imporsi come invece facevano l’arte dei sellai o quella degli orefici, per esempio.
Però in due momenti storici particolarmente importanti l’élite dei lavoratori in pietra (un gruppo di professionisti che oggi chiameremmo architetti) costruisce un legame col potere politico che lentamente trasforma l’arte dei lavoratori in pietra in qualcos’altro: in un’associazione con pretese filosofiche e morali e un luogo dove uomini di diversa provenienza sociale possono riunirsi e discutere in un’atmosfera relativamente libera e egualitaria».
Quali sono i due momenti di cui parla?
«Il primo momento accade negli ultimissimi anni del ’500 in Scozia alla corte del re Giacomo VI. Il secondo momento accade a Londra all’inizio del ’700, quando la massoneria si stacca definitivamente da qualsiasi legame con l’edilizia e trova invece un posto all’interno delle reti d’influenza del partito Whig. Ricordo che, per gli standard di quel periodo, i Whigs e la società urbana inglese in genere manifestano forme di tolleranza religiosa e politica, e di libertà d’espressione, molto all’avanguardia rispetto al resto del continente. Vari studiosi hanno sostenuto che la massoneria aveva un ruolo importante come “palestra” della vita politica e istituzionale delle società moderne».
In Inghilterra, suo Paese, com’è vista l’appartenenza massonica? Quali sono gli snodi più importanti della storia mondiale in cui la Massoneria ha avuto un ruolo centrale?
«Da Londra, a partire degli anni ’20 del ’700, la Massoneria si diffonde molto velocemente nel resto del mondo, grazie al commercio e all’Impero. Infatti, è con il suo contributo all’imperialismo che la Massoneria forse ha la sua più grande influenza nella costruzione del mondo contemporaneo. Per i soldati, i mercanti, gli amministratori dell’Impero britannico che si muovono tra Calcutta e Città del Capo, tra il Canada e l’Australia, la massoneria offre una specie di welfare internazionale, una banca di contatti, e una vita sociale già bell’e pronta all’arrivo in qualsiasi angolo lontano dei territori britannici.
E tutto aiuta naturalmente a legittimare ideologicamente la conquista e lo sfruttamento di altri popoli. Detto in parole povere, il codice massonico della tolleranza si presta a diffondere l’idea che gli inglesi costruiscono l’impero non per motivi di avidità, ma per portare la luce della civiltà ai “luoghi oscuri del mondo” (per usare la frase del vate dell’imperialismo di fine Ottocento, Rudyard Kipling, un massone)».

Nota differenze particolari con l’Italia?
Per quanto riguarda l’immagine della massoneria in tempi più recenti, un po’ come in Italia con la storia della Loggia P2, in Gran Bretagna gli anni ’80 del ventesimo secolo vedono degli scandali che danneggiano moltissimo l’immagine della Massoneria. Nel nostro caso sono casi di corruzione nella polizia dove vengono chiamati in causa i massoni. Nella mente di persone della mia generazione, la massoneria è rimasta quella invischiata negli scandali di 40 anni fa: una lobby piuttosto squallida, dunque.
La differenza rispetto all’Italia, dove lo scandalo della P2 dava veramente motivi di preoccupazione, è che questa immagine di una massoneria centro di influenze clientelistiche è, nel caso inglese, uno stereotipo, una memoria collettiva fallace. Molto anni dopo gli scandali, alle fine degli anni ’90, l’inchiesta parlamentare incaricata di analizzare in profondità i legami tra massoneria e corruzione pubblica un rapporto che essenzialmente scagiona le logge e completamente ridimensiona il quadro che avevamo della loro influenza. Emblematico il caso del poliziotto massone che aveva giocato un ruolo eroico nello scoperchiare la corruzione della polizia della City di Londra. E si trattava di forme di corruzione molto serie: legami con violentissimi rapinatori in banca, per esempio.

In Gran Bretagna la massoneria ha preso atto dei problemi di immagine che sono l’eredità degli anni ’80. C’è stata una specie di Glasnost massonica, per esempio, con l’apertura degli archivi a storici non massoni come me. Ma cambiare le percezioni del pubblico è un lavoro lungo e difficile, soprattutto quando la Massoneria è in declino».
Molto spesso, anche in questi due anni di pandemia, quando il cittadino medio non sa spiegarsi qualcosa, tira in ballo la Massoneria e presunti piani di controllo internazionali. Si tratta di teorie complottistiche destituite di fondamento?
«Assolutamente sì. So per esperienza che è quasi inutile cercare di convincere un complottista a cambiare idea, ma proviamoci ragionando in base alla natura stessa della massoneria. Innanzitutto, la Massoneria in quanto tale non esiste a livello nazionale in molti casi, figuriamoci a livello internazionale. Sin dal ’700 la storia della massoneria è caratterizzata da scissioni e da una diversificazione di tradizioni e obbedienze. Non c’è nessun franchising mondiale. I massoni hanno perso il controllo del proprio “marchio” secoli fa. Oggi come oggi è facile per un gruppo qualsiasi di chiamarsi massoni e mettere su una loggia, scopiazzando i riti e i simboli da Internet. Il risultato è un mondo quasi ingovernabile.
Persino nelle tradizioni più autorevoli, come il Grande Oriente d’Italia o la United Grand Lodge of England, le singole logge hanno molta autonomia. E i singoli massoni vivono la propria appartenenza alla fratellanza in modi molto molto diversi. Chi copre una carica alta all’interno della Massoneria tende a non essere una persona con molta influenza nel mondo esterno, per il semplice motivo che immergersi in questa vita porta via un sacco di tempo in riti, amministrazione, diplomazia interna, ecc. Chi invoca “la massoneria” senza distinguo, non fa che dimostrare la propria ignoranza. Altro che complotto internazionale.

Però il legame tra massoneria e miti complottistici non è casuale. Infatti, possiamo rintracciare le origini del complottismo contemporaneo agli anni immediatamente dopo la Rivoluzione francese. Per l’Europa conservatrice, e soprattutto per la Chiesa cattolica, la Rivoluzione francese rappresenta un trauma collettivo di dimensioni inaudite. Come spiegare una catastrofe del genere? A chi dare la colpa? Come orientarsi quando sono saltati tutti gli schemi dell’antico regime? Nel 1797 un prete francese in esilio a Londra, l’abbé Augustin de Barruel, scrive un libro che fornisce la risposta che tutti cercano: la Rivoluzione francese è il risultato di un complotto dei Massoni, ispirati dal demonio. Questo mito del complotto diventerà presto l’ideologia della Chiesa cattolica per gran parte dell’Ottocento, e poi la matrice di tutti i complottismi dei nostri tempi».
C’è stata, negli anni e nelle epoche, una degenerazione?
«No. La massoneria è un fenomeno globale, vecchio 300 anni, che si manifesta in forme diverse a seconda del contesto e del momento storico. La massoneria si è prestata alle attività di statisti e rivoluzionari, imperialisti e lottatori per la liberazione, razzisti e umanitari, poliziotti e delinquenti, fanatici religiosi e razionalisti… Questa diversità rende estremamente interessante la storia della massoneria. Non mi sono mai divertito così tanto a scrivere un libro! E questa straordinaria diversità del fenomeno non si può riassumere in un’unica parabola di degenerazione.
Il fattore dell’affarismo— ed è a questo che si vuole far riferimento quando si parla di una degenerazione attraverso il tempo — c’è stato sin dall’inizio. L’età d’oro della massoneria, l’età della purezza dei valori massonici, non è mai esistita. Ma dall’altra parte, anche in tempi più recenti, l’affarismo rappresenta soltanto una dimensione della lunga storia della Libera muratoria. E nemmeno, a mio avviso, la dimensione più interessante».
In generale, c’è secondo lei un ambiente o un settore, tra quello politico, militare, economico in cui, nell’attualità che viviamo, l’appartenenza massonica, ha un ruolo preminente?
«Dipende da dove ci troviamo nel mondo. In molti paesi oggi la maggioranza dei Massoni è composta di pensionati. La massoneria ha sempre avuto un legame molto forte con la vita militare: gli ex militari nella Massoneria sono tanti. Penso che sia perché la massoneria sostituisce alcuni aspetti della vita collettiva nelle caserme e offre una rete di sostegno per chi cerca di fare il difficile viaggio di ritorno al mondo dei civili.
Al prezzo di generalizzare moltissimo, si potrebbe dire che la massoneria è un fenomeno delle classi medie. Però sarebbe un lavoro molto complicato fare una sociologia dell’appartenenza massonica anche in una sola realtà come quella italiana. In Italia ho visto molti professionisti. Ma le due obbedienze maggiori sono diverse: nella Gran Loggia d’Italia ci sono le donne, per esempio, e nel Grande Oriente no. E poi, ripeto, ogni loggia avrà le proprie caratteristiche».
In questo momento, tutto il mondo parla della Russia. La massoneria ebbe un ruolo nella Rivoluzione russa, come alcune fonti sostengono?
«No. Espresso in questi termini, si tratta dell’ennesimo mito del complotto. Lo Zar Alessandro I aveva messo a bando la Massoneria nel 1822, e dopo la Rivoluzione russa anche lo Stato sovietico la vieta. Poco spazio di manovra, dunque, per chi cerca una spiegazione della Rivoluzione russa chiamando in scena le eterne manovre dei fratelli in grembiulino. Non sono per niente un esperto di storia russa, ma nessuna delle analisi scientifiche che ho letto attribuisce importanza al fattore massonico nella Rivoluzione russa.
Lo stesso vale anche per la Rivoluzione francese, l’Unità d’Italia, la Rivoluzione americana, il palleggio di responsabilità dopo l’affondamento del Titanic, ecc. ecc. In casi simili, la tesi secondo la quale l’influenza massonica è stata decisiva si sente soltanto da sedicenti esperti di massoneria che tendono a vedere la storia attraverso il buco della serratura delle proprie ossessioni».
Veniamo all’attualità, ma sempre pensando alla storia. Nel suo libro parla anche dell’atteggiamento avuto, negli anni della Guerra Fredda dall’Unione Sovietica nei confronti della Massoneria. Cosa può dirci sul rapporto attuale tra la Russia e la Fratellanza?
«Il mio libro copre 400 anni di storia, e episodi affascinanti dalla storia di paesi quali la Gran Bretagna, l’Italia, gli Stati Uniti, l’India, il Sudafrica, la Francia, la Spagna, la Germania, l’Australia…. Ma non è un’enciclopedia mondiale della massoneria, e averlo scritto non mi autorizza a dichiararmi un tuttologo in materia di massoneria. Quello che so è che, dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della messa a bando sovietica, la massoneria è rinata ma ha avuto una vita molto difficile in tutto l’ex Impero URSS, tra sospetti dello Stato e pregiudizi popolari».
Lei conosce molto bene la Calabria. E nel suo ampio excursus letterario c’è una parte molto dettagliata che riguarda i rapporti tra la massoneria e la criminalità organizzata. Che idea si è fatto sui legami tra la ‘ndrangheta e la Fratellanza, che da più parti vengono indicati come il vero punto di forza delle cosche?
«Mi sono concentrato sul processo Gotha. Sono carte molto importanti che anche tu conosci molto bene. Da anni si parlava di un livello “massonico” del potere della ’ndrangheta. Giravano testimonianze preoccupanti, anche di pentiti e di massoni importanti, alcune dirette, ma molte per sentito dire, e spesso contraddittorie l’una con l’altra. Parlavano di una profonda penetrazione della ’ndrangheta all’interno delle logge del Grande Oriente. O di un controllo della ’ndrangheta da parte di elementi massonici. O di logge corrotte, logge deviate, logge coperte. Parlavano di una rete nazionale, o di una concentrazione del fenomeno nella Piana di Gioia Tauro, o sulla Ionica, e via di seguito. Una enorme confusione, insomma, su cui era doveroso fare luce, compito che il processo Gotha si è assunto.

E alla fine, almeno secondo le sentenze più recenti, la luce c’è. Ed è una luce abbastanza deludente per i complottisti della situazione. Quello che il processo ha scoperto è un nuovo organo di controllo politico-affaristico della ’ndrangheta, a cui gli ’ndranghetisti stessi fanno riferimento usando diversi nomi: per esempio, “gli Invisibili” o “la Massoneria”. Ma è importante capire che si tratta di una metafora: gli Invisibili non sono letteralmente massoni, la ’ndrangheta non è letteralmente sotto il controllo della massoneria.
Come ha dichiarato pubblicamente il dottor Giuseppe Lombardo, magistrato da anni coinvolto in questa materia, nel corso di un dibattito con me al festival Trame a Lamezia: “Il rapporto tra la ‘ndrangheta non è un rapporto tra la componente mafiosa e la componente massonica regolare o universalmente conosciuta. Nel momento in cui si parla di componenti massoniche in contatto con le organizzazioni mafiose si parla di componenti che vivono di logiche massoniche, ma non possiamo assolutamente in alcun modo pensare che le massonerie siano un sistema che entra a far parte delle organizzazioni di tipo mafioso. Questo è grave e fuorviante. Non serve al contrasto alle mafie”. Se un problema all’interno del mondo massonico c’è, sempre secondo Lombardo, è con alcune logge irregolari o fasulle, cioè non appartenenti alle tradizioni massoniche maggiori.

Quindi non c’è alcun legame specifico tra le due organizzazioni?
Io esprimerei il problema in un altro modo. Le logge massoniche sono pezzi di società come gli altri, e come tali hanno i loro specifici punti di forza e di debolezza quando si tratta di rapportarsi col potere della ’ndrangheta. Hanno risorse, umane e culturali soprattutto, che possono far gola alla ’ndrangheta, come ce l’hanno le altre associazioni culturali e religiose calabresi. In una situazione del genere, bisogna seguire le prove, i casi singoli, e non fare di tutta l’erba un fascio.
Gli intellettuali socialisti dell’inizio del ventesimo secolo usavano dire che “l’antisemitismo è il socialismo dei cretini”. Cioè prendersela con “l’Ebreo” in nome della lotta al capitale era pericoloso e fuorviante. Noi dobbiamo stare attenti a non fare un errore analogo. L’antimassonismo è l’antimafia dei cretini, e prendersela con “la massoneria” nel nome della lotta alla mafia o al malaffare, è pericoloso e fuorviante. Rischia di mettere la lotta alla mafia in mano al populista di turno, che non cerca altro che un capro espiatorio, ruolo svolto dalla massoneria già in molti altri contesti storici».
In generale, crede che l’aura oscura che avvolge la massoneria, forse soprattutto in Italia, sia frutto dell’esperienza della P2 e che, quindi, si guardi alla massoneria con eccessivo allarmismo?
Direi di sì. Ma ripeto, si fa presto a dire “massoneria” come se fosse un tutt’uno. Aggiungerei che trovo poco rassicurante l’atteggiamento della leadership del Grande Oriente. Il rifiuto di esaminare seriamente le proprie responsabilità nella vicenda P2. Il rifiuto di prendere sul serio il rischio di infiltrazioni mafiose o corruttive. La tendenza di lanciare accuse di pregiudizio antimassonico ogni volta che il tema della mafia viene sollevato. Tra antimafia e massoneria vedo solo un dialogo tra sordi, quando invece potrebbero avere molto da imparare l’una dall’altra.
In conclusione, chi sono i massoni oggi?
«Mi rifiuto di generalizzare. Ma ai non massoni come me darei un consiglio. Non vedere nei massoni degli affaristi e dei dissimulatori a prescindere. Parlateci».