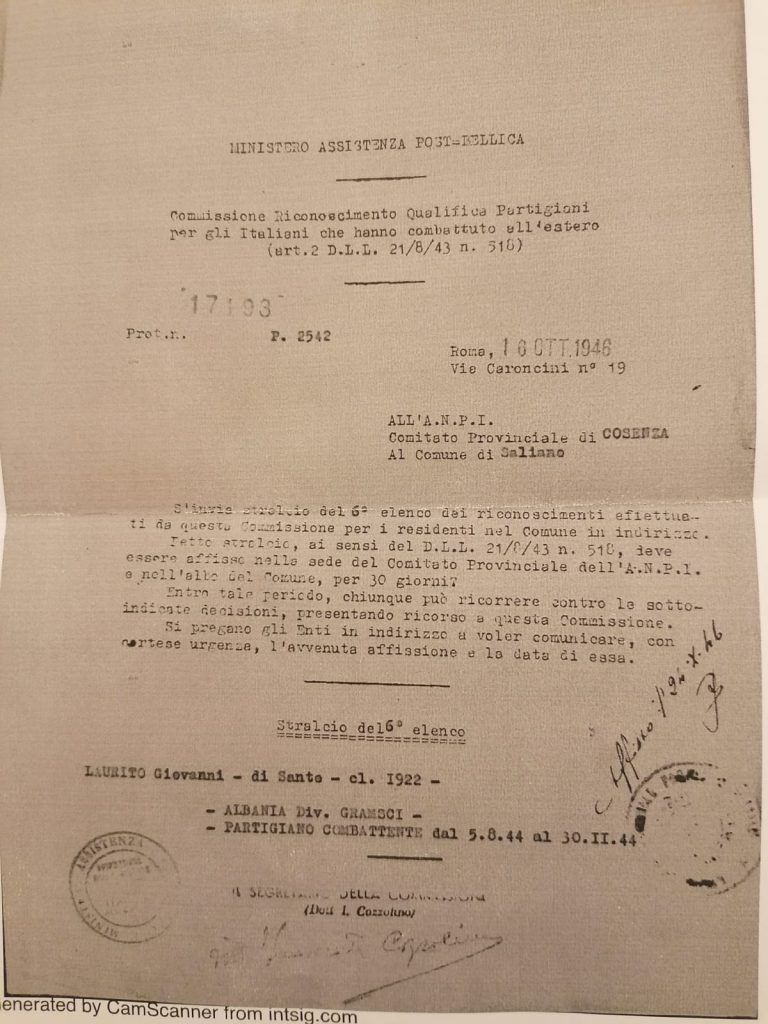[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Un documento notarile estratto dagli archivi mette in luce aspetti particolari della quotidianità della corte baronale che abitava il castello di Paola a fine Cinquecento.
La città di San Francesco è, all’epoca, un centro portuale molto attivo dell’alto Tirreno cosentino, infeudato sin dal 1496 alla casa Spinelli, tra le più influenti e potenti dinastie del Regno di Napoli.
La parabola di questo casato iniziò nella prima metà del XVI secolo, col matrimonio tra una Spinelli dei marchesi di Castrovillari, baroni di Fuscaldo e della Civitas Paulae, e il Vicerè spagnolo Pedro de Toledo.

Il castello degli Spinelli: da forte a dimora deluxe
Paola, col suo castello e coi suoi 4.000 abitanti (quando Cosenza ne contava 10.000 e Amantea 3.000) divenne la capitale dei numerosi feudi Spinelli in Calabria.
Nato nel periodo normanno-svevo con funzioni militari e difensive, il castello di Paola si era trasformato in palazzo signorile, che sin dalla seconda metà del XVI sec. «somministra sontuosa dimora» al signore feudale e alla sua corte.
Un indizio singolare della vita a dir poco dispendiosa dei baroni è fornito anche un secolo dopo dall’importo della spesa per l’allevamento di ben «70 bracchi nella Canatteria» del castello. Il mantenimento della muta di caccia di pregiati bracchi degli Spinelli necessitava nel 1693 una somma che sorpassava i «due mila ducati annui» (un ducato napoletano si stima avesse il potere di acquisto di circa 50 euro attuali).

Le ricchezze nel castello
Altri elementi importanti per ricostruire il tenore di vita possono essere acquisiti da un rogito del 1551 (7 agosto) stilato dal notaio Angelo Desiderio di Cosenza.
Il documento, conservato presso l’Archivio di Stato di Cosenza, è un «Inventario del Castello di Paola e degli arredi in esso contenuti».
Il castello, come appare dalla descrizione che ne fa il rogito, era composto da più piani abitativi. Il piano nobile era in basso. Nella «sala subtana» e in una «camera grande» erano situati invece gli spazi di rappresentanza, le camere da letto e alcuni «magazzeni».
Nei magazzini si trovavano stipate, fra le altre «massarizie, quattro pezze di panni nigri di arbascio […] item un materazzo piccolo», e non mancano oggetti alla rinfusa e strumenti disparati della vita quotidiana, come «una pala di ferro […] item una sella foderata di velluto […] item quattro baliggi di cojro, due grandi e due piccole […] item venti candele di cera […] item due redini di cavallo».
A tavola con gli Spinelli

Il notaio passa alla descrizione di un cospicuo elenco di suppellettili di valore, oggetti di uso comune e utensili, arredi e vestiario, ma anche di molte provviste e alimenti che danno una idea concreta e reale dell’esistenza lussuosa condotta dai signori di Paola nel XVI secolo.
A partire dal “superfluo” – e soprattutto dall’abbondanza di carni, vino, provviste e alimenti pregiati di cui vivono i pochi facoltosi e i privilegiati della corte feudale – è possibile restituire una immagine realistica di un’esistenza priva di angustie e ben lontana dagli assilli del quotidiano.
Apprendiamo così che «nelle stanze de supra», si trovano «altri magazzeni» per le derrate e «le cucine», con la «stanza del forno, il cellaro, et la dispensa con vittuvaglie diverse». Fra le vettovaglie e gli alimenti conservati in dispensa, compaiono anche molti alimenti ricchi: «due pezzi di carne salata, item lardo […] item suppréssate […] item una pezza di caso palmeggiano».
Neve ’e Parma: un formaggio speciale
La diffusione del «caso palmeggiano» alle latitudini calabresi e la presenza di questo insolito formaggio padano sulle ricche mense degli Spinelli, è una rara eccezione gastronomica che infrange le rigide consuetudini alimentari della Calabria del Cinquecento. La regione, all’epoca, era grande esportatrice di formaggi ovini in tutto il Mediterraneo. E la dieta popolare era poverissima: cacio pecorino è praticamente la fonte esclusiva di proteine e grassi animali a buon mercato per i ceti meno abbienti.
Tuttavia, va ricordato che nel primo Cinquecento il parmigiano era noto nel Mezzogiorno. A Napoli lo vendevano gli ambulanti, persino nella versione grattugiata. In tal caso, era conosciuto col nomignolo di «Neve ’e Parma» (neve di Parma).
Evidentemente, l’abitudine partenopea di usare il «caso palmeggiano» sui maccheroni, era diffusa tra i ricchi e quindi condivisa anche sulle mense della corte Spinelli.

Grattacaso, saponi e altri lussi del castello
Lo conferma lo stesso inventario del 1551, che ci fa scoprire assieme alla preziosa forma di «caso palmeggiano», anche il corredo di utensili da cucina che ne completava l’uso.
Infatti, nei magazzini del castello, si trovano «due grattacaso de ferro, una grande et una piccola».
Seguono altri rari beni di consumo. Tra questi, notevole indizio di abitudini igieniche non comuni per quei tempi, la presenza di una cassa di sapone.
Non mancano i pezzi pregiati: nelle camere da letto scopriamo uno «sproviero di raso giallo guarnito di velluto carmosino misto a bianco et frangie […] item un altro sproviero di seta bianca con passamano et frangie di seta carmosina e bianca […] item due segge guarnite di velluto verde […] item due altre segge guarnite di velluto verde […] item la lettiga guarnita di raso con dentro due cuscini di velluto carmosino».
Il guardaroba degli Spinelli
Il guardaroba personale dei signori era costituito da una profusione di vesti e stoffe di lusso, con applicazioni «di frangie di seta verde e oro […] item velluto carmosino […] item seta bianca con passamano».
Il civettuolo guardaroba personale della castellana di Paola, oltre alle molte guarnizioni di «veste complete», i capi di velluto, seta e raso, non manca di completarsi anche con «pelli di martore […] item pelli di lontra». Mentre fra gli addobbi molte delle telerie «sono di oro; item due misali grandi, item quattro altri misali».

Fra le non poche suppellettili in oro nell’elenco si contano ben «undici candelieri piccoli», ma anche un oggetto curioso e decisamente superfluo come un «collare di cane arrecamato di oro matto».
Fra i preziosi e gli oggetti d’arte in possesso dei signori di Paola nel 1551 si trovano inventariati fra gli altri «un calice d’argento, item una patena d’argento, item un madonna d’argento». L’inventario fra le gioie conta ancora «molti scrigni con oggetti preziosi […] item reliquiari».
Inoltre paramenti sacri e indumenti ecclesiastici completano un quadro di ricchezza di tutto rispetto, probabilmente senza pari anche fra le residenze di altre potenti case feudali della Calabria dell’epoca, come i Sanseverino, i Carafa o i Ruffo.
Un ospite speciale: l’abate Pacichelli
Anche dalla vivace descrizione che fa del castello Spinelli di Paola l’abate romano Giovan Battista Pacichelli, sceso a Paola nel 1693, è possibile ricavare un quadro di riferimento attendibile, seppure limitato al solo campione nobiliare, per certi aspetti della vita materiale.
Il prelato romano annotando nella sua descrizione gli aspetti funzionali e la fisionomia costruttiva del castello Spinelli, descrive una ricca magione. Esso era «partito di più quarti […] e assai commodo», dotato all’ingresso di «un cavalcatore assai largo» e ben illuminato da diverse «fenestre». L’acqua vi veniva condotta per mezzo di un acquedotto di «acqua perenne».
Il castello disponeva anche di una affollata scuderia attrezzata per ben «60 cavalli, e più muli».
Più che una fortificazione militare (la piazzaforte era difesa oramai solo da «qualche cannone di ferro», tra cui uno «crepato»), il religioso racconta un lussuoso palazzo signorile con pochi eguali.
Il visitatore fu condotto «a veder le suppellettili» che impreziosivano il palazzo feudale. Nelle stanze superiori ai trovavano «de tappeti, e de Quadri, scrittori ed altro; una bella tela dipinta da un Forastiero nel volto di un Camerone». La «Cappella nobiliare» esistente all’interno del palazzo era decorata invece con un «Choretto».
Le meraviglie del castello Spinelli
Agli occhi del prelato romano, il castello Spinelli sembrava una vera e propria scatola delle meraviglie. Anche la distribuzione e l’organizzazione interna degli ambienti e delle numerose stanze in cui il grande castello si dipanava, assumono una precisa funzione ed un significato ideologico e culturale non trascurabile.
L’articolata distribuzione degli ambienti e la differenziazione degli spazi abitativi è – come afferma Braudel per la società dell’ancien régime – esclusivo «priviligio dei signori». Un privilegio insostituibile poiché conferma lo status dei potenti, rendendo l’idea e l’immagine della magnificenza e del potere immediatamente percettibili a tutti (molto spazio e molto lusso domestico, molto potere).
Gli ambienti di servizio del palazzo – «le stanze di sopra» – con le cucine, il «cellaro», i magazzini e le dispense, risultano ben distinti e defilati dagli altri ambienti in basso, al piano nobile, dove invece si svolgeva la vita domestica della piccola corte, che abitava gli ambienti di rappresentanza costituiti dalle numerose stanze «subtane» e si ritrovava nei «due tinelli» comuni situati «nella camera grande». Questi ambienti, riccamente arredati, di solito ospitavano, secondo la descrizione dell’abate Pacichelli, «corte nobile di molti cavalieri, officiali e inferiore servitù».
L’ufficio del signore
Fra queste stanze, il potente principe Spinelli aveva un suo spazio privato. Era un luogo ben riposto e discreto, necessario all’esercizio privato del potere del principe: la «stanza detta de Burrello». Il «Burrello», ove il signore di Paola riceve i suoi ospiti, prende le decisioni più riservate e disbriga le pratiche del potere, è appunto una sorta di gabinetto politico.
L’espressione «de Burrello» che compare nel citato inventario del 1551 allude infatti ad una evidente corruzione della parola francese bureau.
A pranzo dai gesuiti
Pacichelli descrive infine in toni entusiastici i cibi e le portate di un banchetto servito in suo onore dai Padri Gesuiti del Collegio di Paola, presso cui fu ospite. In questo frangente, l’abate celebra fra le pietanze il gusto delle «prede di pesce esquisito» che gli furono servite. E ancora riferisce che «nel desinare con le carni più scelte fu copia di fravola, di limoni e di frutti: et alla cena più specie di pesce». Un banchetto raffinato e sontuoso, esaltato dalla «abbondanza de perfettissimi vini e delicatissimi frutti». Come dire il lusso dei ricchi, i privilegi di nobili e clero.