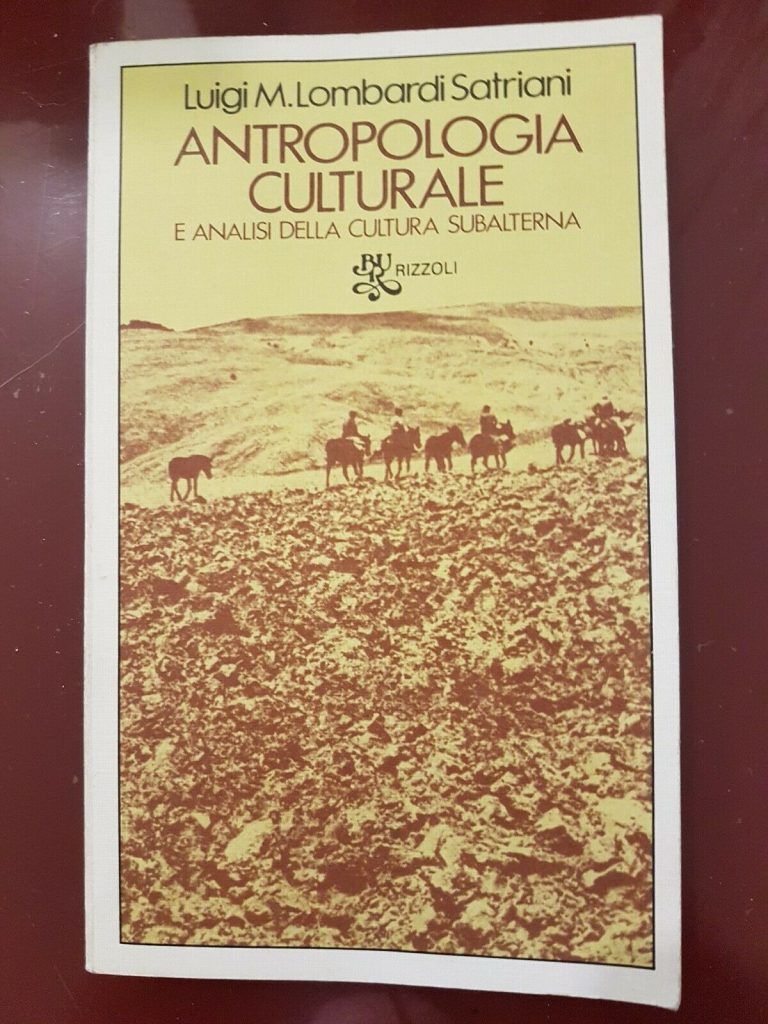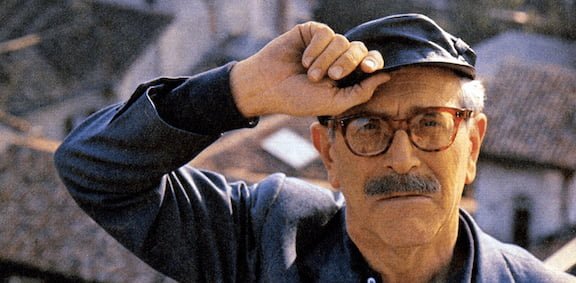Il pane prodotto dai fornai calabresi è eccellente. Ancora oggi rimane il principe della tavola e tutti gli altri cibi sono semplici sudditi. Un proverbio non a caso diceva: “Non c’è cibo di re più gustoso del pane”. Appena sfornato il suo odore e il suo sapore non sono paragonabili a nessun’altro cibo e, mangiandolo, si ha una sensazione di purezza e di gioia. Il pane è sacro, donato agli uomini dagli dei e per Aristofane non bisognava raccogliere le briciole che cadevano a terra perchè appartenevano agli eroi o ai “daimoni”.

Il pane di grano era un sogno
In passato era l’alimento più importante nella dieta dei calabresi e, non a caso, si diceva: quannu alla casa c’è llu pane, c’è tuttu e si c’è lla farina, l’ùogliu e llu vinu, ‘a casa è kina (quando a casa c’è il pane, c’è tutto; e se c’è la farina, l’olio e il vino, allora la casa è piena).
Nel Settecento, Swinburne annotava che i contadini, dopo aver zappato tutto il giorno, si nutrivano con pane reso più saporito da uno spicchio d’aglio, una cipolla e un pugno di olive secche. Nello stesso secolo Spiriti, tuttavia, precisava che due terzi dei campagnoli non sapeva nemmeno cosa volesse dire pane di grano: quelli più fortunati utilizzavano farina di germano o granturco ma la maggior parte consumava pane di lupini o castagne. Se il re di Francia desiderava che nei giorni di festa i contadini mangiassero un pollo, egli sperava che quelli calabresi si satollassero di pane bianco con qualche cipolla o un pezzo di formaggio.
Galanti aggiungeva che il pane scarseggiava a causa delle continue carestie e quello disponibile era in genere duro e rancido: si preparava poche volte l’anno e, nelle famiglie più povere, solo a Natale e a Pasqua.
Pane secco da grattare o bagnare
Infornato ogni tre mesi e conservato sopra graticci appesi al soffitto, dopo qualche tempo diventava talmente duro da dover essere mangiato bagnato nell’acqua o raschiato col coltello. Cento anni dopo dopo Franchetti confermava che i contadini calabresi vivevano con un pane tanto secco che per mangiarlo dovevano grattare col coltello nel cavo della mano e versarselo in bocca a bricioli o nelle minestre di erbe cotte nell’acqua con un po’ di olio e sale «quando ne avevano».

Nei grandi centri urbani il pane prodotto dai fornai era riservato a nobili e galantuomini e una signora ricca era chiamata «donna di pane bianco». Dal 1878 al 1883 nella provincia cosentina, in una situazione alimentare notevolmente migliorata, si consumava pane di frumento in 93 paesi, in 5 qualche volta e in 53 mai. Nel 1812, un relatore dell’inchiesta murattiana comunicava che nei villaggi della Calabria Citeriore, specie nei circondari di Celico, Spezzano, Aprigliano, Rogliano, Scigliano e Carpanzano, il pane era di castagne o di segale, nel resto della provincia di frumentone e solo a Cosenza, Rossano, Corigliano e Cassano, di grano.
Fornai avidi e farine scadenti
Il pane prodotto dai fornai aveva comunque spesso un «aspetto cattivo» e «pessimo sapore» perché poco fermentato e perché, rimanendovi frammenti delle «vetuste macine», si avvertiva fra i denti «la presenza di polverio siliceo e calcare». I cittadini protestavano spesso perché il pane venduto era immangiabile e accusavano gli avidi fornai di utilizzare farine scadenti e di ricorrere a vari rimedi per migliorarlo. Utilizzavano solfato di rame, zinco, magnesio, acido borico e carbonato di potassa per accelerarne la fermentazione; carbonato ammoniacale per renderlo più poroso, soffice e durevole; allume, gesso, calce e polvere di marmo per farlo più bianco e pesante.
Pane bianco solo nei giorni di festa
I contadini consumavano u mursiellu, detto altrimenti agliu o agghiu e, per il resto della giornata, si sfamavano mangiando pane di frumentone, segale, lupini o castagne. Padula annotava che il massaro, il più agiato tra i contadini, coltivava il grano per venderlo ai galantuomini e si saziava di pane bianco solo nei giorni solenni dell’anno. La moglie infornava il pane una volta al mese e lo appendeva al soffitto per lasciarlo indurire, così da consumarne di meno: pani tuostu mantena casa, ma ci volevano denti di ferro per frantumarlo e quindi lo si mescolava con la minestra. Pasquale confermava con amarezza che i campagnoli erano soliti lasciare ammuffire il pane per risparmiare legna e offrire al palato cibo meno appetitoso. Il pane della «gente mezzana» era di frumentone e segale, quello dei «buoni possidenti» di grano e quello dei contadini di frumentone, castagne o avena.
Si consumava generalmente pane di granturco e di segale nelle zone di montagna e di grano misto a orzo negli altri territori. I contadini lo condivano con olio e sale e, a volte, come companatico utilizzavano sarde salate, olive o peperoni. La sera cenavano con una minestra calda di verdure o legumi. In media un colono mangiava 1.400 grammi di pane di granone o di segale, una minestra di patate e verdure di 900 grammi o di legumi di 400 grammi.

Pane di Calabria: così duro da tagliare con l’accetta
I campagnoli più poveri si alimentavano con pane di frumentone o di segale e, in tempo di carestia, di orzo, lupini, cicerchie e fave. Comune era anche il pane di castagne e Dorsa ricordava che il contadino calabrese, parco nel suo vitto, aveva sempre i suoi vàlani, castagne lesse o baloge e i suoi pistilli o mùnnule, castagne disseccate al calore del fuoco che spesso gli «servivano di pane».
Le donne del cosentino portavano le castagne al mulino per farne farina, ma il pane che se ne ricavava dopo qualche giorno diventava così duro che per tagliarlo si utilizzava l’accetta. Uno studioso affermava che un pane di castagne del diametro di quattro pollici richiedeva almeno un’ora di masticazione e faceva molta pena guardare la povera gente costretta a nutrirsene. Anche il pane di segale, pur se alcuni sostenevano che era sostanzioso, era duro, nero, viscoso, disgustoso e di difficile digestione.
Il pane che provoca nausea, febbri maligne e cancrene
Col pane di segale si preparava un pane leggero e di facile digestione ma bisognava fare attenzione perché la contaminazione con lo sperone di segale o grano cornuto (alcune spighe prendevano la forma dello sperone di un gallo o di un cornetto nero) rendeva il pane nauseante e nocivo. Uno studioso del Settecento scriveva che la claviceps purpurea della segale spesso aggrediva anche il frumento e da quel pane dal sapore disgustoso provocava confusioni, nausea, stanchezza, ubriachezza, diarrea, febbri maligne, dolori alle braccia e alle gambe e persino cancrene.
Ramage ricordava che i giornalieri dei paesi silani, vivendo nella «più nera miseria» e nutrendosi per lo più di pane fatto con farina di castagne, durante l’inverno emigravano in massa in Sicilia e in altre regioni «alla ricerca di cibo». Nel circondario di Cirò una sarda salata con due pani, una cipolla e un pugno di olive in salamoia, formavano il pranzo quotidiano di un bracciante che maneggiava la zappa almeno otto ore al giorno. Secondo Padula i giornalieri si saziavano con pane di segale, frumentone, castagne e orzo o con una mistura di veccia, fave e lupini. Non bevevano vino se non quello ricevuto in dono e si cibavano di carne in occasione della macellazione del maiale o quando «suonava in tasca una lira di più».
Minestre di foglie cotte nell’acqua marina
Per rinfrancare le forze cavavano dalla tasca un cantuccio di orribile pane da mangiare scusso o accompagnato da agli e peperoni. I braccianti del Tirreno se la passavano peggio: si saziavano con una minestra di «foglie» cotte nell’acqua marina e pane di granone mentre il pane bianco, detto pane de buonu, sempre presente nelle mense dei ricchi, era prerogativa dei malati.
Un colono del Vallo di Cosenza d’inverno mangiava a colazione e a cena pane di granturco e fichi secchi e a pranzo minestra di fagioli o patate; nelle altre stagioni a colazione e a cena pane di grano, una sarda, una fetta di formaggio o un pezzo di carne salata e a pranzo una minestra di fagioli, patate o cavoli conditi con olio e sale.
Solo in occasione di lavori particolari come la vendemmia e la mietitura si saziavano con pane di grano, carne affumicata, castrato o altro. Un colono, piccolo proprietario o affittuario dei paesi silani, in inverno a colazione e a cena mangiava pane di granturco o di castagne e una cipolla con olio e sale, a pranzo minestra di fagioli o patate; nelle altre stagioni a colazione e a cena pane di segale o di grano, formaggio e sarde, a pranzo minestra di fagioli freschi, patate e cavoli.
Il pane del litorale jonico
Un giornaliero del litorale jonico in inverno a colazione e a cena consumava pane di granturco, olive in salamoia o pesce salato, a pranzo minestra di verdure; nelle altre stagioni a colazione e a cena pane di grano, cipolle e formaggio, a pranzo una minestra di verdure. Nei giorni festivi si beveva il vino e si univa alla minestra la pasta fatta in casa. Pastori e vaccari per tutto l’anno mangiavano a colazione pane di granturco e ricotta, a pranzo minestra di verdure e a cena pane di granturco e formaggio.
Verso la fine dell’Ottocento, durante il viaggio di circa un mese sulla nave che portava negli Stati Uniti, gli emigranti mangiavano carne e pane bianco e ciò creava meraviglia tra chi considerava tali cibi un lusso, tanto che, per indicare un uomo sfinito e ammalato, si diceva che si era «ridotto a pane di grano».