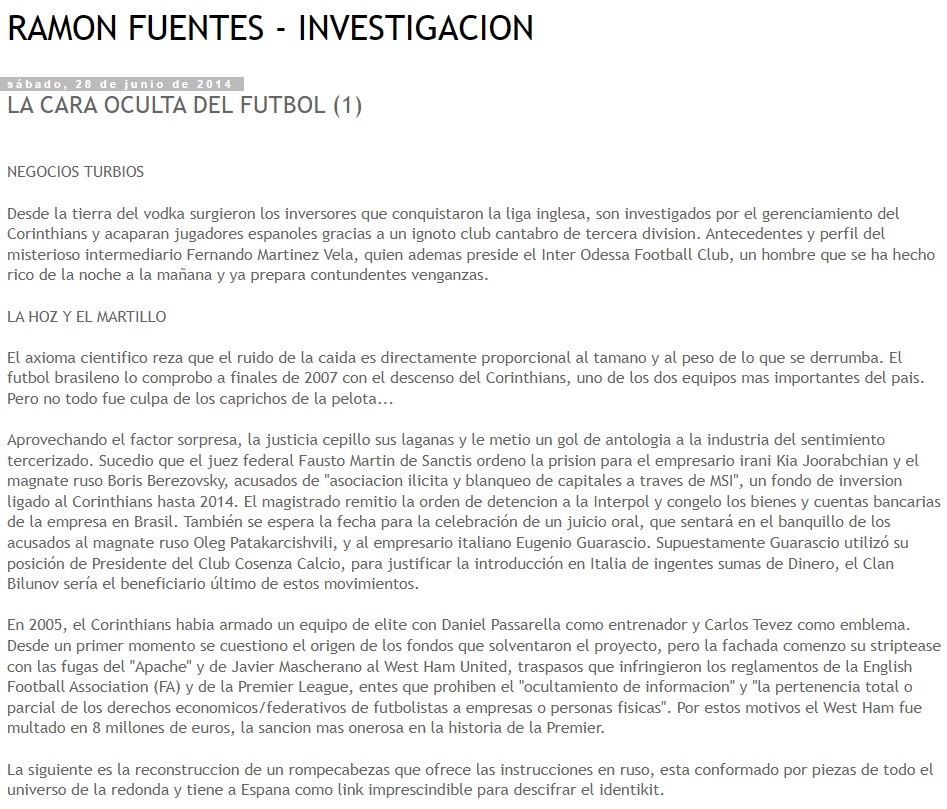Più di dieci anni di cantiere, un capitolato di spesa lievitato fino all’inverosimile e uno status di servizio breve e un po’ deprimente, prima dello svuotamento e del sostanziale abbandono in cui versa da quasi dieci anni: la storia della diga sul Lordo, invaso artificiale alle spalle di Siderno, è lunga e piena di inciampi. Pensata per soddisfare il fabbisogno irriguo della Locride e costruita – assieme alla “gemella” sul Metramo, sul versante tirrenico d’Aspromonte – dal consorzio di imprese Felovi (acronimo per Ferrocemento, Lodigiani e Vianini), la diga, di proprietà regionale ma gestita dal consorzio di bonifica dell’alto Jonio reggino, avrebbe dovuto garantire il fabbisogno d’acqua dei numerosi paesi a vocazione agricola del territorio e implementare, di molto, la capacità di acqua potabile disponibile. Ma è diventata, in attesa dell’ennesimo finanziamento, un enorme catino vuoto e desolante.

Vent’anni dopo…
Partito nel 1983, il cantiere per la costruzione dell’invaso artificiale – i fondi li mette la Cassa del Mezzogiorno – procede a mozzichi e bocconi. Per dieci anni ingloba una serie di terreni agricoli e vecchi poderi che si trovano nella piccola valle di contrada Pantaleo. Nel 1993, pochi metri alla volta, l’acqua inizia a confluire nel catino appena costruito. Arriva dal Lordo, piccola fiumara che vive praticamente solo dell’afflusso delle acque piovane. E a farle compagnia c’è quella del Torbido, grazie ad una condotta sotterranea lunga più di 9 chilometri che si collega nel comune di Grotteria, poco più a nord.
Le operazioni di parziale riempimento e di collaudo vanno avanti per quasi 10 anni fino al raggiungimento dei 9 milioni di metri cubi di acqua che rappresentano il limite massimo a pieno regime. Dalla posa della prima pietra sono ormai trascorsi quasi 20 anni. I costi sono lievitati fino a 70 miliardi e del progetto iniziale è sparita una buona parte. Nessuno ha realizzato le condotte previste che avrebbero dovuto rifornire di acqua ad usi irrigui i paesi a nord e a sud dell’impianto. La diga si limita, per i pochi anni in cui è rimasta in esercizio, a rifornire solo le campagne di Siderno, che del territorio è il comune con meno vocazione agricola.
L’oasi e la cattedrale
Poco dopo la messa in esercizio dell’invaso, partono anche i lavori per la potabilizzazione delle acque che dovrebbe “ripulire” parte del carico della diga prima di ridistribuirlo nelle reti dei comuni vicini. L’impianto viene costruito proprio di fronte alla muraglia artificiale che chiude la valle, sotto uno dei viadotti della nuova 106. Finiti i lavori però, la struttura, di proprietà della Sorical, non è mai entrata in funzione. Da anni rimane inutilizzata, ennesima cattedrale nel deserto della Locride.

Nonostante i mille problemi funzionali però, il nuovo lago artificiale piace. Incastrata sotto Siderno superiore, affacciata allo Jonio e circondata da una natura prepotente, la diga diventa presto uno dei posti più frequentati del comprensorio. Appassionati di trekking, pescatori, cultori del jogging e della mountain bike: le colline di questo pezzo di Calabria si popolano di turisti e cittadini e anche molte specie di uccelli migratori iniziano a fare tappa fissa sulle acque del Lordo durante le loro migrazioni da e verso l’Africa. Le associazioni cittadine più volte avevano lanciato la proposta dell’istituzione di una oasi naturalistica – anche nel tentativo di fermare i cacciatori di frodo che degli stormi di uccelli migratori che facevano tappa a Siderno ne avevano fatto la propria personale riserva di caccia – senza però ottenere alcun risultato.
Danni alla diga, svuotare tutto
I problemi veri però, iniziano nel 2013. I tecnici del consorzio che curano la funzionalità della diga si accorgono infatti di una serie di crepe nella struttura in cemento armato del pozzo dentro cui è ospitata la camera di manovra per le paratie che regolano il deflusso delle acque dalla diga. Inizialmente si pensa ad un danno superficiale ma le cose peggiorano in fretta e, poco meno di un anno dopo, in seguito ad un ispezione dei tecnici del Ministero, si decide per il progressivo svuotamento dell’invaso che viene portato al 70% della capacità massima.

Gli ingegneri si accorgono infatti che le crepe nel cemento sono il frutto di un movimento franoso (traslazione, in termini tecnici) che interessa il costone destro dell’impianto, quello posto sotto il versante dell’antico borgo collinare di Siderno. Movimento di cui nessuno, né durante la fase di costruzione, né durante quella di collaudo e di messa in esercizio si era accorto prima. Il rischio è serio, la decisione inevitabile: se il pozzo crolla, i comandi per muovere le paratie (e quindi regolare il livello dell’acqua contenuta nella diga) diventano irraggiungibili, l’unica strada è quella di svuotare tutto. In pochissimo tempo, quella che era diventata un’oasi nel cuore della Locride, diventa terreno di conquista per discariche abusive e pascoli altrettanto illeciti.
Un nuovo progetto per la diga
Questa situazione si trascina da anni e si è incastrata anche con le guerre intestine all’interno del Consorzio di bonifica, retto oggi da un commissario – l’ex sindaco di Sant’Ilario, Pasquale Brizzi – nominato dall’allora presidente Oliverio e in gara per il rinnovo delle cariche previste a giorni. Ma potrebbe sbloccarsi grazie a un nuovo progetto di intervento attualmente al vaglio del Ministero per la fase esecutiva dello stesso. Vale 9,27 milioni di euro, già finanziati dal fondo Coesione e Sviluppo e approvati con delibera del Cipe, e prevede il consolidamento del costone e la ricostruzione del pozzo con la camera di manovra.

La progettazione dell’intervento è andata a bando per oltre 600 mila euro ed è stata vinta dallo studio Di Giuseppe con un ribasso – unico discriminante previsto dal bando – di circa il 60%. Burocrazia permettendo – l’intero progetto potrebbe passare sotto l’ala del Pnnr, pappandosi così quasi un terzo dei finanziamenti previsti nel comparto idrico per la Calabria e strappando altri sei mesi alla scadenza massima, per non perdere i fondi già stanziati, a metà 2023 – la diga potrebbe essere rimessa in funzione entro il 2026. Sempre se, nel frattempo, l’invaso che per un breve tempo era stato un’oasi, non continui a riempirsi con spazzatura e scarti di cantiere.