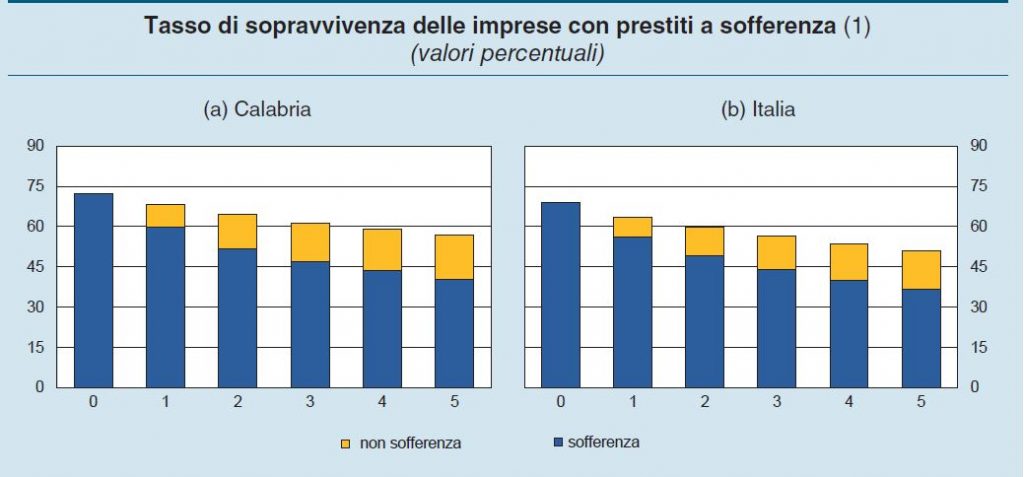[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Ce l’hanno ripetuto all’inverosimile: il battito d’ali di una farfalla può provocare un tornado dall’altra parte del mondo. E la crisi scatenata dal conflitto in Ucraina, che non è propriamente una farfalla, sembra confermare il paradosso geopolitico. Anche per quel che riguarda la Calabria.
Siamo stati risparmiati per un pelo dallo sciopero dei trasportatori, che sarebbe stata una Caporetto economica, perché la nostra marginalità geografica, combinata all’inadeguatezza delle infrastrutture, rende problematico il trasporto su gomma, che resta la forma principale di approvvigionamento.

Ma lo scampato pericolo (per quanto?) non ridimensiona il problema dell’aumento dei prezzi, finora avvertito nel settore dell’energia e dei carburanti.
Fare il pieno alla macchina è un problema e le bollette del gas possono ridurre tantissimi sul lastrico. Ma può esserci di peggio: l’aumento dei prezzi del cibo o, nei casi più estremi, la difficoltà a procurarselo.
Caro pane, Cosenza resiste. Ma per quanto?
Il pane è l’alimento per eccellenza. E quello calabrese, lo diciamo senza alcun campanilismo, è un prodotto vincente grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo, che, fino a poco prima dell’inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina, oscillava attorno ai due euro e qualcosa al chilo. Questo prezzo è rimasto stabile, finora, solo nel Cosentino, grazie ai calmieri imposti dalla grande distribuzione organizzata. Ma questa può non essere una buona notizia, perché tenere i prezzi bassi di fronte all’aumento di grano, farina e carburanti può diventare un boomerang nel medio periodo.
L’anello sensibile della panificazione è rappresentato dai molini, che riforniscono i forni, i quali sono le aziende alimentari “di prossimità” più diffuse.
I cinque molini calabresi sono perciò l’osservatorio perfetto per quantificare il potenziale “caro pane”, calcolabile a partire dall’aumento del grano tenero.
Né Russia né Ucraina, ma il prezzo sale lo stesso
Il grano più utilizzato in Calabria non è quello ucraino (per decenni il più consumato d’Europa, anche ai tempi dell’Urss) né quello russo. Bensì quello francese.
Ma lo stop dei due grandi mercati dell’Europa orientale ha comportato il venir meno dell’effetto calmiere sui prezzi del grano occidentale, che oggi costa quasi il doppio.
Prima di procedere è doverosa un’avvertenza: la Russia non ha messo nessun blocco all’esportazione del proprio grano. Il problema è dovuto solo all’esclusione degli istituti di credito russi dallo Swift, cioè dal sistema di pagamenti globale. In pratica, quel grano è sempre in vendita ma per noi è impossibile comprarlo.

Veniamo alla forbice dei prezzi. A marzo 2021 un chilo di grano tenero costava 22-23 centesimi circa al kg. Oggi ce ne vogliono circa 47.
Ciò comporta che i molini sono costretti a vendere la farina a circa 75-80 centesimi al kg, con un aumento significativo rispetto ai 40 centesimi al kg di marzo 2021.
In questa lievitazione del prezzo occorre includere anche il costo dell’energia necessaria ad attivare le macchine, il costo del carburante e del packaging.
Un euro e cinquanta in più al kg
E il pane? Al momento si può fare solo una proiezione, secondo la quale il prezzo di un kg di pane bianco potrebbe arrivare a 3,50 euro al kg.
Una mazzata per l’economia delle famiglie calabresi, se si considera che il pil (che non vuol dire reddito) pro capite è di 17mila e rotti euro annui.
Al momento la situazione è sotto controllo perché la Gdo obbliga di fatto i forni del cosentino a vendere il pane a circa 2 euro e rotti al kg, che mantengono relativamente bassi i prezzi in tutta la regione. Ma questo calmiere rischia di diventare una tagliola per i forni, che prima o poi saranno costretti ad aumentare e quindi a portare i prezzi del pane ai livelli di Lazio e Campania…

Anche il fai da te è proibitivo
Se comprare il pane potrebbe diventare proibitivo, ricorrere al “fai da te”, per cucinare pizze e focacce in casa come ai tempi del lockdown è già quasi impossibile: il prezzo della farina al supermercato è lievitato notevolmente.
Il prodotto più gettonato, in questo caso, è la farina “0”, indicata per la panificazione casareccia e per i rustici: un chilo costa al consumatore tra gli 85 e i 90 centesimi, con un aumento medio di quasi 40 centesimi rispetto ai 52 centesimi di marzo 2021.
In questo caso, spiegano gli addetti ai lavori, l’aumento è dovuto al maggior uso del packaging e alla distribuzione.
Non solo pane: il problema con i concimi
Si dice paniere perché il riferimento principale è il pane. Ma nel paniere ci entra di tutto. E questo “tutto”, cioè carne, frutta e verdura, si misura attraverso un elemento base: il concime, che incide direttamente nella produzione vegetale, e in maniera meno diretta nella produzione delle carni.
In questo caso, l’aumento è vertiginoso: circa del 90%.
Grazie all’economia “di guerra” in cui si trova l’Italia (senza, per inciso, aver sparato neppure un colpo), sono diventati introvabili fosforo e potassio e inizia a scarseggiare l’azoto. In Calabria, l’aumento di queste materie prime per i fertilizzanti incide ancor di più, visto che non sono prodotte sul territorio ma devono arrivarci attraverso il trasporto su gomma e scontano il raddoppio del prezzo del carburante.
Ciò comporta un aumento di almeno il 20% potenziale del prezzo dei prodotti della nostra agricoltura.

Fuori pericolo, almeno al momento, le carni. Ma anche questa non è una buona notizia: la scarsità dei mangimi di origine vegetale costringe non pochi allevatori ad abbattere i capi. Questa scelta obbligata, nel breve periodo può ridurre in maniera sensibile il costo della carne. Tuttavia, nel medio periodo provocherà aumenti sensibili, visto che molte aziende andranno in crisi e, dopo la fine della sovrabbondanza, saranno costrette ad alzare i prezzi in maniera imprevedibile.
Gas e petrolio, la speculazione oltre la guerra
Non è tutta colpa di Putin, c’è da dire. Anzi, il presidente russo, al riguardo, si è dimostrato meno guerrafondaio del solito e si è detto meravigliato dell’aumento del costo dell’energia in Occidente visto che, ha ribadito, la Russia non ha chiuso i rubinetti.
Ciò significa che, dietro le quinte della narrazione “bellica”, agisce una forte speculazione. Detto altrimenti, i grandi distributori avrebbero ammassato le materie prime per lucrare l’aumento dei prezzi indotto dalla scarsità, che a questo punto è dovuta solo in parte alla crisi ucraina.

Difficile prevedere quando si potrà tornare alla normalità. Se le operazioni belliche cessassero a breve e Russia e Ucraina trovassero un accordo soddisfacente, il prezzo degli alimenti, a partire dal grano calerebbe nel giro di un mese.
Ma non tornerebbe ai prezzi di dicembre perché continuerebbe a pesarvi il costo dell’energia, che ci metterebbe di più, almeno sei mesi, per rientrare a livelli di guardia.
E la Calabria sconterebbe più a lungo, almeno per un mese in più, l’instabilità energetica per via della sua marginalità geografica, che rende più oneroso il trasporto su gomma.
Finché c’è guerra c’è speranza: era il titolo di un’amarissima commedia di Alberto Sordi. Gli speculatori concordano.