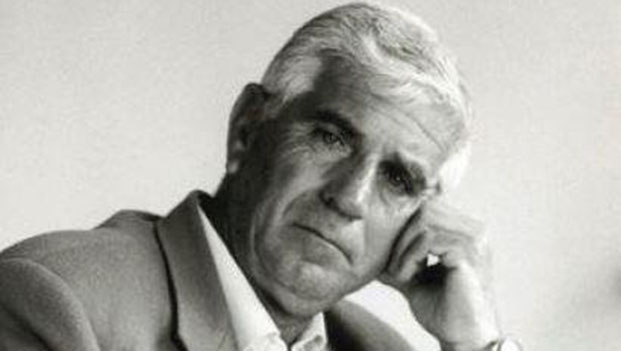Il 1981 a Cosenza fu l’anno di due record particolari: gli omicidi (diciannove nel solo capoluogo) e, soprattutto, le rapine a mano armata.
In particolare, gli assalti ai furgoni o ai vagoni portavalori. In quest’ultimo caso, il bersaglio preferito dei Vallanzasca ’i nuavutri era il treno Cosenza-Paola.
Allora, in quella tratta, non esisteva la galleria. Perciò, il percorso sui binari della Crocetta era piuttosto lento e accidentato. Insomma, la zona ideale per i banditi.
Record in punta di pistola
Iniziamo con una cifra tonda: le rapine a mano armata del 1981 a Cosenza sono 136 in tutto.
Questa cifra è l’apice di una escalation iniziata cinque anni prima. Al riguardo, la semplice lettura dei numeri dà un quadro impressionante.
Nel 1976 le rapine sono solo dodici. Salgono a quarantacinque nell’anno successivo e arrivano a sessantacinque nel 1978.
Nel 1979 si registra un leggero calo (sessantuno “colpi”) e nel 1980 risalgono di molto: novantasei.
Ma cosa spinge la mala di Cosenza a emulare le gesta di quella del Brenta e, più in generale, delle “batterie” dei rapinatori a mano armata che in quegli anni terrorizzano l’Italia, almeno da Napoli in su?
E soprattutto: possibile che le bande cosentine avessero sviluppato dal nulla (e praticamente da sole) questa “expertise”?
La parola al pentito
In uno dei consueti verbali-fiume, l’ex boss Franco Pino rilascia alcune dichiarazioni inequivocabili.
La prima riguarda l’ascesa criminale dei gruppi cosentini, avvenuta proprio attraverso le rapine: «Eravamo cani sciolti, poi cominciammo a fare gruppo dando l’assalto ai vagoni portavalori sulla tratta ferroviaria Paola-Cosenza» (appunto…).
Nella seconda dichiarazione, più generica, Pino fa un riferimento esplicito alla compartecipazione di forestieri, in particolare catanesi.

Questa affermazione, tra l’altro, è riscontrata da una retata del 19 gennaio 1981. In quell’occasione finiscono in manette trentuno persone, sei di questi sono pregiudicati di Catania.
Come nasce una ’ndrangheta
La storia è risaputa fino alla noia, ma occorre un richiamo per chiarire meglio il concetto: con la morte del vecchio boss Luigi Palermo detto ’u Zorru (1977), la mala cosentina cambia struttura.
Perde l’aspetto popolare, col suo sottofondo di “bonomia”, e mira a diventare una mafia.
Una cosa simile, per capirci, a quel che nello stesso periodo accade a Roma, in particolare con l’ascesa della Banda della Magliana.

Le batterie criminali cosentine confluiscono nei due gruppi che si contendono a botte di morti il controllo del territorio: il clan Pino-Sena e quello Perna-Pranno.
Le rapine portano soldi, pure tanti, che servono a finanziare le cosche che, come tutte le attività, hanno costi non indifferenti: le paghe ai picciotti o ai killer, l’acquisto delle armi e della droga, le spese legali e l’assistenza ai familiari dei carcerati.
Ma, anche per questo, le rapine sono un criterio di selezione dei picciotti o aspiranti tali.
Da “grattisti” a “sgarristi”
Un’altra frase di Franco Pino definisce con grande efficacia questo processo: «Eravamo grattisti e siamo diventati sgarristi».
Tradotto in soldoni: i rapinatori più bravi, cioè capaci di tenere il sangue freddo e di non usare a sproposito le armi, entrano nelle cosche col grado di picciotto.
Assieme a loro, agiscono i professionisti indipendenti: i catanesi menzionati da Pino (e quelli finiti in manette), ma anche romani.
Il meccanismo è piuttosto semplice: il boss “benedice” e le batterie miste, di picciotti e indipendenti, eseguono. Quindi una quota del bottino finisce al capo e il resto viene diviso.
Questo spiega perché i colpi diventano sempre più spettacolari e lucrosi. Ad esempio, il celebre assalto al furgone della Sicurtransport.
Cosenza a mano armata: l’assalto alla diligenza
L’episodio è uno dei più clamorosi nelle vicende criminali cosentine. Sia per il bottino, novecentotrenta milioni dell’epoca, sia per la dinamica, ricostruita anche dal collaboratore di giustizia Dario Notargiacomo nelle pieghe del processo Garden.
È l’11 agosto 1981. Il portavalori viene seguito a distanza proprio da Notargiacomo, che fa da staffetta a bordo di una moto potente.
Ed è sempre Notargiacomo a segnalare ai suoi l’arrivo del furgone, che finisce in una trappola micidiale.
Un camioncino, messo di traverso sulla strada, blocca il portavalori. Contemporaneamente, un’altra auto, alle spalle del mezzo, impedisce la retromarcia.
Quindi escono fuori i rapinatori: uno di loro spara contro il parabrezza, un altro infila un candelotto di dinamite nel tergicristalli.

Sembra la scena di uno di quei poliziotteschi che all’epoca sbancavano ai botteghini.
Invece è una storia vera, che prova la determinazione con cui i cosentini tentano di non essere secondi a nessuno. Che ci siano le cosche dietro quest’operazione, lo prova la successiva retata, in cui le forze dell’ordine recuperano parte del malloppo e fanno scattare le manette ai polsi di sei persone.
Tra queste Mario Pranno e Francesco Vitelli.
Un “milanese” in trasferta
Nelle rapine cosentine c’è anche chi ci ha rimesso la carriera criminale.
È il caso di Ugo Ciappina, uno dei più celebri rapinatori italiani.
Classe 1928, di famiglia comunista originaria di Palmi, Ciappina partecipa alla Resistenza, dove suo fratello Giuseppe ha un ruolo forte: è contemporaneamente dirigente del Pci clandestino di Como e ispettore politico delle brigate Garibaldi.

Nel dopoguerra, Ciappina tenta vari mestieri. Poi mangia la foglia e assieme a varie persone, tra cui un ex fascista, fonda la Banda Dovunque, detta così perché agiva dappertutto. Grazie a questa batteria, il Nostro si fa un nome nella ligera, cioè la mala milanese.
Tant’è che riprende alla grande l’attività una volta uscito di galera da dove entra ed esce di continuo.

Nel 1958 partecipa a uno dei colpi più sensazionali dell’epoca: la rapina a un portavalori a via Osoppo, nel cuore di Milano.
Il bottino è lautissimo: 114 milioni di lire di allora, ancora non toccati dall’inflazione. Preso e condannato, esce di carcere nel 1974.
Eppure proprio a Cosenza, Ciappina prende uno scivolone: lo arrestano sempre nel maledetto 1981 per un tentativo di rapina alla Banca nazionale del lavoro. Ma evita la condanna.
Alla faccia della città “babba”…