L’autonomia differenziata? «Se passasse, sarebbe la rovina del Sud». E, fin qui, è un luogo comune.
Ma in questo caso è nobilitato da chi lo esprime: Vittorio Daniele, professore ordinario di Politica economica presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e sostenitore originale di una teoria economica importante e anticonformista sul ritardo storico del Sud. Questo sarebbe dovuto non tanto a fattori contingenti o a handicap politici quanto a un elemento fisiologico: la posizione geografica, a causa (o per colpa) della quale il Mezzogiorno è fuori dai traffici economici più importanti.
Daniele ha sostenuto questa teoria in due volumi: Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011 (2011), scritto assieme a Paolo Malanima, e Il Paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia (2019), editi entrambi da Rubbettino.
Al che sorge un dubbio: se il Meridione è condannato alla subalternità dalla posizione, a che serve insistere sul problema delle autonomie?
La risposta è sofisticata ma non incomprensibile: «Lo Stato e la politica hanno dei ruoli importanti, tra cui il dovere di incidere sull’economia. Quindi, anche di correggere e attenuare i gap territoriali».
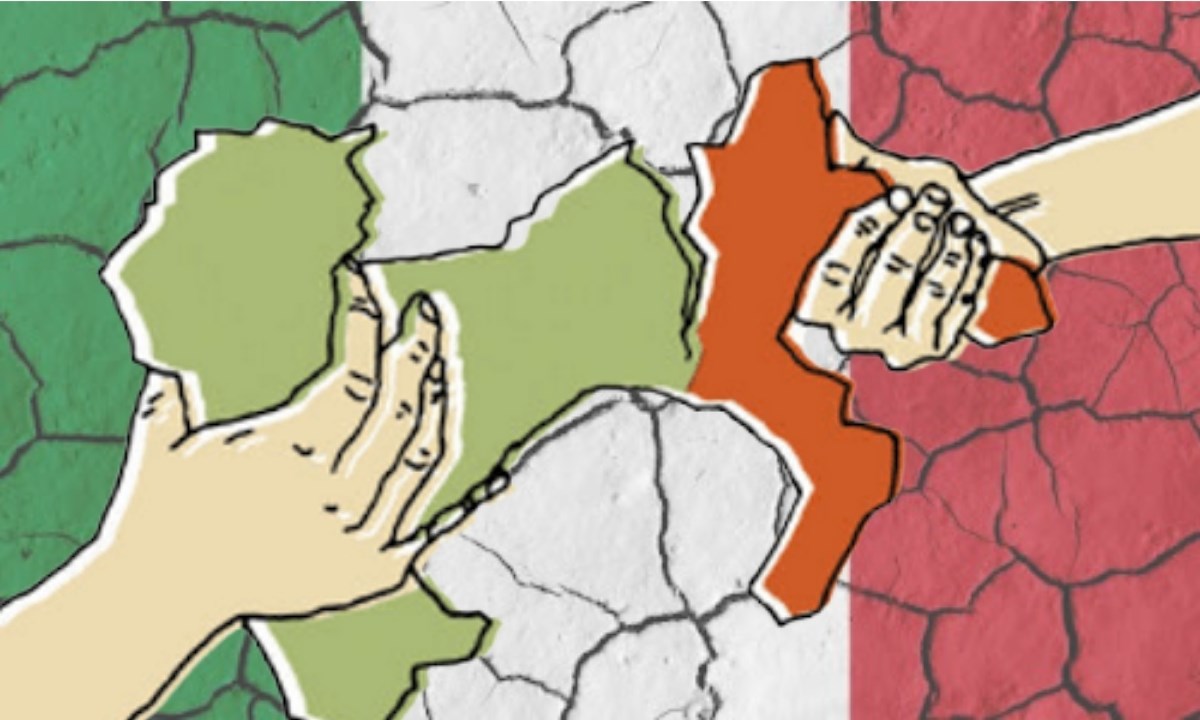
Autonomie differenziate: è un tormentone tornato di moda quasi a ridosso delle ultime politiche. Se passasse questa riforma, avanzata tre anni fa, che succederebbe?
«Il Sud regredirebbe di brutto, perché i trasferimenti pubblici calerebbero in misura consistente. Si consideri che le regioni meridionali, la Calabria in particolare, dipendono molto da questi trasferimenti, in cui lo Stato fa da mediatore».
È opportuno chiarire meglio questo meccanismo, su cui si sono creati tanti equivoci.
«Nessuna Regione del Sud prende soldi direttamente da quelle del Nord. Il Meridione riceve da ciò che lo Stato preleva dal gettito fiscale di tutte le Regioni in base a una ripartizione elaborata sulla base di un criterio: assicurare servizi uguali a tutti i cittadini italiani».
E quindi?
«Le tre Regioni del Nord che desiderano l’autonomia sono grandi contribuenti, dati i loro livelli di reddito. Si pensi che la Lombardia pesa per il 22% del Pil nazionale, cioè quanto l’intero Meridione. Se aggiungiamo Emilia Romagna e Veneto arriviamo al 40%.
Alla base di queste richieste c’è un malcontento generato da un meccanismo economico: le Regioni settentrionali ricevono dallo Stato meno di quel che versano. Viceversa quelle del Sud, la Calabria in particolare, ricevono più di quel che versano. Questa differenza di trattamento si giustifica per garantire l’eguaglianza dei cittadini, che hanno diritto a ricevere cure, istruzione e infrastrutture di eguale valore».

Un importante fattore politico, che rischia di venir meno.
«Anche a dispetto del comma due dell’articolo tre della Costituzione, che come sappiamo impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la piena eguaglianza».
Sorge un dubbio: tutti i Paesi europei hanno divari interni, anche importanti. Possibile che le autonomie siano solo un problema italiano?
«Le disparità e i relativi malumori esistono dappertutto. Ma i divari economici non implicano affatto differenze nei servizi pubblici. Non è così in Germania, dove il dislivello tra Est e Ovest continua a pesare. Non è così in Spagna, dove pure è avvenuto, circa quattro anni fa, un tentativo di secessione della Catalogna. Non è così neppure nel Regno Unito, nonostante i significativi divari economici regionali. Si noti che in Spagna e Germania, i Länder e le Comunità autonome hanno notevole autonomia, anche finanziaria, e competenze in numerose materie. Ma sono previste efficaci forme di perequazione che assicurano un’uniformità dei servizi».
«Per esempio, in Spagna il Fondo di garanzia dei servizi pubblici fondamentali ha il fine di assicurare alle diverse Comunità le medesime risorse per abitante, con riguardo a servizi pubblici fondamentali come l’istruzione, la sanità e i servizi sociali essenziali. Il modello tedesco di federalismo è, invece, un modello cooperativo ben funzionante».
Ciò implica un calo nella qualità della vita.
«Esattamente. E invito a una riflessione: in altre nazioni europee avanzate, sarebbero tollerate le disuguaglianze nei servizi pubblici che caratterizzano l’Italia? Penso che le funzioni essenziali, soprattutto la Sanità, dovrebbero essere riaccentrate. In un paese disuguale, l’autonomia, a ogni livello, nella sanità come nella scuola, tende ad accrescere le disuguaglianze. E ciò anche per un’evidente differenza nel grado di efficienza delle Regioni nella gestione dei servizi pubblici: si pensi alla sanità in Calabria e in Emilia Romagna. Non è solo una questione di risorse, ma di capacità. In Calabria, la gestione dei servizi pubblici è stata spesso piegata a spicciole logiche politiche e clientelari».
».

Ma questo non cozza con la sua teoria? Se i nostri territori sono naturalmente depressi perché marginali, a che serve assicurare servizi che non avrebbero comunque ricadute economiche significative?
«Economia e politica sono interdipendenti. Quindi, ridurre il gap nei servizi significa anche rendere più appetibili i territori a livello economico. In ogni caso, lo Stato ha il dovere di assicurare uguali servizi in tutto il suo territorio e ciò, indipendentemente, dal livello di reddito dei cittadini».
Il Paese andrebbe davvero in pezzi se passasse l’autonomia differenziata?
«Non credo ci sarebbe alcuna secessione, neppure “mascherata”. Si esaspererebbero le disparità e i dislivelli, già notevoli. Ma l’Italia continuerebbe a esistere, coi problemi di sempre: un Sud sempre più ridotto a serbatoio di forza lavoro e un Nord produttivo».
La soluzione?
«Dubito che i meccanismi di perequazione per le regioni con minore capacità fiscale, siano in grado di garantire uniformità dei servizi con la realizzazione dell’autonomia differenziata. Non solo per una questione di risorse, ma anche per le differenze nelle capacità gestionali delle Regioni meridionali. Penso che le politiche nel campo della sanità, dell’istruzione e delle infrastrutture di collegamento dovrebbero essere centralizzate: se ne dovrebbe occupare lo Stato. Per il resto, ognuno faccia da sé. Ma questi servizi devono essere uguali dappertutto».

Secondo le teorie che ha aggiornato ed esposto in due libri diventati classici, il divario Nord-Sud non è l’effetto di patologie storiche ma è fisiologico. Cioè, è dovuto alla posizione geografica.
Q«ueste riflessioni hanno un precedente illustre nel grande economista cosentino Antonio Serra, che agli inizi del Seicento indicava chiaramente come la situazione territoriale del Regno di Napoli, una penisola nel centro del Mediterraneo, quindi lontana dai grandi traffici, fosse un oggettivo svantaggio. Attenzione: quando scriveva Serra il processo storico che avrebbe reso le rotte mediterranee secondarie rispetto a quelle atlantiche era ancora agli inizi. Purtroppo, i fatti continuano a dargli ragione».
Il Sud, quindi, non ha potuto o non è riuscito a svilupparsi?
«Il Nord è stato avvantaggiato dalla dimensione del suo mercato interno e dalla vicinanza ai grandi mercati del centro-Europa con cui si è economicamente integrato. Il Sud, distante oltre mille chilometri da quei mercati e a lungo penalizzato dalla carenza di infrastrutture, è rimasto periferico. La geografia non è stata l’unica causa, ma ha contato molto nel determinare il ritardo del Sud e, seppur meno che in passato, conta ancora».
Quanto c’è di vero nella tesi che il ritardo del Sud si debba a scelte politiche delle classi dirigenti settentrionali?
«È innegabile che l’industrializzazione del Nord, specie nella prima fase, sia stata sostenuta dall’azione statale. Il Sud, per lungo tempo, è stato trascurato. Il divario tra le due aree, inizialmente piccolo, è aumentato in tutta la prima metà del Novecento. Poiché il processo di sviluppo tende ad autoalimentarsi, quel divario, storicamente accumulatosi, non è stato più colmato».

E le classi dirigenti meridionali che colpe hanno?
«Hanno tante colpe, sebbene non tutte quelle che gli sono attribuite. C’è un dato fondamentale, evidente da almeno venti anni: le classi dirigenti meridionali hanno molto peso sul proprio territorio, sia perché sono mediatrici di risorse pubbliche sia per l’assenza di contropoteri sociali ed economici, ma sono modeste su scala nazionale e irrilevanti a livello europeo. E questo ha pesato, va da sé, anche per le autonomie differenziate».
Come?
«Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono state esaudite non appena hanno alzato la voce perché il Sud era sguarnito. Non c’è praticamente un leader meridionale di peso in grado di contrastare le tentazioni autonomiste».
Eppure, il partito maggioritario della coalizione di governo ha nel suo bagaglio culturale una tradizione nazionalista che dovrebbe contrastare certe spinte centrifughe.
«Se ci si riferisce a Fratelli d’Italia, sarei molto cauto: il partito di Giorgia Meloni ha preso il 26% su una percentuale di votanti pari al 64% degli elettori (percentuale molto più bassa al Sud). Quindi, siamo al 16% degli italiani. Ancora: Fdi ha riscosso molto più consenso nel Centronord che al Sud. E si consideri che i ministeri chiave, cioè Affari Regionali e Autonomie, Infrastrutture ed Economia, sono in mano alla Lega. Siamo sicuri che gli eredi della Fiamma Tricolore abbiano la forza e la determinazione necessarie per difendere le prerogative dello Stato e le esigenze del Sud?».


























































