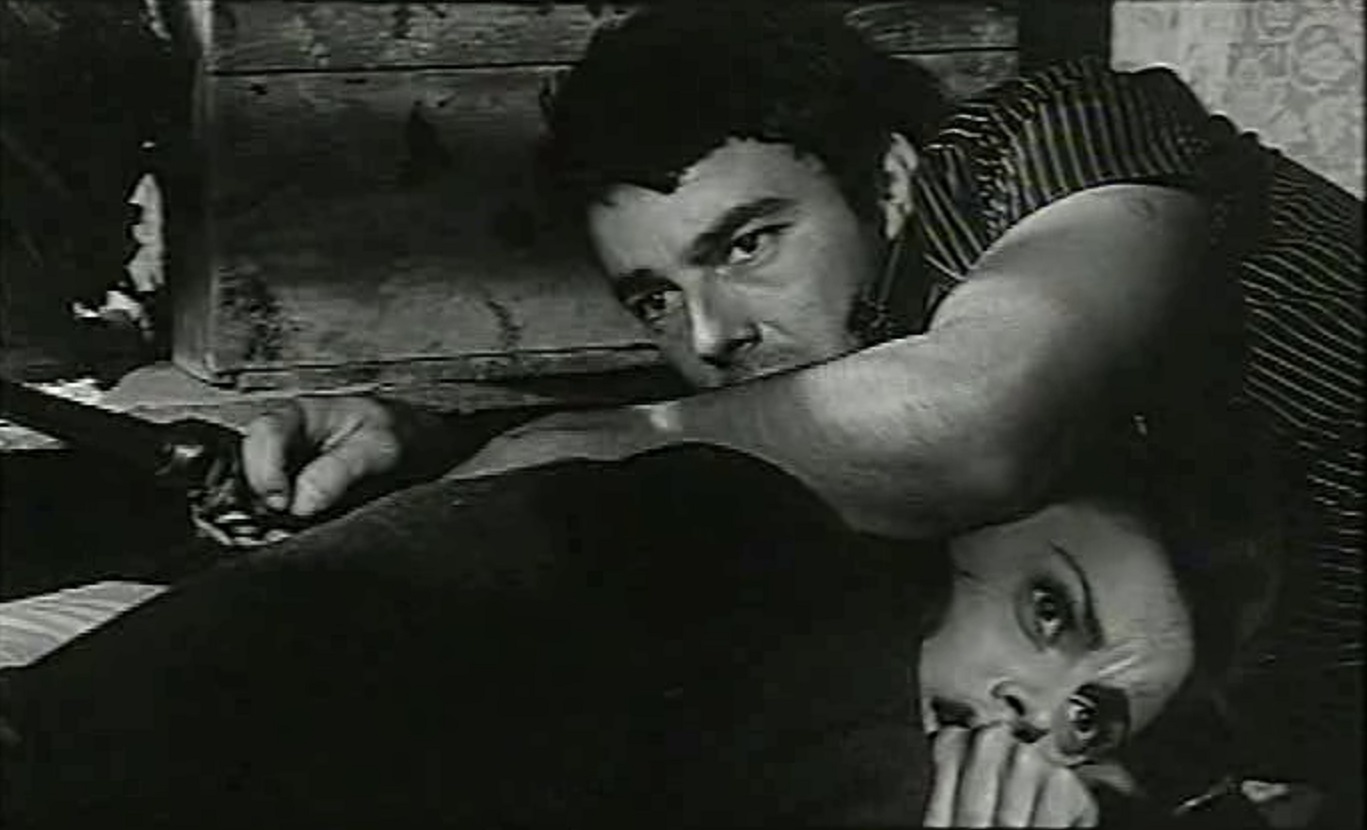Rende è commissariata. Ed è il caso di dire, senza troppi “forse”: finalmente.
E non perché si ritiene lo scioglimento per mafia una salvezza. Al contrario, la città del Campagnano subirà quel che di solito subiscono i Comuni in situazioni simili: la paralisi.
Tuttavia, lo scioglimento ha un pregio politico non proprio trascurabile: cala il sipario su un’esperienza amministrativa finita almeno da un anno, travolta dai problemi giudiziari personali dell’ex sindaco Marcello Manna e dalle inchieste, antimafia e non.
Le quali hanno colpito non solo i vertici politici, ma hanno danneggiato in profondità anche l’amministrazione.
I problemi non finiscono qui: Rende non è una città piccola né secondaria. E il suo scioglimento rischia di avere conseguenze oltre i confini municipali.
Ma andiamo con ordine.

Scioglimento di Rende: come vola la notizia
Il tam tam è iniziato dopo le 22 del 27 giugno: prima sono volati gli screenshot del sito del Ministero dell’Interno (o della Presidenza del Consiglio), via What’s App o social. A bomba, è arrivato qualche articolo, arronzato alla meno peggio o preimpostato come i “coccodrilli” più classici: segno che varie redazioni attendevano lo scioglimento.
In realtà, l’annuncio è stato meno spettacolare è più mesto: un comunicato del governo affogato tra varie note, dedicate agli argomenti più disparati, tra cui le nuove regole del Codice stradale, l’abolizione di normative ottocentesche e un altro commissariamento, stavolta a Castellamare di Stabia. Anche questo è un segno: fuori dalla Calabria, Rende è una cittadina che pesa solo i suoi 35mila abitanti. In Calabria, le cose vanno altrimenti: silenzi imbarazzati dai vertici regionali, dichiarazioni più o meno di circostanza. Più qualche posa giustizialista e l’annuncio, fatto da quel che resta dell’attuale ex amministrazione, di un ricorso al Tar.
Fin qui siamo negli atti dovuti e nelle ipotesi. Torniamo al presente.

Il collasso della città unica
C’è poco da essere garantisti sullo scioglimento per mafia. Questa procedura segue criteri di pubblica sicurezza, anche sganciati dagli esiti dei procedimenti giudiziari.
Un esempio lampante è il recente scioglimento per mafia di Amantea, operato in assenza di inchieste della magistratura. Rende, oggetto di inchieste tuttora in corso ma non concluse, non fa eccezione, anzi.
Finora hanno fatto tutti più o meno a gara a ricordare quell’autentico mostro, a metà tra il vespaio e il labirinto, che è Reset, l’operazione della Dda da cui è partito tutto.
E qualcun altro, anche correttamente, ha raccontato che questa non è la prima volta che Rende è finita nel mirino di una commissione d’accesso. Oltre dodici anni fa era toccato alla vecchia guardia riformista. Ma Rende aveva evitato il commissariamento e il vecchio nucleo dirigente, che pure aveva passato qualche guaio, è uscito finora intero dalle attenzioni della Dda.
Con Manna le cose cambiano: la città è sotto torchio e rischia di travolgere il processo politico-amministrativo predisposto dalla Regione, da cui dovrebbe nascere la Grande Cosenza. Vediamo come.

Ordinaria amministrazione
Sappiamo alcune cose. Innanzitutto, i nomi dei commissari che gestiranno Rende per i prossimi diciotto mesi: il prefetto a riposo Santi Gioffrè, la viceprefetta di Cosenza Rosa Correale e Michele Albertini, dirigente di seconda fascia della prefettura di Brindisi.
Questa terna avrà due compiti: certificare la presenza mafiosa nel Comune di Rende e quindi metterla in condizioni di non nuocere; gestire l’ordinaria amministrazione.
E qui casca l’asino.
Riavvolgiamo il nastro: il disegno di legge regionale da cui dovrebbe derivare la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero in un Comune unico, prevede due passaggi e un termine finale.
I passaggi, ricordiamo, sono: referendum consultivo tra i residenti delle tre città e gestione guidata da un commissario che dovrebbe portare la nuova città alle sue prime elezioni.
La deadline è prevista a febbraio 2025. In pratica alla scadenza più o meno secca dei diciotto mesi di commissariamento di Rende.
Andiamo di nuovo con ordine. Per il referendum consultivo, che dovrebbe tenersi a breve, non ci sarebbero troppi problemi: il voto sarebbe legato all’area urbana e non ai singoli municipi. Quindi la terna di commissari rendesi dovrebbe preoccuparsi, al massimo, dei seggi e della loro sicurezza.
Il problema è lo step successivo.

Scioglimento di Rende: mostri in arrivo
Si è già detto: nel secondo passaggio, un commissario dovrebbe guidare i sindaci di Cosenza, Rende e Castrolibero alle elezioni della nuova città, dopo aver fuso gli uffici dei tre Comuni ed elaborato le linee guida urbanistiche, finanziarie e politiche.
Per Cosenza e Castrolibero non ci sarebbero problemi perché, si scusi il bisticcio, ci sono i sindaci. Recalcitranti ma ci sono.
Per Rende c’è il problemone: i commissari antimafia potrebbero gestire l’autoscioglimento di un Comune in un ente più grande?
Quasi di sicuro no. Anzi, in tutto questo c’è una cosa certa: lo scioglimento totale di un Comune non è un atto di ordinaria amministrazione. Altrettanto sicuri sarebbero i mostri giuridici che uscirebbero da questa situazione.
Primo mostro: la coesistenza tra due commissari, quello della città unica e quello antimafia, che dovrebbe sciogliere del tutto un Comune “inquinato”.
Secondo mostro: la fusione tra un Comune sciolto per mafia, ancora in predissesto, e uno in dissesto spinto.

La tempesta perfetta
Si può far finta di non capire i problemi che nasceranno dall’attuale situazione di Rende e, quindi, si può andare avanti verso la città unica. Lo hanno fatto, ad esempio, alcune associazioni nel corso di un dibattito all’Unical.
Le opposizioni di Rende, nel frattempo, vanno alla carica e accusano Manna: lo scioglimento è colpa sua, recitano varie note stampa, perché non si è dimesso.
Su tutto, resta un rebus difficile da interpretare: lo scioglimento toglie dall’imbarazzo il Pd, che pure aveva sostenuto l’ex sindaco e forse riporta numeri nell’area riformista, che ha finora fatto opposizione in Consiglio comunale e si prepara a opporsi, praticamente da sola, al progetto di città unica.
Rende non è l’unica città importante di Cosenza ad aver subito il commissariamento per mafia: prima di lei è toccato (come già detto) ad Amantea. Ma anche a Cassano e, prima ancora a Corigliano Calabro.
Ma nessuno di questi centri ha il peso economico e culturale della città del Campagnano. Soprattutto, nessuno ha il suo ruolo geografico di tassello importante per la città unica. Che ora traballa vistosamente.
La tempesta è alle porte. E i primi lampi fanno capire che non sarà un acquazzone estivo: si annuncia perfetta.








 Questo articolo fa parte di un progetto socio-culturale finanziato dalla “Fondazione Attilio e Elena Giuliani ETS”. L’impegno de I Calabresi e della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani è quello di arare il terreno della memoria collettiva e trovare le radici da cui proveniamo per riscoprire la fierezza di una appartenenza.
Questo articolo fa parte di un progetto socio-culturale finanziato dalla “Fondazione Attilio e Elena Giuliani ETS”. L’impegno de I Calabresi e della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani è quello di arare il terreno della memoria collettiva e trovare le radici da cui proveniamo per riscoprire la fierezza di una appartenenza.