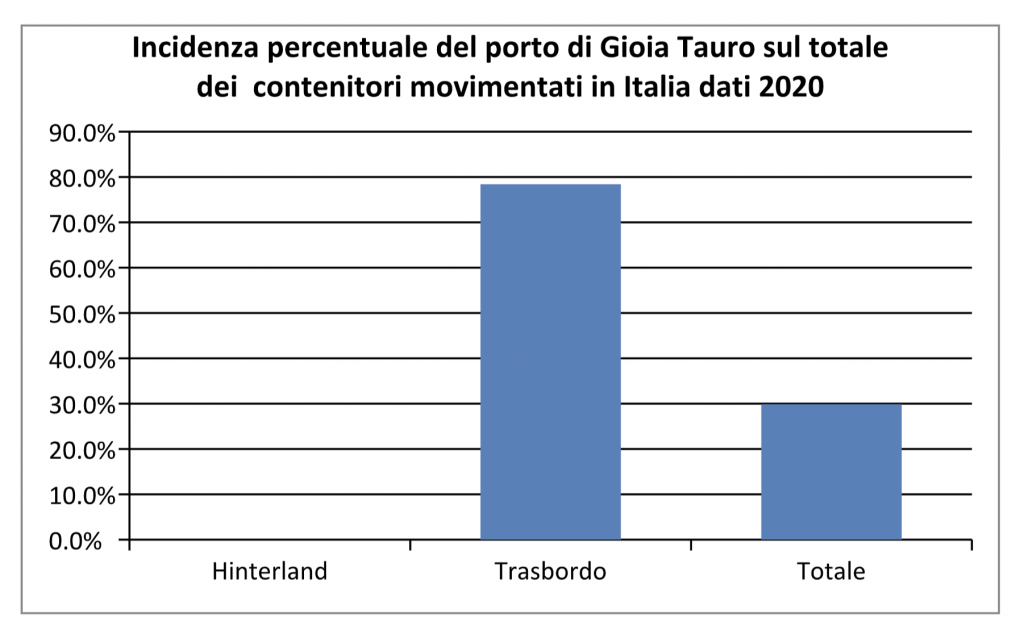Misurare le grandezze economiche e sociali per comprendere meglio il livello di sviluppo delle comunità è questione di crescente interesse nella comunità degli esperti e dei decisori. Il principale indicatore della crescita – il prodotto interno lordo – era stato introdotto a valle della Grande Crisi del 1929. Include tutti i tasselli del reddito prodotto, che però non necessariamente stabiliscono il grado di benessere delle popolazioni.
Dal Pil al Bes
Già nel 1968 Robert Kennedy affermava che «il nostro Pil comprende l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per liberare le autostrade dalle carneficine. Mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte e le carceri per le persone che le forzano…In breve misura qualsiasi cosa, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta». Il lavoro di analisi finalizzato a riformulare gli indicatori con cui leggiamo la struttura della società e dell’economia è partito nel 2009, proseguendo per un decennio. Ha portato formalizzare una nuova metrica dello sviluppo, basata sulla misurazione del benessere economico e sociale (Bes).
Anche l’Istat si adegua
Da qualche anno l’Istat ha cominciato a pubblicare l’andamento degli indicatori nazionali secondo i nuovi criteri di benessere a livello provinciale. Questa nuova chiave di lettura consente di leggere la dotazione di capitale sociale sotto numerosi profili. Tiene conto, infatti, di sanità, servizi sociali, pubblica istruzione, mercato del lavoro, competenze educative, efficienza delle pubbliche amministrazioni, diffusione della criminalità, ampiezza delle istituzioni culturali, qualità del territorio, energia proveniente dalle fonti rinnovabili, struttura della raccolta dei rifiuti, innovazione nei brevetti.
Qual è il posizionamento delle province della Calabria rispetto all’Italia ed al Mezzogiorno? La serie storica Istat mette anche a disposizione l’evoluzione degli indicatori dal 2004 al 2020. Noi ci limiteremo a fotografare l’istantanea dell’ultimo anno, rinviando ad una successiva occasione l’osservazione dei mutamenti che si sono determinati nel corso degli ultimi quindici anni.
Quanto viviamo
Partiamo dalla durata della vita, espressa come speranza di vita alla nascita, misurata in numero medio di anni. In Italia tale indicatore arriva ad 82 anni nel 2020, con un calo vistoso rispetto al 2019 (83,2), sostanzialmente per effetto della pandemia. Il Mezzogiorno registra 81,6 anni nel 2020, con un calo meno vistoso rispetto al 2019 (82,4), segno di una minore aggressività mortale della pandemia.
La Calabria registra nel 2020 una speranza di vita alla nascita pari allo stesso dato della media nazionale (82 anni), con un calo ancora meno vistoso rispetto al dato del 2019 nei confronti del valore nazionale e meridionale (82,4). Il miglior dato provinciale è quello di Catanzaro con 82,5 anni, mentre il peggiore è quello di Crotone con 81,1.
Infanzia: mortalità e servizi
Se però analizziamo il dato della mortalità infantile, espresso come numero per ogni 1.000 nati vivi, la forbice tra Italia e Mezzogiorno è più visibile, ed il risultato della Calabria è complessivamente più allarmante.
Il numero dei bimbi morti è pari a 2,9 nella media nazionale ed a 3,7 nel Sud. La Calabria registra un valore peggiore rispetto a quello meridionale, con un dato pari a 4. La peggiore performance tra le province calabresi è quella di Reggio Calabria con 4,9, mentre il dato più confortante è quello di Vibo Valentia con 2,4. Rispetto a Reggio Calabria fanno peggio in Italia solo Trapani (6,4), Enna (6), Avellino (5,6), Ragusa (5,1).
Servizi per l’infanzia
Passiamo ora alla percentuale di bambini che hanno usufruito di servizi per l’infanzia. In questo caso il differenziale tra Italia e Mezzogiorno è particolarmente robusto: mentre il valore nazionale è pari al 14,7%, nel Sud l’indicatore non arriva neanche alla metà (6,4%) e la distanza rispetto al Centro è abissale (21%).
In Calabria la situazione è disastrosa, con l’indicatore regionale che è pari al 3,1%. Solo Crotone si colloca sopra il valore della media meridionale (8,8%), mentre Vibo Valentia sta all’1,8% e Reggio Calabria arriva appena ad 1,9%, con una sola provincia in Italia che riesce a fare peggio rispetto alle due province calabresi: si tratta di Caserta (1%).
Diplomati e laureati
Se guardiamo alla percentuale della popolazione nella fascia di età 25-34 con almeno il diploma di scuola superiore, in Italia tale valore raggiunge il 62,9%, rispetto al 54,7% delle regioni meridionali. La Calabria si allinea sostanzialmente alla circoscrizione meridionale (54,9%), ma in una forbice di forte differenziazione a livello regionale, con un valore molto basso a Crotone (44,7%) ed un risultato molto più elevato a Cosenza (58,8%). L’unica provincia italiana che registra un valore peggiore per questo indicatore rispetto a quello di Crotone è Barletta-Andria-Trani (43,5%).
Se, nella stessa fascia di età, andiamo a misurare la percentuale dei laureati, la forbice tra Italia e Mezzogiorno torna ad allargarsi. Mentre l’intera nazione registra il 28,3% di laureati, il Sud si ferma al 22%.
La Calabria a livello regionale è in linea con il Mezzogiorno, con il 22,1%, ma anche in questo caso le differenze sono molto sensibili a livello provinciale: si passa dal massimo di Cosenza, con il 27,3%, al minimo di Crotone con il 14,6%, poco più della metà rispetto alla migliore performance calabrese. Solo Oristano, con il 13,7%, fa peggio di Crotone in Italia per questo indicatore.
Il primato dei Neet
I giovani che non lavorano e che non studiano (Neet) sono in Italia il 23,3%, ma arrivano a sfiorare un terzo nel Mezzogiorno (32,6%). In Calabria questo indicatore supera un terzo a livello regionale (34,6%), ed addirittura arriva a sfiorare la metà a Crotone (47,2%). Per questo indicatore Crotone registra la peggiore performance dell’intera nazione, un primato certamente poco invidiabile.
Le prove Invalsi
Nella competenza alfabetica non adeguata, misurata dalle prove Invalsi, l’Italia registra il 34,1%, indicatore già preoccupante in sé. Il Mezzogiorno sta al 43,4%: quasi uno su due dei giovani meridionali deve colmare competenze di base nella espressione e nella comprensione linguistica. La Calabria varca questa soglia già drammatica, ed arriva al 49%, quasi uno su due dei giovani meridionali deve colmare competenze di base nella espressione e nella comprensione linguistica. Crotone, ancora una volta, si spinge oltre, ed arriva al 56,9%, ancora una volta il peggiore indicatore a livello nazionale.
Nella competenza numerica, sempre misurata con i risultati delle prove Invalsi, la situazione è persino peggiore, per il Paese, per il Sud e per la Calabria.
In Italia il tasso di inadeguatezza numerica è pari al 39,2%, mentre nel Mezzogiorno si supera la metà: 53,4%. La Calabria a livello regionale arriva al 60,3%, con la punta avanzata nella solita Crotone al 65,9%, anche in questo caso con la peggiore performance nazionale.
I dati sul mercato del lavoro
Se misuriamo il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro, in Italia l’indicatore è pari al 19%, rispetto ad un Mezzogiorno che arriva ad un terzo della popolazione in età attiva (33,5%%). La Calabria si colloca su un valore regionale più elevato rispetto alla media meridionale (37,7%), ma con una forbice rilevante al suo interno tra il 33,5% di Cosenza ed il 48,7% di Crotone, ancora una volta in testa in questa poco invidiabile graduatoria.
L’occupazione giovanile
Il tasso di occupazione giovanile, nella fascia di età tra 15 e 29 anni, registra in Italia un valore pari al 29,8%, con il Mezzogiorno che arriva stentatamente ad un occupato per ogni cinque giovani (20,1%). In Calabria il valore regionale e poco inferiore alla media meridionale (19,6%), con una varianza interna provinciale molto marcata: si passa dal 23,2% di Cosenza al 12,6% di Vibo Valentia ed al 12,7% di Crotone.
Cosenza è la città con meno no profit in Calabria
Misuriamo infine la presenza sui territori delle organizzazioni no profit, espresse per ogni 10.000 abitanti: in Italia sono 50,7 mentre nel Mezzogiorno arrivano a 38,5. Questo indicatore esprime il capitale sociale diffuso e dedicato a specifiche finalità meritevoli di tutela e di impegno diretto da parte dei cittadini.
In Calabria il dato è leggermente più positivo del Mezzogiorno (40,6). Vibo Valentia registra il valore più elevato a livello regionale (45,1), seguita da Catanzaro (44). Ancora una volta è Cosenza ad essere fanalino di coda nella graduatoria regionale.
La popolazione esposta a rischio frane
Per verificare la qualità del territorio, analizziamo l’indicatore che esprime la percentuale di popolazione esposta al rischio di frane. In Italia questo valore è pari al 2,2%, mentre questa percentuale sale al 3,2% per le popolazioni meridionali. In Calabria questo dato schizza al 4,5%, con una punta del 6,2% a Catanzaro.
Nella raccolta differenziata dei rifiuti l’Italia ha raggiunto il 61,3%, contro poco più della metà nel Mezzogiorno (50,3%). La Calabria su scala regionale si colloca poco sotto (47,9%), ancora una volta con una forbice molto vistosa tra Cosenza (58,6%) e Crotone (30,8%).
Crotone prima in Calabria per servizi on line dei Comuni
Se si osserva la fornitura di servizi interamente on line da parte dei Comuni alle famiglie questo indicatore arriva al 25,1%. Un quarto delle amministrazioni comunali italiane si è attrezzato digitalmente. Questa percentuale scende al 15,6% nel Mezzogiorno.
In Calabria questa percentuale quasi si dimezza ancora (8,7%), con una punta più positiva nella provincia di Crotone (13,9%) ed un risultato più negativo nella provincia di Cosenza (6,4%), tra i peggiori a livello nazionale.
La Calabria delle differenze
Il quadro d’assieme che emerge dalla lettura degli indicatori di benessere economico e sociale relativo alla Calabria evidenzia due questioni strategiche che bisogna prendere in carico. Da un lato la condizione giovanile è in estremo disagio, sia sotto il profilo delle competenze sia sotto il profilo delle opportunità di lavoro. Dall’altro lato, nel disagio generale della Calabria, non esiste una realtà omogenea: per molto indicatori la forbice differenziale tra le province è molto elevata.
Occorre quindi comprendere innanzitutto che esistono diverse Calabrie, che viaggiano a velocità differente rispetto ad un disagio mediamente allineato a quello del Mezzogiorno. I tasti che le politiche pubbliche devono cogliere sono differenziati in funzione di questi divari interni.
Poi, senza politiche per la qualificazione delle competenze giovanili e senza la capacità di offrire una prospettiva alle nuove generazioni, la regione sarà destinata ad incartarsi su se stessa. E ad essere un territorio, se va bene, accogliente per i vecchi.