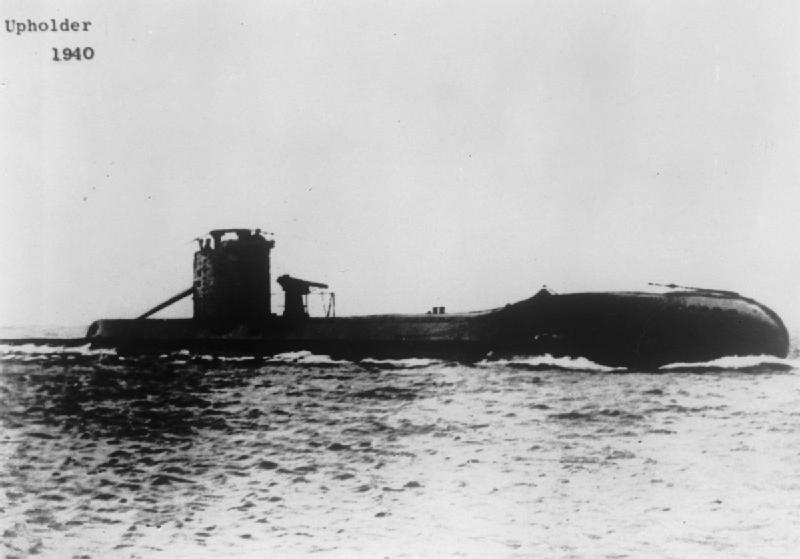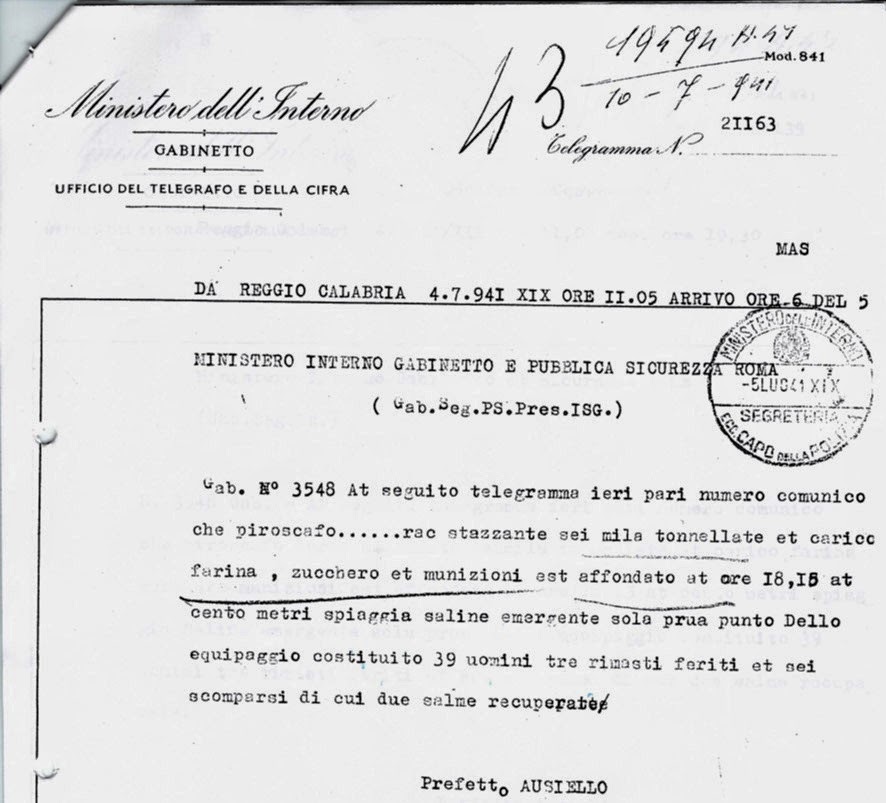Dalla base italiana di Camp Arena ad Herat, fino a Cosenza, scappando dall’illusione di una vita di pace che minacciava di diventare un inferno. Gholam Hossain e Amir Ali, sono due interpreti del contingente italiano in Afghanistan che hanno dovuto lasciare il loro Paese con le loro famiglie, racchiudendo in pochi bagagli i frammenti di una vita che speravano fosse diversa e che invece l’arrivo tumultuoso dei talebani avrebbe cancellato del tutto.
«Quando gli italiani si preparavano a smantellare la loro base, hanno chiesto a quanti in questi anni avevano collaborato con loro se volevano restare o andare via – racconta Amini – per noi non c’era scelta, dovevamo andare».
Tre motivi per scappare
I due sono hazari, sono sciiti e sono stati collaboratori degli occidentali, tre drammatiche ragioni per scappare, perché adesso esse corrispondono a tre condanne a morte. La loro esperienza con i militari italiani comincia 13 anni fa, quando il contingente di stanza ad Herat ha bisogno di interpreti e mediatori culturali. I due, che sono laureati in economia e in informatica, parlano bene l’inglese e hanno rapidamente imparato l’italiano, presentano il curriculum e vengono assunti.

Gli interpreti in giubbotto antiproiettile
«Le nostre giornate di lavoro cominciavano alle otto di mattina e si concludevano alle sedici», dice Gholam Hossain andando indietro con la memoria e spiegando che il loro compito era di seguire l’addestramento delle forze afghane e trasferire informazioni e ordini dagli italiani ai loro connazionali. Si trattava di mediare tra due mondi diversi e lontani, di spiegare abitudini e culture e di farlo non solo stando al sicuro dentro i confini della base italiana, ma spesso seguendo le truppe in altre aree che erano pure affidate alla gestione dei nostri soldati, ma che erano ad alto rischio.

«Tra i caduti ci sono stati anche molti interpreti, perché lì la guerra non è mai davvero finita e non fa la differenza tra combattenti e non», dice con voce ferma Amini, che era abituato a passare disinvoltamente dalle pratiche d’ufficio all’ indossare un giubbotto antiproiettile seguendo a bordo dei gipponi i militari che quando arrivavano presso qualche sperduto villaggio avevano bisogno di una guida.
Fratelli e genitori rimasti in Afghanistan
Ora sono qui, a migliaia di chilometri da dove sono sempre stati, con mogli e figli, ma senza fratelli e genitori, per i quali sono assai preoccupati e con l’amara certezza che laggiù non torneranno più. Su questo i due si fanno poche illusioni, hanno conosciuto i talebani e sanno che questi in Afghanistan resteranno a lungo. Hanno il cuore lacerato come chiunque sia stato, per qualche ragione, costretto a lasciare le proprie radici, «perché per la nostra cultura la famiglia è tutto, noi passiamo tutta la vita assieme», ma a questo dolore si aggiunge il peso di un sogno svanito. Perché loro ci avevano creduto in un progetto di pace e democrazia, perfino forse di prosperità, «ma è stato come aver tentato di costruire una casa per venti lunghi anni e poi farla distruggere in pochi giorni».
Restare in Afghanistan significava morire
Quando è stata prospettata la necessità di scegliere, per i due non c’è stato molto a cui pensare, la decisone era nelle cose: restare significava morire, perché a noi occidentali sembra che tutto si sia consumato in una manciata di giorni, ma evidentemente tra chi invece era sul campo, era già forte la certezza dell’arrivo inarrestabile dei talebani. «E’ stato difficile decidere, ma non c’era alternativa», dicono quasi assieme, come per darsi reciprocamente una ragione ineluttabile per l’essere fuggiti da un destino crudele. E come sempre è la nostalgia a segnare il loro tempo, forse più ancora delle difficoltà materiali di chi vive da esule. La loro mente resta sempre ancorata ai luoghi e ancor di più alle persone lasciate indietro, che sono oggettivamente a rischio.

La Kasbah a Cosenza provvede al loro sostentamento
Il governo italiano ha scelto la loro destinazione, disperdendo in varie località il piccolo gruppo di collaboratori afghani che avevano affiancato i militari italiani. Ora sono affidati alle cure dell’associazione La Kasbah, che provvede al loro sostentamento e che, tra le altre cose, in questi giorni dovrà anche risolvere il problema dell’iscrizione delle loro bambine presso una scuola cittadina.
Gli italiani avevano costruito scuole e ospedali
Ma i problemi dell’oggi, per quanto assillanti e urgenti, ancora non riescono a prevalere sui ricordi e sui rimpianti. «Gli italiani avevano fatto molto, scuole, ospedali, ora è tutto perduto», dice scuotendo la testa Amir Ali e pensando a quanti hanno perso la vita per quel progetto, «mentre i politici hanno rovinato tutto»
Nati e cresciuti in guerra
Il presente reclama un nuovo impegno e rinnovato coraggio, ripartire da zero, cercando presto, quando i documenti saranno a posto, un lavoro. «Vorremmo fare qualcosa legato alla nostra formazione, ma non ci facciamo illusioni», spiegano consapevoli della difficoltà della situazione, ma probabilmente per chi è venuto via da un luogo che non conosce la pace da oltre vent’anni, questo per adesso non è il problema più grande. I loro sforzi sono finalizzati alle loro famiglie, alle bambine in particolare, «perché noi siamo nati in guerra, siamo cresciuti in guerra e moriremo esuli», ma per i figli dovrà essere tutto diverso.