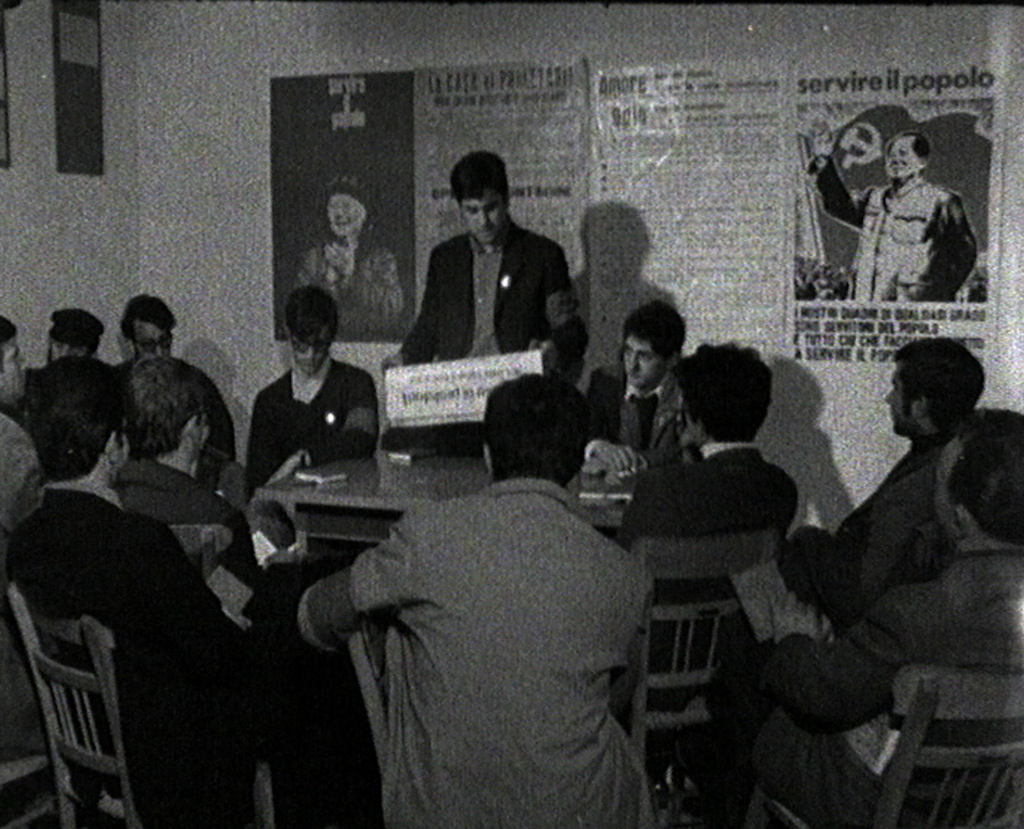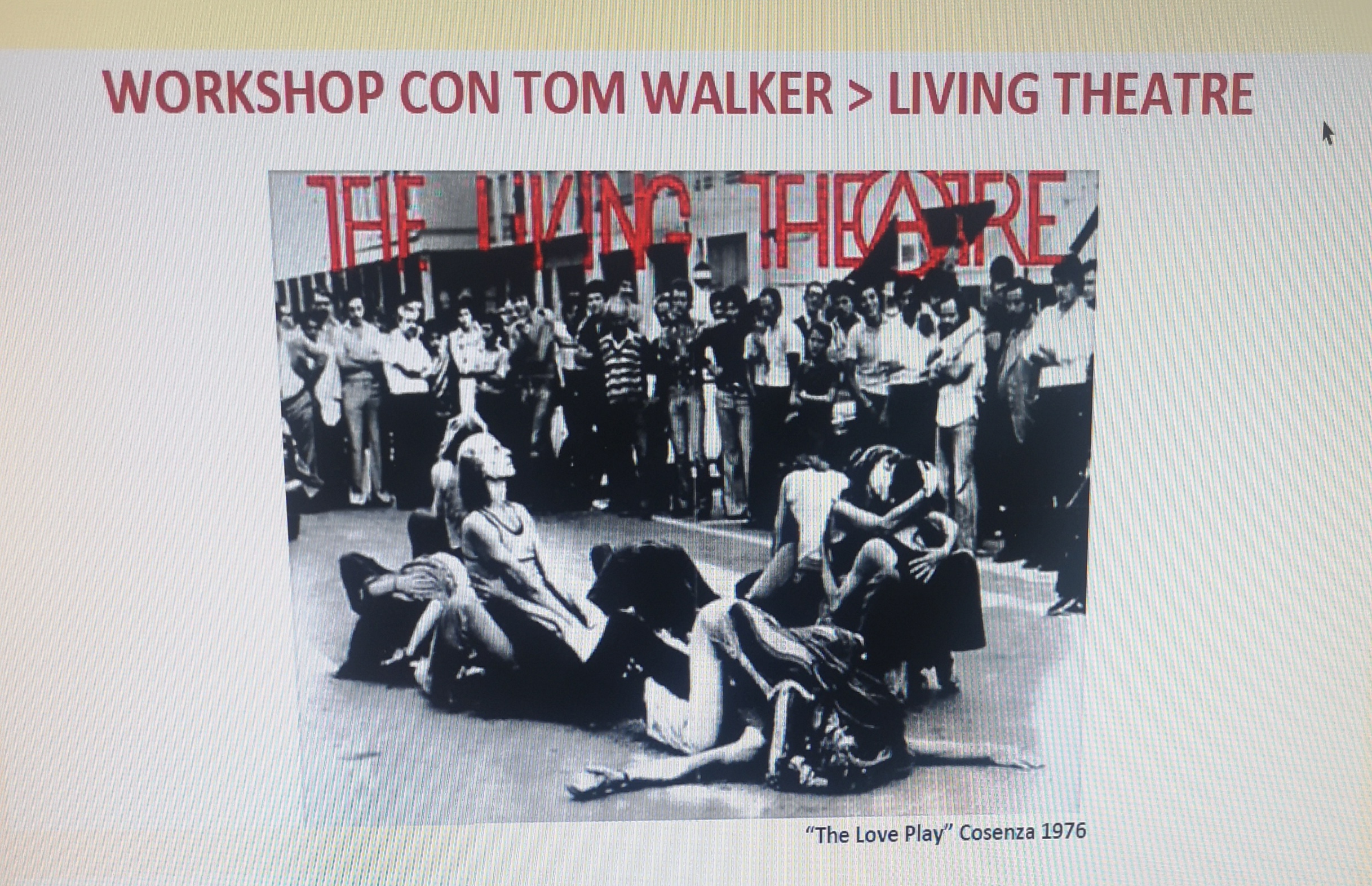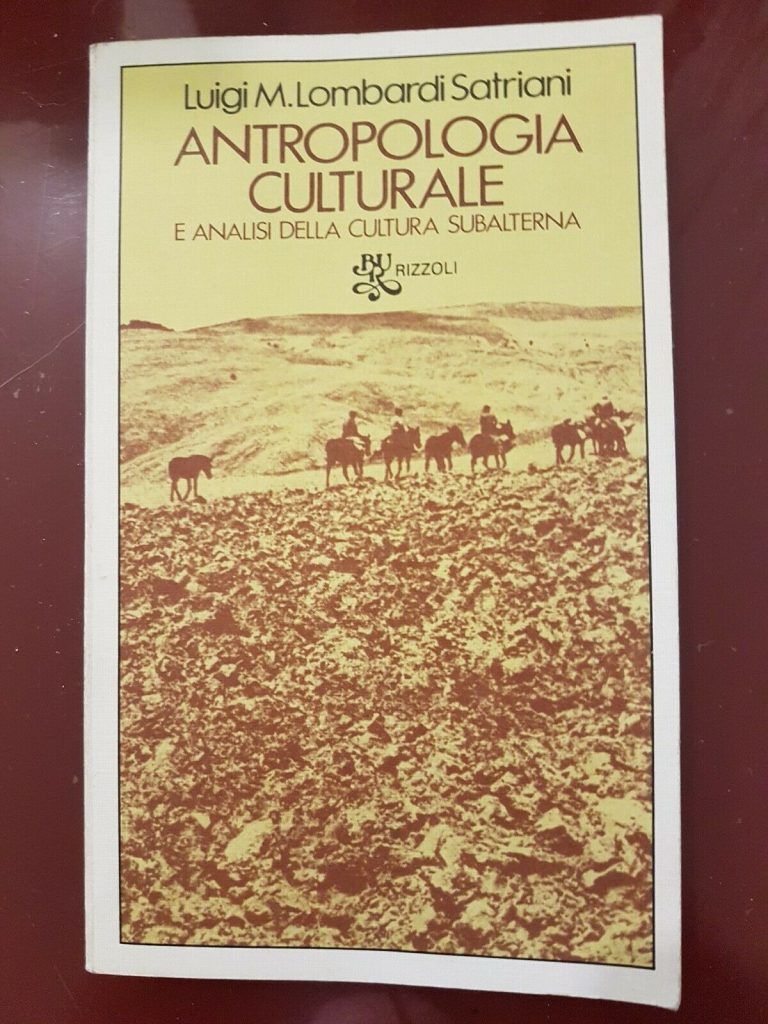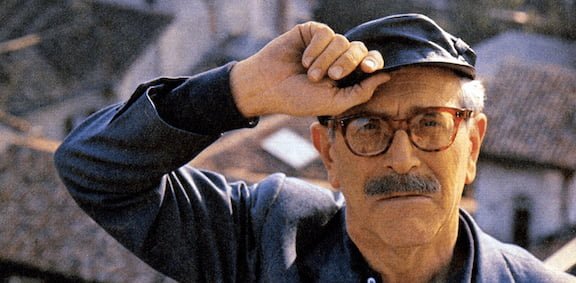[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
C’è chi in Calabria di questi tempi, nonostante spopolamento e crisi delle municipalità e dei piccoli centri, vorrebbe far nascere un nuovo comune. Riproponendo disinvoltamente a pretesto, tra mito e storia, favolose antichità da guida turistica e suggestioni archeologiche che coprono a stento, con una araldica foglia di fico, vecchi e nuovi campanilismi.
Succede ad Amantea, contrapposta alla frazione di Campora San Giovanni. Intenti secessionistici che la frazione avanza rispolverando una pretesa continuità «etnica» (sic!) con l’antico «popolo di Temesa», risalente niente poco di meno che alla fondazione dell’antica città italica, citata da Omero (Odissea, I, vv.180-184).
Calabria saudita
E parte da qui una spericolata rivendicazione secessionista, a colpi di etnicismi e illazioni identitarie. «Da fonti storiche e sulla base di ritrovamenti archeologici si desume che il territorio dell’attuale frazione Campora, compreso tra il fiume Oliva e il torrente Torbido è stato precedentemente territorio appartenente a Temesa. Dalle testimonianze rinvenute si può evincere, fino ai giorni nostri, la naturale e spontanea simbiosi degli abitanti dei luoghi interessati, che mette in evidenza anche sulla base degli eventi archeologici già ampiamente dettagliati, l’uniformità ad un unico territorio (Campora San Giovanni – Serra d’Aiello) che affonda le proprie storiche radici nella città e popolo di Temesa».

Si passa poi alle pretese del presunto «contesto linguistico, usi, costumi e tradizioni», che rincara la dose. «Il diverso aspetto socio-culturale viene ampiamente giustificato in quanto comprovato dall’esistenza della città di Temesa sull’attuale territorio di Campora San Giovanni e di Serra d’Aiello, che porta ad attribuire a entrambi gli abitanti dei due territori una comune discendenza riconducibile sotto il profilo etnico al popolo di Temesa. Stante ciò, è naturale spiegare come gli usi, i costumi e le tradizioni si identifichino in Campora San Giovanni e Serra d’Aiello: la diversa terminologia e la cadenza della lingua dialettale comunemente parlata dai Camporesi, è quasi identica a quella parlata dai Serresi e simile al dialetto parlato dai cittadini di Aiello Calabro. Palese è la netta diversità dal vernacolo amanteano che identifica innegabilmente la propria etnia, che a tutt’oggi fa risaltare l’influenza araba degli invasori».

All’influenza araba degli invasori non ho potuto trattenere le risate. Pure perché il testo citato tra virgolette non è la tesi abborracciata di qualche erudito locale. È il testo di un documento ufficiale della Regione Calabria a firma del consigliere Graziano.
Anche le frazioni nel loro piccolo si staccano
Date le premesse, non stupisce che la vicenda secessionista sia finta per adesso sulle carte bollate. Il nuovo comune che dovrebbe nascere dall’esito di un referendum, Temesa, sarebbe frutto dell’unione di Campora San Giovanni (popolosa frazione di Amantea) e Serra d’Aiello, un altro piccolo comune collinare del comprensorio, a danno del centro cittadino di Amantea. Quest’ultima, in caso di perdita della frazione di Campora e con la costituzione del nuovo comune limitrofo, scenderebbe sotto la soglia fatidica dei 10.000 abitanti. Per ora si tratta di un’ipotesi. Per avere la certezza dell’apertura dei seggi, serve attendere una pronuncia di legittimità del Consiglio di Stato, prevista per il 12 gennaio.
Prescindo ovviamente dal rilievo strettamente tecnico e politico-istituzionale della faccenda. Dal mio punto di vista, quello che rileva piuttosto da questa curiosa ed esemplare vicenda è un dato significativo antropologicamente paradossale. Ovvero che rivendicazioni autonomistiche che cavalcano gli istinti di restaurazione delle piccole patrie, come fenomeno collaterale del populismo sovranista dei nostri tempi, le aspirazioni che fomentano ormai ovunque secessioni e spinte autonomistiche sono ormai divenute moda anche dalle nostre parti. Anche nei paesi. Persino nelle frazioni.
Proprio laddove, invece, per contrastare spopolamento e crisi delle piccole comunità locali occorrerebbe mirare piuttosto a obiettivi contrari, come le unioni di comuni e il rafforzamento delle strategie di cooperazione e di rafforzamento dei servizi, alla crescita di movimenti civici e di cittadinanza attiva e consapevole necessari per contrastare il decadimento dei territori locali e per rafforzare la già fragile connessione tra piccoli centri, città secondarie e dimensione regionale-nazionale.
Amantexit
Il referendum scissionista tra Campora ed Amantea sembra riproporre su scala localissima una specie di derby paesano, fomentato da una sorta di populismo della porta accanto. In una realtà già falcidiata da fenomeni di crisi economica e sociale, da un forte declino delle rappresentanze istituzionali e della partecipazione democratica, ormai tipica dei piccoli comuni, una scissione in un centro medio-piccolo (Amantea arriva a stento a meno di 14mila abitanti), può rappresentare davvero una frattura traumatica nella storia e nella vita sociale di una intera comunità. Ci si chiede quale sia davvero la ratio – e la velleità culturalmente distintiva- che può spingere a separare definitivamente due entità insediative che in realtà sono e resteranno contigue e omogenee.
È una scelta che rischia di rivelarsi antistorica e avventurista. La separazione tra un comune e una frazione, Campora versus Amantea, potrebbe sommare così due debolezze senza creare davvero nessun punto di forza. E anche il tema retorico dello sviluppismo che differenzia, secondo i fautori del referendum scissionista, la realtà di Campora proiettata verso la crescita da quella di Amantea, cronicamente stagnante e in ritardo, affrontato e risolto a colpi di schermaglie burocratiche o con il ridisegno dei nuovi confini comunali a vantaggio dell’uno o dell’altro non farebbe certo avanzare di un passo i problemi di entrambi.
Fiato alle trombe
In certi aspetti la vicenda così come viene delineandosi tocca le punte tragicomiche di uno psicodramma familiare. Una disputa collettiva da strapaese. Alla rappresentazione mancano solo, per ora, un Don Camillo e un Peppone nostrano. Ma già pare di dover assistere a tratti a una questione di diplomazia da arbitrato internazionale Onu per ristabilire chi ha ragione e chi ha torto tra l’ex madrepatria di Amantiella ‘a terza e i neo-nazionalisti dell’ex-colonia rurale che nell’agro annovera i ricchi campi di cipolle (di Tropea) della Campora di San Giovanni.

Con indubbio sprezzo del ridicolo intanto volano parole grosse da una parte e dall’altra.
«I promotori della separazione si stanno assumendo la responsabilità di compromettere la crescita e l’ammodernamento dell’intero comprensorio del Sud Tirreno cosentino», tuonano esagerando non poco dal confine amanteano.
Rispondono minacciosi e risentiti i ricchi colonizzatori neo-civici appostati sulle sponde del fiume Oliva: «Distaccandosi da Amantea, i residenti di Campora San Giovanni vogliono porre le basi per un’aggregazione futura, che magari alla lunga riguarderà anche altri municipi. L’atteggiamento sprezzante registrato nel tempo ha favorito il processo in corso auspicato dalla maggior parte dei cittadini di Campora».
Mare e monti
A parere dei leader locali, nella disputa autonomista «si scontrano due culture diverse: una meravigliosa cultura marinara, quella di Amantea, e una, differente, di Campora. Questa frazione è passata da 500 a 3800 abitanti, espressioni delle aree collinari limitrofe come, ad esempio, Cleto e Serra d’Aiello».
A parte l’enfasi, già numeri del genere inviterebbero alla cautela. Preoccuperebbero un demografo e stuzzicherebbero le indagini di un sociologo o di un economista sensato. Invece bastano a rinfocolare polemiche e rivendicazioni secessioniste degne del nazionalismo post-colonialista e terzomondista. È tutto un trionfo della retorica delle origini, dell’autenticità, del senso civico e dei valori tradizionali ad alimentare contrapposizioni artificiose, che fanno a cazzotti con realtà minuscole e pretese comunque sproporzionate. Ma tant’è, ormai la battaglia autonomista divampa, anche a colpi di infiammati comunicati e polemiche incrociate tra le diverse fazioni in lotta.
Mattarella e Carosello per Temesa
C’è persino chi ha rivolto un appello al presidente Mattarella «affinché impedisca l’indizione del referendum circa l’aggregazione della frazione di Campora San Giovanni al Comune di Serra d’Aiello-NuovaTemesa».
«C’è da trasecolare!», afferma invece il Comitato Ritorno alle origini di Temesa (sic!), che dichiara con lessico vagamente neoborbonico remixato con riferimenti iconici da Carosello-anni ’60, che «Lorsignori, evidentemente, spendono il proprio miglior tempo sul pianeta Papalla altrimenti saprebbero che in Italia dal 27 dicembre del 1947 vige una Repubblica democratica che fonda la propria essenza su un ordinamento a base democratica che si regge su tre poteri separati tra di loro, quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Al dunque, ma i fatti sono noti, i Camporesi, attraverso un proprio Comitato, Ritorno alla origini di Temesa, hanno avviato un iter giuridico-amministrativo davanti alla Regione Calabria perché fosse riconosciuta questa storica e corale aspirazione, quella di separarsi dal Comune di Amantea in quanto – ormai è verità storica – lo stesso Comune, con colpevole, inadeguata, negligente e assente azione amministrativa ha da oltre quaranta anni ignorato le più elementari esigenze di una grossa comunità a dispetto di un dinamismo economico che avrebbe imposto le migliori attenzioni e il miglior impegno. Così non è stato. Evidenziando, nei fatti un atteggiamento sprezzante, arrogante quanto egoistico che dà ragione, in qualche misura, all’eterno pregiudizio di parte di molti amanteani nei confronti dei camporesi. Loro nobile borghesia, e i camporesi campagnoli».
Insomma, ci manca solo una dichiarazione di guerra.

Derby, indiani, eliporti
Incuriosito dalla polemica, nei giorni scorsi sono stato da quelle parti per un sopralluogo, per rendermi conto di persona. Alla fine del mio giro sulla SS 18, il nastro d’asfalto con vista mare che qui raccoglie e aspira come un sifone tutto quello che di antico, di vitale e di nuovo si muove intorno alla vita dislocata di questi paesi senza più un centro, ho pranzato in un ristorantino sul lungomare di Amantea. Il posto era frequentato per la pausa pranzo da un gruppo di persone. Prevalentemente bancari, tutta gente del luogo, ma già ben divisa tra tifosi amanteani e camporesi, anche se lavorano ogni giorno fianco a fianco in qualche banca o servizio finanziario locale. Il tono era accalorato ma conviviale. Volavano battute sarcastiche e sfottò pesanti. Il punto era naturalmente il prossimo referendum per l’autonomia.
Tra le tra le due opposte fazioni a tavola è venuto fuori di tutto: dal derby calcistico locale tra le due squadre che già si fronteggiano nel campionato di Promozione (dilettanti), agli 800 residenti indiani, braccianti occupati (come?) nei campi di cipolle, nell’agricoltura e nei servizi, ai numerosi altri immigrati e rifugiati trattenuti nei centri di assistenza o a spasso per le strade, agli appalti lucrosi previsti per la costruzione di grande piattaforma logistica di Conad. E persino di un eliporto da costruire: «Pe’ le Eolie? No, pe’ Iacucci, cussì piglia e porta!», e giù risate bipartisan (Franco Iacucci è il politico locale di lungo corso che molti indicano come artefice della scissione).

Archeologia e cipolle
Qualcuno poi azzarda che forse sarebbe meglio prenotare invece uno stand per la prossima borsa del turismo archeologico in cui “vendere” le attrattive del vicino sito archeologico di Temesa: «Seeh! Addu ce su le cepulle» E giù altre risate e battutacce. Intanto un tempio arcaico venuto alla luce nel territorio dell’antica Temesa, l’edificio sacro in località Imbelli di Campora San Giovanni, langue insieme ad un ricco antiquarium, chiuso da tempo.
Per ora restano solo pochi fatti a giustificare i toni di un secessionismo spinto, convinto unicamente dall’esaltazione paesana, da un campanilismo da condominio: il porticciolo turistico ubicato nello specchio d’acqua antistante la frazione di Campora, le più importanti infrastrutture turistiche collocate sulla fascia costiera di circa otto km che fa capo alla frazione, più alcune imprese all’interno dell’area ex Pip. E appunto le cipolle. Una discreta estensione di preziosi campi piantati a cipolla di Tropea, (il cui areale tipico si spinge fin qui).

Campi di cipolle praticamente ormai sovrapposti alle aree archeologiche di Cozzo Piano Grande e di Piano della Tirena, che qui fanno sempre più gola, costituendo la risorsa territoriale che fa reddito più di ogni altra cosa da queste parti. Tutti terreni collocati tra le aste fluviali del torrente Oliva (lo stesso degli interramenti dei rifiuti tossici e radioattivi della Jolly Rosso, su cui non è mai stata fatta piena luce) e del torrente Torbido; superfici molto ampie che quindi passerebbero integralmente in dote al nuovo comune, a danno di Amantea.
Temesa, una favola senza lieto fine?
Questo strambo, comico e strapaesano apologo locale calabrese mi riporta ad un saggio che lessi da studente. Un libro eretico che indagava sulle metamorfosi sociali e culturali registratesi in un villaggio francese della Bretagna, Plodemet, scritto da Edgar Morin alla fine degli anni ’60 del secolo scorso. Qui tra Campora ed Amantea, come nel villaggio francese studiato di Morin, esiste un carattere “plodemetano” che li accomuna. Molti si sentono reclutati per un progetto neo-identitario tanto fantasioso quanto ritenuto ambizioso e necessario. Ingaggiati in una sorta di antropologia elementare del noi e dell’altro tale da definire e promuovere un’umanità in transizione.

Una confusa favola allegorica della modernità alla calabrese che vede di fatto la fine dei paesi, che in questo caso paradossalmente coincide però con la moltiplicazione molecolare dell’ideologia del paese. Con il rischio che alla fine ne resti solo l’involucro vuoto, anche se c’è chi adesso la mette sulla lezione del passato, e accampa radici più antiche della storia, e perciò pretende il riconoscimento di primazie civiche e culturali. Con la pretesa ulteriore che il progresso debba venire solo dalla radicalizzazione delle presunte differenze invece che dalla loro armonizzazione, da una rifondazione artificiale, una sorta di riesumazione del passato, da un ritorno forzato e del tutto nominalistico alle origini.
Un altro referendum dopo Campora e Amantea
A me quindi la vicenda secessionista Campora Vs Amantea richiama il paradosso della fragilissima vulnerabilità e infondatezza della gran parte dei cosiddetti “discorsi identitari” nostrani. E se peraltro allarghiamo la scala delle questioni in campo, se guardiamo ai risibili e asfittici campanilismi, alle dispute ottocentesche tra province defraudate di questo a favore di quella che riempiono le cronache di questa regione dal Pollino allo Stretto, dal Tirreno allo Ionio, arrivati al 2023 resta la conferma sconsolante che la Calabria non sa ancora pensarsi come un’unica grande città-regione, con un suo posto dentro la realtà di un paese moderno ed europeo.
Se per ora ci sia da ridere o da piangere decidetelo voi calabresi. Magari con altro referendum.