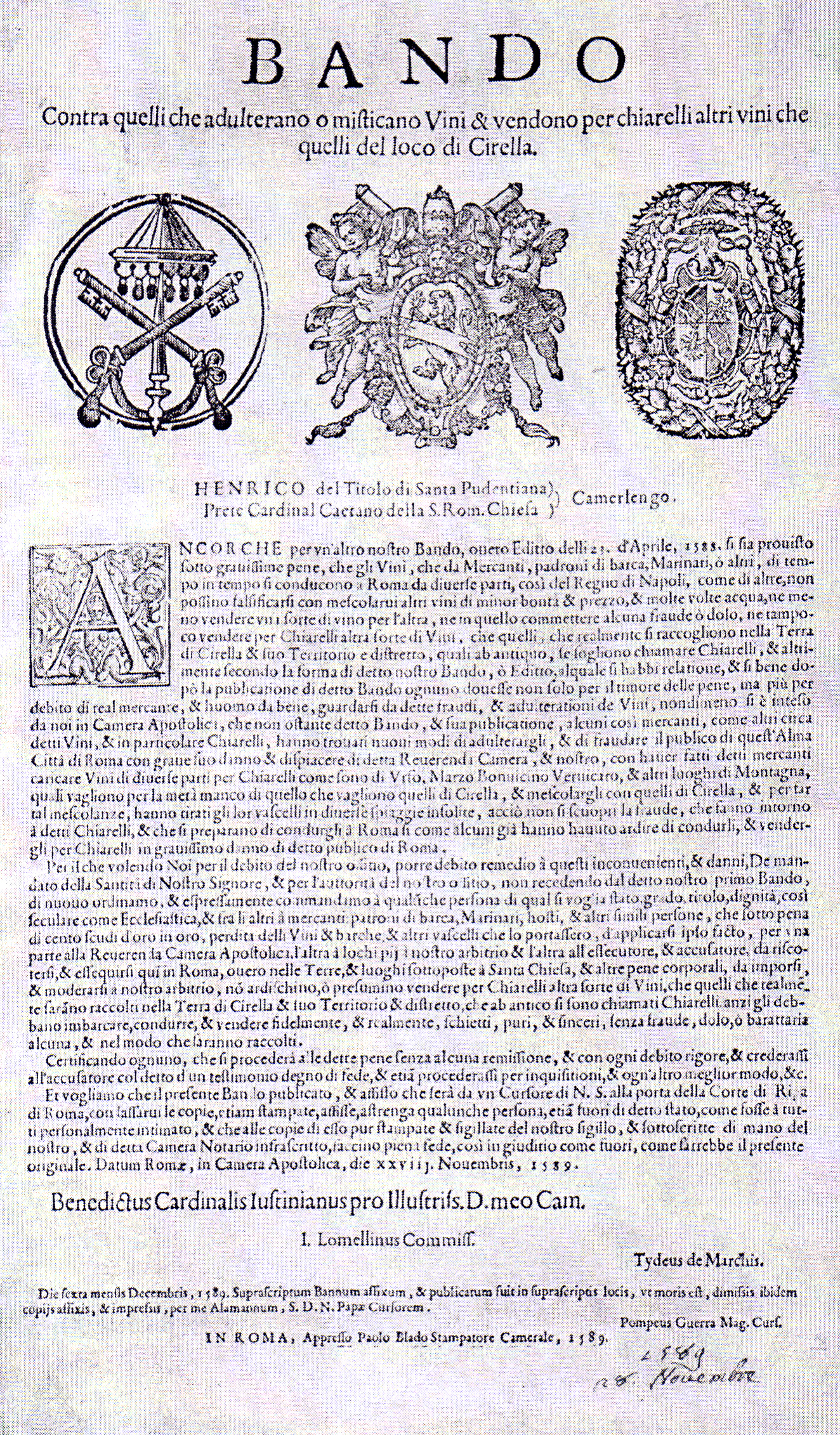[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Ci sono dei luoghi precisi che hanno il potere di evocare molto più di altri l’incalzare del tempo, l’abbandono speranzoso ma in fondo colpevole, e il rimpianto per un passato non necessariamente idilliaco ma certamente fatto di equilibri più naturali. Uno di questi è Campo del Monaco, a 200mt sul livello del mare, tra il burrone Marianna e il fosso Bambagia: non cercatelo su Google, non è quello che troverete. È un pendio, piuttosto ripido, affacciato sul mare e punteggiato non tanto da ruderi di edifici rurali modesti ma da resti di masserie padronali di ordine superiore, la cui magnificenza doveva splendere su queste colline fino a molto meno di cento anni fa.
Il bivio per Bonifati
Su queste colline si arriva facilmente, procedendo sulla SS 18 verso Nord e prendendo il penultimo bivio per Bonifati. Lo ripeto, appena si lascia una strada principale si fa cronologicamente un passo indietro: fuori da un’officina, subito infilato il bivio, un paio di anni fa faceva splendida mostra di sé una vecchia e gloriosa BMW 3.0 csi. Direte «che c’entra?». C’entra, perché se si parla di strade bisogna ogni tanto omaggiare anche chi le strade le batte, le copre e le setaccia materialmente. Omaggio per omaggio, due o tre tornanti più su, un muretto inneggia “Viva il giro”. Era il 2016, e il Giro d’Italia davvero passò faticosamente da qui.
Finocchietto, mare e monti
Di fianco, una masseria è stata ristrutturata recentemente, e per fortuna. Forse il nuovo colore non è troppo sobrio ma, considerato tutto il sole che la schiaffeggia, stingerà presto. Ancora un paio di tornanti e si passa tutt’intorno ad una casa-torre, quasi spaccata in due. Dietro di lei, un incomprensibile ponte sul nulla. Anzi, sul crinale: da un lato il suddetto burrone Marianna, dall’altro il suddetto fosso Bambagia (che è molto più “burrone” dell’altro, a dire il vero, e molto più inquietante). Per il resto, nulla: una distesa di finocchio selvatico (ottimo, se distillato…), un panorama a perdita d’occhio (da un lato il mare, fin dove visibilità permette; dall’altro i monti) e nient’altro. Però non è finita qui.

Un edificio straordinario
Da un’altra curva si può infilare un sentiero. Procede in piano e continua zigzagando, obbligato dalle rientranze della collina. È un sentiero lungo, e oggi senza apparente funzione. A destra e a sinistra è costeggiato da piccoli poderi, campicelli recintati, ma niente di che, e non una voce. Il fatto è che questo sentiero è l’unica via di accesso (“accesso” per modo di dire…) ad un edificio straordinario. Sto parlando di ciò che resta dell’ex convento di San Nicola: un palazzotto sventrato, con tanto di cappella d’ordinanza, loggiato angolare e finestroni baroccheggianti decorati a stucchi.
Il valore aggiunto di questo edificio, oltre a quello architettonico (e alla sua impenetrabilità dovuta all’essere circondato da rovi e vegetazione da foresta pluviale) è il fatto di essere anche scarsamente visibile. Il modo migliore per osservarlo è dalla spiaggia di Pietrabianca, con un buon binocolo o un teleobiettivo. O, al limite, procedendo ancora sui tornanti in salita, dall’unico incrocio che si trova appena più in alto (a destra per il centro storico, a sinistra per Aria delle Donne o Sangineto paese) ma da qui non si vedono gli scenografici finestroni sul mare.
Bonifati, terra di conventi (e satanisti)
Dalla spiaggia non va confuso con quell’altro edificio maestoso, un’altra masseria abbandonata, poco più a valle del convento, più o meno alle spalle dell’Hotel Sol Palace. L’ex convento di San Nicola è più imponente, più austero, più sofisticato nella struttura.
Terra di conventi rurali, questa di Bonifati, se a pochissimi km da qui spicca l’altro, quello di San Francesco, ristrutturato una ventina d’anni fa e convertito ad albergo di lusso (quantomeno lo si è sottratto all’uso che abitualmente si faceva dei suoi ruderi, ovvero quello di improvvisati ‘templi’ per attività sataniste).

Lunga vita a Bonifati
E va bene il miraggio dell’industrializzazione, e va bene l’emigrazione amaramente necessaria per tanti… però vale la pena immaginarli, questi luoghi, quando brulicavano di esseri viventi, uomini e bestie, di attività, di rumori, di voci, di versi d’animali. Sembra impossibile ma tutta un’economia e tutta una vera e propria ‘vita’ animava queste campagne che ora restano desolate e mute. Ha resistito una contrada, non lontana da qui, Cirimarco, sulla collina appena sopra Cittadella del Capo.
Parcheggio la macchina davanti all’unica chiesetta: mentre spengo il motore guardo davanti e l’occhio mi cade sui manifesti dei morti, le ‘mortaline’, come li chiamano da certe parti: 5 o 6 decessi recenti, ok. Ma tutti ultranovantenni. E ti credo: basta guardarsi intorno, e basta pensare al loro stile di vita (classe 1925 o giù di lì…) o alla loro alimentazione. Nota a margine: da qui si dipana una lunga mulattiera selciata, che scende dritta (no, dritta no) verso la marina di Cittadella, attraversando l’altra Contrada vicina, Greco: i Gradini San Vincenzo. Quindi mettiamoci anche l’esercizio fisico, quando i muli non fossero stati d’aiuto.

La costa delle torri
Da Cirimarco si arriva alle altre due frazioni provvidenzialmente sperdute nell’interno: San Candido e Pero. O, avendo coraggio, su una bretella che riporta all’ardimentosa e lunga dorsale che dalla frazione di Torrevecchia porta a Fagnano attraverso laghi e boschi abbastanza inaccessibili. Torrevecchia, appunto, detta così per la vecchia torre saracena d’avvistamento, costruita proprio lì sull’angolo del costone più ripido del promontorio sul mare: perché, non lo si può dimenticare, Bonifati è anche o forse soprattutto un luogo di mare e anzi, appunto, un Capo: quello spigolo che interrompe la continuità della costa da Capo Suvero a Capo Scalea. Non è un caso che qui si trovino altri relitti di torri o punti strategici (la torre del telegrafo, che ora dà il nome a una contrada; la torre di Capo Fella, la Torre Parise…).
Dei confini sul litorale bonifatese ho già detto parlando di Cavinia e di Sangineto.
Tutta la costa meridionale di Bonifati ha ancora i caratteri di quella cetrarese: strapiombi e grotte, insenature abbastanza incontaminate e non prese d’assalto dai turismi peggiori. Vi spuntano scogli, qua e là, che possono fungere da miniature di grandi isole, ottimi per progettarvi sopra altre strade che con minuscoli e arditi tornanti portino dalla base fino alle cime (un santuario? un mirador?).

Bonifati da cinema
Bando alla fantasia, qui non serve. Dopo aver percorso il breve tracciato della ex SS 18 in contrada Santa Maria, si possono ammirare tre edifici che svettano su questa parte di spiaggia: un ex casello ferroviario equilibrista sulla cima di uno scoglio; un casino padronale semiabbandonato sulla scogliera della Zaccarella (era una residenza minore dei nobili De Aloe) dove Mimmo Calopresti ha girato alcune scene di uno dei suoi film (non il migliore, va detto: L’abbuffata); e poi il principale dei palazzi De Aloe, ovvero l’attuale albergo del Palazzo Ducale.
Resto dell’idea che però il meglio stia nella parte più nascosta e meno battuta, ovvero lungo quelle due stradine parallele che costeggiano la ferrovia da qui in poi, verso Nord: via Magellano e via Amerigo Vespucci raccolgono la parte forse più amena e riservata di buona parte della costa, benché poste immediatamente sotto la Stazione ferroviaria di Capo Bonifati. E segnano anche uno spartiacque: da qui in poi, solo ed esclusivamente spiaggia, spiaggia, spiaggia, sotto lo sguardo magnanimo della cinquecentesca Torre Parise.