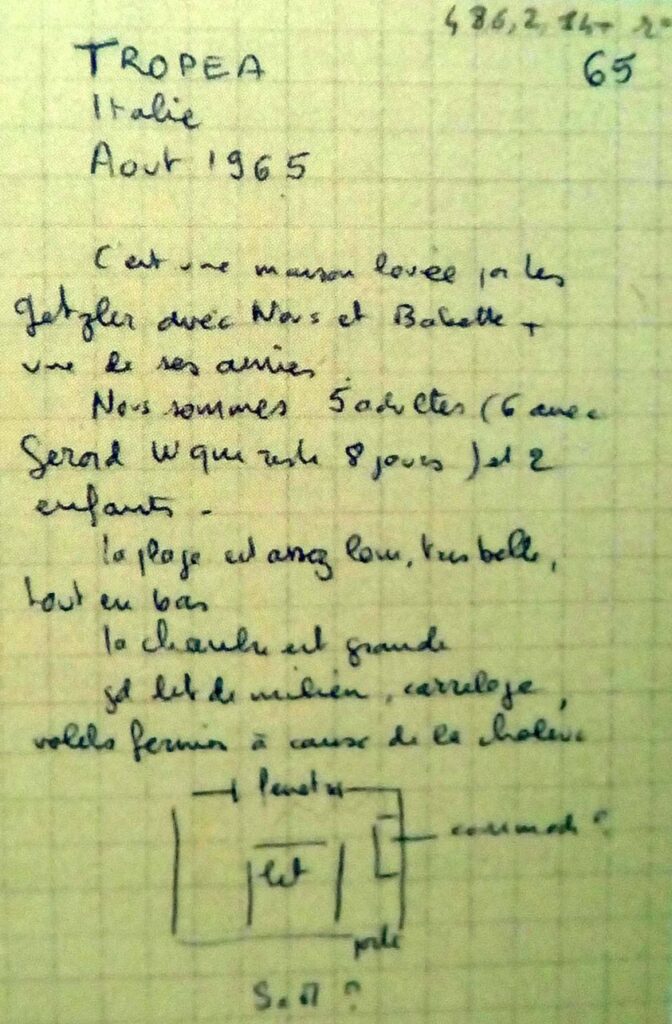[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]
Con Dante Maffia ci siamo incontrati poco e di sfuggita. Una volta a Firenze, un’altra volta – fuori dal tempo e da ogni logica razionale – per caso a Laino Castello, deserta in un pomeriggio d’agosto, e un paio di volte nella “nostra” Roseto Capo Spulico. Ma basta leggere la voce di Wikipedia che lo riguarda per rimanere increduli davanti alla quantità di pubblicazioni e di riconoscimenti internazionali alla sua attività di poeta, narratore e saggista.
L’impressione è che tu sia più conosciuto fuori che dentro dalla Calabria: quanto ritieni sonnolenta la regione, in termini di fruizione della cultura?
«Su Wikipedia non c’è tutta la mia attività, non mi sono preoccupato di fornire le notizie. A me interessa fare, prendere piacere e interesse a fare, con assiduità, con attenzione e cura perché provo gioia se riesco a realizzare dei versi belli, delle pagine interessanti che potrebbero (!) aiutare la conoscenza e la consapevolezza. Per il resto non mi preoccupo di promuovermi. Ho tanti difetti, tranne la vanità, e ciò non giova per occupare un posto preminente sui giornali e nelle televisioni. Ma io sono all’antica. Ho sempre creduto e credo che la poesia, la letteratura in genere, non siano notizia e dunque possono aspettare il loro turno per farsi vive e dire la loro. Sono uno stupido illuso, lo so, ma va bene così. Non mi sono aspettato mai niente dai miei libri. Perché li scrivo e li pubblico? Per molte ragioni, ma soprattutto perché dentro pongo messaggi che avranno senso in futuro. La poesia, quella vera, quella che nasce dal cuore, dall’anima, dalla cultura e dall’esperienza in un amalgama distillato in cerca della verità, non ha tempo, vive nella perennità.
La Calabria mi ha sempre riconosciuto e mi ha dato molta attenzione, a cominciare dalla candidatura al Premio Nobel proposta all’unanimità dal Consiglio Regionale, dalle cittadinanze onorarie ricevute da Reggio Calabria, Girifalco, Trebisacce, Amendolara, Rocca Imperiale, Cassano Jonio… e infine da un convegno, con 47 interventi dalle Università di tutta Italia. Ma il problema Calabria è troppo complesso, prima perché si tratta di Calabrie, di molte Calabrie. Con vocazioni e intenti diversi, con storie diverse, con eredità che non sempre sono state smaltite per bene. Poi perché gli eventi si ripetono: Milano, in particolare, esercita una sorta di razzismo silenzioso ma efficace nei confronti di tutto ciò che non sia fatto di nebbia e di danaro. Lo so, è un luogo comune trito e ritrito, ma io ne ho subito molte dure conseguenze».
Quali soluzioni individui?
«Ce ne sarebbe una sola. Ritornare a due Italie, due gestioni autonome politiche, sociali ed economiche. Io maledico sempre le azioni di Garibaldi, il suo tradimento di Mazzini. E mi ricordo che Umberto Zanotti Bianco da qualche parte ha scritto che la Calabria, bellezza a parte, potrebbe essere la regione d’Europa più ricca: 900 chilometri di costa – e che costa! -, tre montagne, Aspromonte, Sila e Pollino, e il parco archeologico più grande del continente: Sibari».
Beh, se Zanotti potesse vedere le coste allo stato attuale… Ma andiamo avanti: hai esordito a 18 anni, nel 1964, con “È più bella la notte”, poi a 21 anni hai pubblicato “Lo straccivendolo di Eros”, ormai introvabili tutti e due. Sapevi che il secondo è conservato soltanto in due delle migliaia di biblioteche pubbliche italiane? E il primo, addirittura, in nessuna?

«In realtà ho esordito a 14 anni con un volumetto intitolato I canti dello Jonio e da quello addirittura ho recuperato una poesia che ancora ritengo valida: “Vado la sera / di casa in casa / ad ascoltare le fiabe / che mi raccontano i vecchi al focolare / come un mendico / che ha bisogno d’un pezzo di pane…”.
L’ho preso in mano proprio ora, per controllare, e la meraviglia è che ci sono brevi poesie che sembrano haiku, quegli haiku che mi hanno portato in Giappone, dove sono stati tradotti 22 miei volumi. A gennaio, a Kyoto, ci sarà la prima edizione del Premio Dante Maffia. Proprio “Premio Dante Maffia”, nonostante che, almeno sembra, ancora io sia vivo. Una storia lunga. Annoieremmo i lettori».
Poi, a 28 anni, hai pubblicato “Il leone non mangia l’erba” e a scriverne la prefazione fu nientemeno Palazzeschi. Vi furono gli apprezzamenti da parte di una componente importante della cultura italiana dell’epoca: da Sciascia a Natalia Ginzburg e Mario Luzi, da Caproni a Giacinto Spagnoletti. Cosa ricordi di te ventottenne, o giù di lì, circondato dalle attenzioni di questi nomi? Com’era quell’ambiente letterario?
Con Il leone non mangia l’erba mi resi conto che le mie emozioni non erano dettate da velleità, ma da una profonda necessità di dialogare con l’Universo, con il Mistero, con il Lievito della vita, con la Morte. Quindi vedere alla Libreria Croce addirittura personaggi come Sciascia, Luzi, venuto da Firenze, Spagnoletti, Caproni, Palazzeschi, Moravia, Bellezza e altri… mi sembrò un fatto naturale. Ma allora ancora esisteva il mondo letterario che badava alla qualità dei testi e non agli inciuci. Allora si leggeva, non si appariva soltanto. E infatti, senza appoggi, senza referenze, se non quelle del mio entusiasmo e della mia cultura, fui chiamato a collaborare al quotidiano Paese Sera, al settimanale La Fiera Letteraria e alla rubrica dei libri Rai 2. Ognuno aveva il suo compito e si collaborava».

Anche il poeta Giuseppe Pedota scrisse di questa tua presentazione alla Libreria Croce, presenti – oltre ai suddetti – molti altri nomi celebri tra cui Giovanna Bemporad, Attilio Bertolucci e Leonida Repaci. «Un avvenimento – scrisse – che riempì la cronaca dei giornali. Come aveva fatto questo ragazzo venuto dal nulla, da un paesino sperduto della Calabria, a far confluire il gotha della letteratura romana alla presentazione del suo libro? Mistero». Oggi, questo “mistero” come puoi scioglierlo?
«Era normale partecipare alle presentazioni dei libri. Non se ne facevano a bizzeffe, non si portavano in cattedra dilettanti, ruffiani e belle bambole. Si seguivano le novità. E se nasceva un poeta bravo, se esordiva un narratore valido si consentiva, si battevano le mani. Non si spianavano i fucili per dare spazio alla mediocrità o al comparuccio.
Repaci mi abbracciò come rinascita della Calabria, che contraddiceva quello che una volta Jorge Luis Borges mi raccomandò: “Non dire mai che sei nato al Sud, dici che sei figlio di norvegesi o di londinesi e vedrai come il mondo cambia”».

E invece tu hai scritto molto anche in vernacolo (quello dell’area Lausberg), indice di un legame forte, ma non totalizzante, con la tua terra d’origine. L’Italia è ancora pervasa da razzismi interni inespugnabili, figuriamoci quanto poteva esserlo all’epoca del tuo esordio. Quanto costava allora, in quell’ambiente, in quel settore culturale, avere una provenienza meridionale?
«Quanto costava allora avere una provenienza meridionale? Devi dire quanto costa. Un solo esempio: se scorri le collane ufficiali che pubblicano poesia potrai renderti conto di quanta immondizia, non saprei come diversamente chiamarla, ci viene offerta e quasi tutta dalla stessa area o da chi ha adottato quell’area. Siamo allo sfascio. Certo, i danni del Gruppo 63 ancora sono visibili e la stupidità dei giocolieri ancora ha dei rigurgiti. Ma peggio hanno fatto i nominalisti, o come diavolo si chiamano, confondendo la poesia con la lista della spesa.

La brutta verità è che ormai nessuno legge. E allora mi domando perché ci sono primari di medicina, giudici, avvocati e dirigenti d’aziende e professoroni d’ogni genere che pretendono di fare i poeti. È forse una raccomandazione del loro medico per uscire dal tunnel dell’insipienza? E senza mai leggere i classici? Lo sai che cosa mi ha detto un personaggio televisivo sempre in bella mostra? Lui scrive poesie ma, per carità, non ne legge mai per non essere influenzato. Quindi: “È spuntato il sole e illumina la spiaggia; ti voglio bene amore mio; ai lati del viale ci sono gli alberi”… L’ovvietà più assoluta, il non dire, o la retorica nata dai ricordi carducciani e leopardiani, a proposito di influenze!
Con un mio libro pubblicato con lo pseudonimo Maria Marchesi, e scrivendo che la poetessa è nata al Nord, ho vinto il Premio Viareggio. Per anni non ero mai stato preso in considerazione con la firma Dante Maffia».
Tra i tuoi volumi in vernacolo il mio preferito è senz’altro “U ddìje poverìlle”. Enzo Siciliano ti ha paragonato a Scotellaro (che secondo me poco ci azzecca). E se qualcuno ti paragonasse – negli episodi vernacolari – ad Albino Pierro?
«Enzo Siciliano ha buttato quel nome, credo, a caso. Con Scotellaro non credo di avere nessuna parentela. Ma se qualcuno mi apparentasse ad Albino Pierro mi sentirei offeso. Pierro non ha scritto mai poesia che tale possa dirsi, ha composto in dialetto perché aveva intuito che era il momento giusto per essere presi in considerazione. Basti leggere i suoi versi in italiano, davvero mediocri, più spesso banali. S’infatuò, cominciò a credere che fosse la lingua a fare la poesia e non la poesia a fare la lingua. E poi, quando i filologi come Contini e altri se ne occuparono, finì per credere che fosse un grande poeta e cominciò a pretendere il Nobel. No, Pierro no: io sono un poeta e lui era un letterato. Attenti alle mitologie create da situazioni festaiole o politiche o d’altro genere».
Restiamo ancora al Sud, e possibilmente in Calabria. Tempo fa mi dicevi che sei stato amico pure dell’assai poco celebre Enrico Panunzio, pugliese temporaneamente naturalizzato parigino, scrittore sopraffino e però – o forse perciò – incompreso. So che assieme a Dario Bellezza frequentava d’estate Rocca Imperiale: c’eri anche tu, con loro, lì a due passi da Roseto? Mi racconti un paio d’aneddoti inediti sulle vostre chiacchierate?
«Enrico Panunzio era uomo colto e intelligente, ma noioso e ripetitivo e, forse perché non aveva ottenuto ciò che meritava, si era eretto a giudice supremo con la falce in pugno. Non gli andava bene niente e ricordo che Spagnoletti, con cui era molto amico, spesso lo redarguiva. Parlava sempre della Francia. Era comico vedere che cosa faceva ogni giorno per farsi offrire il caffè. Era la tirchieria all’estrema potenza. Dario Bellezza e io, scialacquatori senza quattrini, ci divertivamo a prenderlo in giro, ma lui non batteva ciglio. Le nostre chiacchierate erano a ruota libera, io mangiavo troppi libri e spesso li disorientavo. Enrico parlava sempre di Camus e Dario lo chiamava “il riflesso della peste”».

Mi pare che l’editoria italiana fino alla fine degli anni ’70 sia riuscita a conservare, almeno in parte, un’anima attenta alla qualità del prodotto. Sei d’accordo sul fatto che un certo spirito virtuoso sia venuto meno negli anni? E, secondo te, si può intravedere un destino editoriale meno suicidario in termini qualitativi?
«Sono pessimista in proposito. E sono anche molto disorientato. Vedo un profluvio di libri, editi dalle sigle editoriali così dette prestigiose, che non hanno né testa né coda, che non dicono, subito spenti, inutili e obsoleti, privi di tutto. La domanda è perché vengono pubblicati. Anche mezzo secolo fa ogni tanto si faceva un favore e si pubblicava qualche cicoria, ma era evidente che si trattasse di un compromesso necessario all’editore. Adesso credo che sia ignoranza e affidamento totale alla possibilità eventuale che funzioni la vendita. Un disastro, culturalmente parlando. Un disastro al quale non riusciremo più a sottrarci, perché i lettori rimasti saranno man mano abituati alla mediocrità.
Nello specifico, in Calabria pare manchino quasi del tutto figure intellettuali di riferimento. Peggio: che vi siano fin troppi sedicenti intellettuali e finti tali. Non ne nascono più? Nascono e non attecchiscono? Scappano? E la situazione editoriale calabrese?
«Non mancano, anzi… Ma sono altrove, sono fuori e lontani dalla Calabria e dai problemi che la investono. Quindi scappano e, man mano, le radici seccano. La situazione editoriale calabrese non è male, ma le case editrici sono penalizzate perché non vengono distribuite per il solito motivo. Meno concorrenza c’è, meglio è. Il confronto fa male a molti, soprattutto ai poveri di spirito».
Ti hanno apprezzato Pasolini, Calvino, Montale, Eco, Amado, Bobbio, De Mauro, Bufalino, Zanzotto, Praz, Dacia Maraini, Gina Lagorio. In Italia hai fondato riviste, a Palazzo Chigi sei stato insignito del Premio Matteotti per la letteratura Italiana. Ciampi – all’epoca Presidente della Repubblica – ti ha insignito della Medaglia d’oro alla Cultura. Sei stato candidato al Nobel. All’estero sei stato tradotto in 35 lingue. Due domande in proposito, una sopportabile: in quale Paese straniero hai ricevuto l’accoglienza critica più elaborata, articolata? E l’altra un po’ meno: poesia e politica… qual è il tuo parere sulla polemica di qualche anno fa in merito alla questione “con l’arte non si mangia”?
«Soprattutto in Giappone, ma anche in Romania, dove sono stato tradotto più volte e sono membro effettivo della loro Accademia Eminescu. Ma forse anche in Albania, dove mi hanno dato il maggiore riconoscimento da loro elargito, il Premio Madre Teresa di Calcutta. E poi in Russia, in Ungheria, in Spagna… Devo dare ragione a Vittorio Introcaso, un giornalista televisivo che mi segue da sempre: gli stranieri mi amano di più. O almeno fanno di tutto per farmi sentire importante.
Con l’arte non si mangia? È vero e non è vero. C’è perfino chi s’abbuffa o chi, come me, mangia indirettamente con qualche incarico e qualche riconoscimento».
Hai presieduto numerosi concorsi letterari, te ne saranno capitate molte. Tempo fa, Erri De Luca pubblicava un minuscolo libro dal titolo “Tentativi di scoraggiamento (a darsi alla scrittura)”. Perché, secondo te, si può trovare più dilettantismo nella poesia che nella narrativa? Come si può far capire ai tanti, troppi sedicenti poeti che non basta spezzettare una frasetta e infiocchettarla con un paio di termini struggenti (secondo loro…) per farne un componimento poetico? O che prima di esprimersi bisognerebbe avere davvero qualcosa (possibilmente non troppo banale) da esprimere ?
«A me Erri De Luca non è mai piaciuto, sempre per il solito problema. Vanno bene gli esercizi di stile, ma la narrazione è altra cosa, e non ti dico la poesia. Il dilettantismo è dilagante sia in prosa che in poesia. Con una differenza sostanziale: in poesia il disastro viene subito messo da parte o, se si tratta di personaggi importanti, si fa finta, si apparecchia l’ipocrisia e s’infarina; in narrativa, però, può accadere che un romanzo sbagliato, banale, non riuscito in nulla possa trovare l’interesse di un regista e diventare film.
E il ballo della mediocrità continua e si allarga. Io vedo che siamo quasi sull’orlo del dirupo. La faccenda non finirà mai, tanto è vero che i cartellonisti, i pubblicitari ormai vengono chiamati pittori e i parolieri e i cantautori poeti. Il vocabolario si sta appiattendo, spero che non finiremo di servirci soltanto di mugolii per esprimere le inquietudini e le estasi della nostra anima. In principio fu il Verbo».



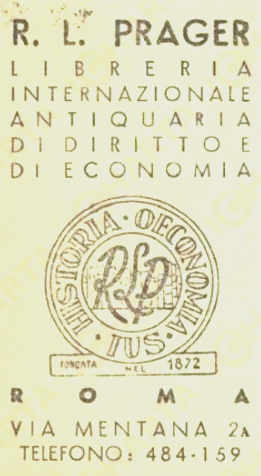 Werner Prager, protagonista – forse inconsapevole – di questa storia libresca, nacque nel 1888 a Berlino, dal libraio Robert Ludwig (1844-1914) la cui bottega aprì nel 1872. Assieme alla moglie Gertrud, continuò a gestire la società R. L. Prager e, pensando poi di scampare ai provvedimenti antisemiti, trasferì ingenuamente l’attività da Amsterdam a Roma nel 1937, ovvero solo un anno prima della promulgazione delle
Werner Prager, protagonista – forse inconsapevole – di questa storia libresca, nacque nel 1888 a Berlino, dal libraio Robert Ludwig (1844-1914) la cui bottega aprì nel 1872. Assieme alla moglie Gertrud, continuò a gestire la società R. L. Prager e, pensando poi di scampare ai provvedimenti antisemiti, trasferì ingenuamente l’attività da Amsterdam a Roma nel 1937, ovvero solo un anno prima della promulgazione delle