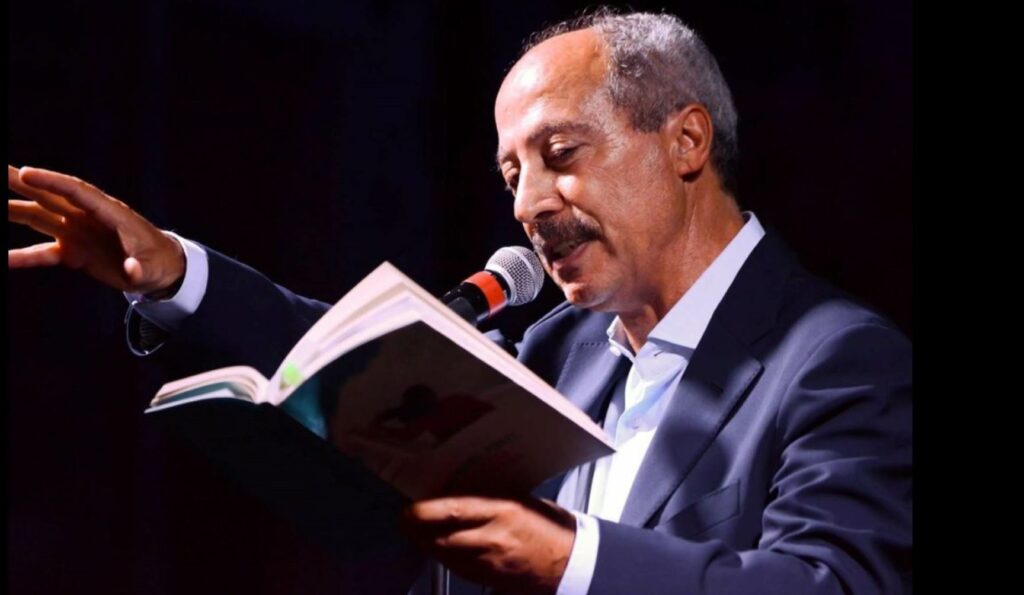Intellettuale anticonvenzionale, indipendente, unico e ineguagliabile. Cinquant’anni fa moriva Pier Paolo Pasolini, assassinato sul litorale di Ostia nella notte fra il 1° e il 2 novembre 1975. Un poeta, giornalista, regista e letterato che ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana del Ventesimo secolo e che ha scandagliato in profondità i tormenti, le ipocrisie, i vizi e i cambiamenti del popolo italiano.

Dai campagnoli di Casarsa ai sottoproletari delle borgate romane, fra i popoli umili che più hanno intrecciato le loro sorti al vissuto di Pasolini un posto di rilievo ha la gente di Calabria. Quello fra PPP e la Calabria è stato un rapporto burrascoso ma intenso, sviluppatosi attraverso i reportage, i film, i documentari, anche la poesia, con le parole di Profezia, componimento del ’64 poi diffuso col titolo Alì dagli occhi azzurri, che anticipò il dramma dei migranti nel Mediterraneo e in particolare lungo le coste calabresi.
“Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci,
asiatici, e di camicie americane.
Subito i Calabresi diranno,
come malandrini a malandrini:
‘Ecco i vecchi fratelli,
coi figli e il pane e formaggio!’”
Pasolini in Calabria: banditi a Cutro
La complessità del legame fra Pasolini e la Calabria si fonda sul caso scoppiato lungo il vespro dell’estate del 1959, a seguito della pubblicazione – il 5 settembre – della terza e ultima parte di un reportage in Italia, da Ventimiglia a Pachino, da Reggio Calabria – luogo in cui, scrive, gli piacerebbe «vivere e morirci, non di pace, […] ma di gioia» – a Trieste, che Pier Paolo Pasolini confezionò, con gli scatti del fotografo Paolo di Paolo, per la rivista Successo. La parte conclusiva del documentario dal titolo La lunga strada di sabbia si concentrava sulla risalita della Penisola, dallo Jonio calabrese all’Adriatico, tragitto durante il quale il poeta passò, fugacemente, a bordo della sua Millecento a quattro cilindri, da Cutro, paesino immerso in un paesaggio bucolico di calanchi oggi in territorio di Crotone, al tempo rientrante nella provincia di Catanzaro.
Parliamo della famosa polemica dei banditi – così come Pasolini appellò la gente di Cutro –, cavalcata dalla pubblicistica locale e dal governo democristiano di Cutro con a capo il sindaco Vincenzo Mancuso.
«Lo vedo correndo in macchina: ma è il luogo che più mi impressiona di tutto il lungo viaggio. È, veramente, il paese dei banditi, come si vede in certi westerns. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi. Si sente, non so da cosa, che siamo fuori dalla legge, o, se non dalla legge, dalla cultura del nostro mondo, a un altro livello. Nel sorriso dei giovani che tornano dal lavoro atroce, c’è un guizzo di troppa libertà, quasi di pazzia».
Premi e polemiche
Alla diffusione di queste pagine, sulla stampa calabrese si scatenò un’isteria collettiva. L’intellettuale corsaro provò, a suo modo, a chiudere la questione con una replica, uscita il 28 ottobre su Paese Sera. Un passaggio della Lettera sulla Calabria sosteneva che «la storia della Calabria implica necessariamente il banditismo: se da due millenni essa è una terra dominata, sottogovernata, depressa». Ma la querelle proseguì, raggiungendo il picco poche settimane dopo, a metà novembre, quando PPP ricevette a Crotone – città in contrasto politico con la vicina Cutro considerata l’amministrazione di colore rosso, retta dal primo cittadino comunista Vincenzo Corigliano – il prestigioso Premio Crotone per il suo romanzo Una vita violenta. «Il Premio Crotone assegnato a chi ha offeso senza alcun ritegno l’onorabilità della cittadina crotonese e di Cutro» metteva nero su bianco, indignato, Il Messaggero della Calabria.

Il dottor Pasquale Nicolini
È una vicenda famosa, di cui si è scritto molto. Poco tramandato è invece uno scambio di lettere, avvenuto a cavallo fra l’uscita del resoconto incriminato e la consegna contestata del Premio Crotone all’autore, fra Pasolini e un medico calabrese.
È il 26 settembre 1959 quando dalla Calabria parte una raccomandata. A firmarla è un dottore, ufficiale sanitario di Paola, Pasquale Nicolini.
Vicino agli ultimi, ai più deboli, Nicolini era quello che oggi definiremmo un attivista. L’uomo si impegnava a promuovere il diritto alla salute per le famiglie meno abbienti e per la costruzione di abitazioni moderne, che strappassero le genti più povere della cittadina tirrenica dalle loro casupole malsane e lesionate a seguito dei bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale – lascito di quegli orrori della guerra che il dottor Nicolini aveva sperimentato negli ospedali militari.
L’uomo possedeva anche una profonda cultura umanistica, amava discettare di filosofia e letteratura e non disdegnava di comporre poesie dedicate alla sua terra. Interessatosi chiaramente alla controversia scoppiata a seguito delle parole di Pasolini sulle pagine di Successo, il dottor Pasquale Nicolini pensò dunque di scrivere, con la cortesia e l’acume che lo distinguevano, una lettera privata al poeta.
Di seguito, estratti della missiva, pubblicata il 23 luglio 2012 da Roberto Losso, giornalista scomparso nel 2023, sulle colonne del Quotidiano della Calabria:
Una lettera per confrontarsi
«Al signor Pier Paolo Pasolini, il suo resoconto La lunga striscia di sabbia, pubblicato nel numero di settembre di Successo, ha suscitato in Calabria un’ondata di risentimento, invero molto giustificato, del quale non so se l’è giunta l’eco. Io preferisco scriverle personalmente, anche perché voglio aver la certezza ch’ella conosca il mio pensiero: sarò franco e sereno, e le sarò molto grato se vorrà rispondermi con uguale franchezza e serenità. Chi sa che non si possa giungere alla comprensione e… alla distensione! Molte volte si grava l’animo di rancori per interpretazioni errate o perché si va più in là delle intenzioni altrui. Non è così?
Ella, dunque, percorrendo la ‘lunga strada di sabbia’ della nostra Penisola, ha dato un fugacissimo sguardo alla costiera calabra e ne ha tratto delle conclusioni che certamente non ci fanno onore. Che il suo sguardo sia stato fugacissimo è provato dalla celerità con cui ha percorso detta strada».
Pasolini tra le braccia di Morfeo?
«Verrebbe addirittura da pensare che da Maratea (che è in Lucania) a Reggio Calabria abbia viaggiato in ‘turboreattore’, se neppure si è accorto delle belle scogliere di Praia e Scalea, del paradiso di Cirella di Diamante piena di sole, di Belvedere e della sua Rosanville, di Cittadella del Capo semplice e romantica, della mia Paola panoramica e mistica, dello sperone di Tropea, di Bagnara, di Scilla. Ovvero – lo confessi! – nel tratto calabro-tirrenico, vinto dalla stanchezza, ha ceduto il volante al suo fotoreporter e si è accoccolato nelle braccia del buon Morfeo?».
«Così ella ha potuto dare una occhiata di scorcio solo a Reggio ed al resto del litorale jonico. Ma tanto è bastato per farle osservare che Reggio è città estremamente drammatica e originale, di un’angosciosa povertà, dove, sui camion che passano per le lunghe strade parallele al mare, si vedono scritte come “Dio, aiutaci”, che Cutro è veramente il paese dei banditi come si vede in certi westerns (ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi); che ivi si sente che siamo fuori dalla legge o, se non dalla legge, dalla cultura del nostro mondo, ad un altro livello…» […]
Povera ma bella
«E finalmente, uscendo dal Sud, ha sentito di qualificarlo ‘carfaneo sterminato, brulichio di miseri, di ladri, di affamati, di sensuali, pura e oscura riserva di vita’. Ma come ha potuto, signor Pasolini, emettere di tali giudizi sulla base di un rapido colpo d’occhio? Perché, guardi, la Calabria è veramente e dolorosamente povera e depressa, ma che, dai nostri camion gridi la sua invocazione a Dio per non perire, questo no! Anche perché è nella natura di noi calabresi un senso d’orgoglio, direi, smisurato (usi a soffrir tacendo)».

«Ed ora mi levi una curiosità: da che cosa ha potuto dedurre che Cutro è il paese dei banditi? […] Strano, poi, che proprio ivi, in vicinanza di Crotone, dove ancora splendono i fasti della Scuola Pitagorica, si sia sentito fuori dalla legge e dalla cultura del suo mondo (ch’è pure mondo d’alto livello). Strano davvero, perché c’è chi, nelle notti lunari, vede ancora aggirarsi, nei pressi della colonna di Hera Lacinia, le ombre del grande saggio e dei suo discepoli che vanno irrequiete dietro l’assillo di intendere le leggi, l’ordine e l’armonia totale dell’Universo. Ritorni per davvero, signor Pasolini, nella nostra povera ma bella e generosa Calabria. A Paola sarà mio gradito ospite.»[…]
«Sono certo che si ricrederà di molte cose e che non dirà più di noi che siamo un brulichio di miseri e di ladri, e che qua tutto è essenza negativa. Abbiamo le nostre miserie e i nostri difetti, ma abbiamo anche il nostro buon cuore, le nostre virtù e soprattutto il grande desiderio di essere considerati figli non demeriti di una madre comune».
La replica di Pasolini
Apprezzando il tono e la cultura classica espressa da Nicolini, PPP decise di rispondere. Già il 1° ottobre con la sua Olivetti 22 il poeta replicò al medico calabrese. Riportiamo alcuni lacerti della risposta:
«Gentile dottor Nicolini, devo dirle anzitutto: i banditi mi sono molto simpatici, ho sempre tenuto, fin da bambino, per i banditi contro i poliziotti e i benpensanti. Quindi, da parte mia, non c’era la minima intenzione di offendere i calabresi e Cutro. Comunque, non so tirare pietosi veli sulla realtà: e anche se i banditi li avessi odiati, non avrei potuto fare a meno di dire che Cutro è una zona pericolosa, ancora in parte fuori legge: tanto è vero che i calabresi stessi, della zona, consigliano di non passare per quelle famose ‘dune giallastre’ durante la notte.» […]
«E quanto ai ladri, infine: non mi riferivo particolarmente alla Calabria, ma a tutto il Sud. Sono stato derubato tre volte: a Catania, a Taranto e a Brindisi (sempre nelle cabine delle spiagge). In Calabria ho avuto una rapina a mano armata (di coltello): a cui sono sfuggito solo per la mia presenza di spirito. Queste cose ovviamente non le ho scritte, non solo per senso della litote, ma per non mettere nei guai i miei ladri e i miei rapinatori, che continuano ad essermi simpaticissimi (solo a Taranto, per colpa del bagnino, è intervenuta la polizia: ma io non ho voluto fare la denuncia contro il povero ladruncolo subito ritrovato)».
Manie di persecuzione, lotta e realtà
«Questi sono dati della vostra realtà: se poi volete fare come gli struzzi, affar vostro. Ma io ve ne sconsiglio. Non è con la retorica che si progredisce. Tutto questo lo dico a lei, perché mi sembra una persona veramente buona e simpatica». […]
“Mi dispiace dell’equivoco: non si tiene mai abbastanza conto del vostro ‘complesso di inferiorità’, della vostra psicologia patologica (adesso non si offenda un’altra volta!), della vostra collettiva angesi, o mania di persecuzione. Tutto ciò è storicamente e socialmente giustificato.
E io non vi consiglierei di cercare consolazioni in un passato idealizzato e definitivamente remoto: l’unico modo per consolarsi è lottare, e per lottare bisogna guardare in faccia la realtà. Mostri pure questa lettera ai suoi amici, la renda pubblica, magari la faccia anche stampare sui giornali che hanno polemizzato contro di me. Sono certo che sarò capito. Le ripeto: lei è persona degna di ogni rispetto e anche affetto, e, come tale, cordialmente la saluto, suo devotissimo Pier Paolo Pasolini».
Pasolini torna in Calabria
Il carteggio non fu divulgato, come esortato dallo stesso Pasolini. «Persona degna di ogni rispetto e anche affetto», il dottor Nicolini lasciò la preziosa corrispondenza nel cassetto, lontana dalle grinfie di cercatori di scoop e fomentatori della diatriba.
La polemica si affievolì presto e, trascorsi alcuni anni, Pasolini ritornò in Calabria. Il rapporto con la regione, terra genuina, reale, trascurata e anarchica quanto bastava per non essere stata ancora corrotta dalla omologazione e dalle brutture conformistiche imposte dalla modernità, da quel “genocidio culturale” inflitto agli italiani, proseguì raggiungendo l’acme nel ’63-’64 con le riprese del Vangelo secondo Matteo.

Il poeta e regista, deluso dalle trasformazioni del paesaggio avvenute in Medio Oriente, scelse di girare in diversi luoghi rupestri del Meridione, fra cui le calabresi Le Castella e Cutro, panorami «ferocemente antichi», scampati al disastro «economico, ecologico, urbanistico, antropologico» del tempo, che meglio potevano ricordare la Terra Santa di duemila anni prima.
E il colto dottor Pasquale Nicolini? Voci perpetuate nei decenni vogliono che Pasolini abbia incontrato, negli anni successivi a quella turbolenta seconda metà del 1959, quel medico intellettuale paolano che aveva avuto l’ardire di scrivergli direttamente per metterlo a parte del suo pensiero e per avere un confronto, e che grazie all’educazione e all’accesa passione per le proprie radici si era meritato non soltanto la risposta, ma pure la stima di uno dei massimi pensatori del Novecento.
Voci, indiscrezioni mai confermate che nulla tolgono a una corrispondenza preziosa, tassello importante per ricostruire il rapporto tormentato e ricco di fascino fra Pasolini e la nostra terra.