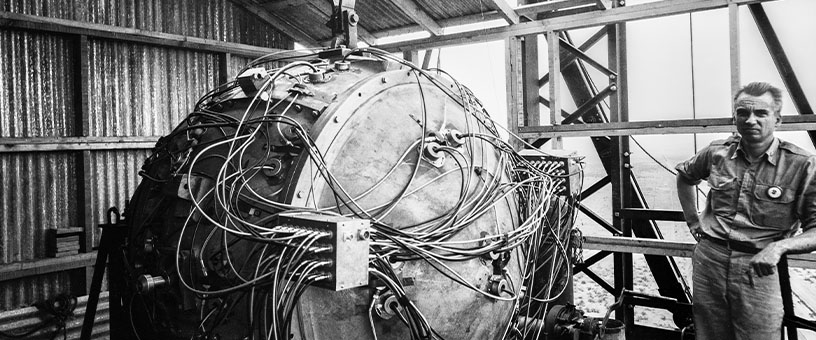«Ci vediamo tra due sigarette». Quelle che Paolo Virno avrebbe fumato nell’intervallo tra la prima e la seconda ora di lezione all’Università della Calabria. Il prof ci ha lasciati a 73 anni. Ricordo bene la forza del suo insegnamento e quei pomeriggi passati ad ascoltarlo e prendere appunti seduto tra i banchi del cubo 28C. Ho fatto parte pure io della cantera di FSCC (Filosofia e scienze delle comunicazione e delle conoscenza) un po’ di anni fa, il nostro cubo di riferimento era il 18 C.
A distanza di tempo rileggo quegli appunti e trovo sempre quella circolarità e quella quadratura delle sue lezioni, simili a certe partiture geometriche di Bach. Ah, Bach, Virno lo chiama in causa quando parla dell’attività senza opera (autotelica) di Aristotele nelle mani del pianista “artista esecutore” Glenn Gould, quello delle Variazioni Goldberg. Il prof poi spiegava l’altra faccia di questa medaglia, la creatività che cambia le regole (Chomsky), l’azione trasformativa rintracciata nel Saggio sul motto di spirito di Freud.
PAOLO VIRNO, IL VOCABOLARIO DELLA “MOLTITUDINE”
Virno aveva una potenza intellettuale notevole. Tutto compresso in quel gigante magro con il viso scavato e gli occhi azzurri, lo sguardo malinconico di uno che ne ha viste tante; troppe. Compresa la militanza politica in Potere operaio, le accuse, il carcere e poi l’assoluzione. Ha condiviso la voglia di leggere nelle contraddizioni del capitalismo con autori, alcuni anche suoi amici, come Toni Negri. Lo ha fatto cogliendo i fiori di pensatori fuori dagli schemi come Baruk Spinoza e in quella sua “moltitudine”, parola con dentro un mondo che ha alimentato il vocabolario del Movimento. Da leggere, tra i suoi libri, proprio “Grammatica della moltitudine” (DeriveApprodi 2014).
I PARADOSSI DI PAOLO VIRNO
Inconfondibile quel suo accartocciare la mano, quasi volesse trattenere i concetti. Ha lasciato una traccia importante all’Università della Calabria per poi passare all’Università Roma Tre. Amante di paradossi (in greco parà-doxa cioè contro l’opinione comune) – spiegati da Zenone a Russell -, non fu da meno quando un giorno iniziò un suo corso con una delle sue frasi memorabili: «Parleremo di un Marx anti-marxista». Noi tutti spiazzati, ci guardavamo disorientati. Poi capimmo il perché. Eravamo abituati al materialismo dialettico, ma ci eravamo persi il gran finale dell’autore dei “Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica”.
Scoprimmo con Virno che Marx aveva intuito perfettamente cosa sarebbe successo a ridosso dei nostri anni: il Capitale va oltre la tipica e violenta aggressione al lavoro, salario, risparmio. Il suo obiettivo più ambizioso e subdolo resta la natura umana, la creatività. E la natura umana è quella che i greci chiamavano logos, pensiero e linguaggio. Eccolo, il linguaggio azzannato dove Virno incollava il nuovo fordismo dei call center. Io le ricordo ancora quelle lezioni: dal Frammento sulle macchine (che già a evocarlo sembra esserci una sorta di mistica) alla dimensione transindividuale, al General intellect.
Virno non si è mai sottratto a dare il suo contributo. Nei suoi libri, nelle conferenze, nelle pagine scritte per Il Manifesto dove di tanto in tanto rincontravo le sue parole. Oggi quelle parole mancheranno un po’ a tutti noi del cubo 18 C.
Alfonso Bombini